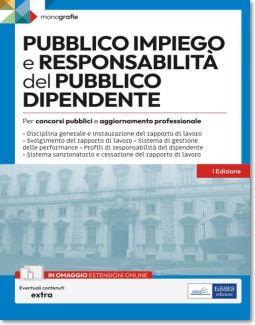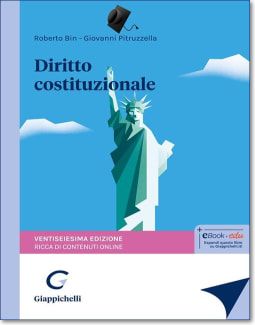Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 28 ottobre 2021, n. 5536
Presidente: Fidelbo - Estensore: Silvestri
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza con cui Z. Luisa, P. Ivan e B. Corrado sono stati condannati per il reato previsto dall'art. 353-bis c.p.
Z., quale dirigente dell'Agenzia unica emergenza presso il Dipartimento protezione della Provincia autonoma di Trento, e P. Ivan, quale dirigente responsabile dell'associazione Trento Rise, ente in forma associata costituito da due enti pubblici, avrebbero turbato, al fine di condizionare la scelta del contraente e favorire l'impresa individuale Ice e Fire, di cui B. Claudio era titolare, il procedimento diretto alla stipula del contratto riguardante la realizzazione e posa in opera di un sistema di sicurezza - ideato in occasione dello svolgimento a Trento delle Universiadi nel 2013 - intercorso tra la Trento Rise e l'impresa di B. per un complessivo importo di 380.000 euro. Ciò sarebbe stato compiuto con collusioni e mezzi fraudolenti consistenti: a) nella scelta, previamente concertata tra i tre imputati, di affidamento dell'incarico alla Ice e Fire; b) nella descrizione delle prestazioni sulla base delle indicazioni e del previo concerto con l'impresa; c) nella esclusione di forme di pubblicità o richiesta di offerta o partecipazione alla fase negoziale di altri possibili concorrenti; d) nella artata configurazione di una situazione di urgenza, al fine di fare riferimento ad una procedura di individuazione del contraente illegittima, perché violativa delle disposizione del d.lgs. n. 163 del 2006 all'epoca vigente in quanto si procedeva ad affidamento diretto - trattativa privata - laddove invece sarebbe stato necessario procedere alla pubblicazione di un bando di gara o comunque con richieste di offerte a più concorrenti da individuarsi secondo criteri oggettivi.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Luisa Z. articolando cinque motivi, sviluppati sulla base di una premessa critica nei riguardi delle sentenze di merito ed alla struttura di una fattispecie, quella prevista dall'alt 353-bis c.p., costruita, si sostiene, su elementi di analogia implicita.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità; il tema attiene alla omessa indicazione nel decreto di giudizio immediato dell'avviso della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168-bis c.p., e alla nullità derivante dalla sentenza n. 19 del 2020 della Corte costituzionale.
Sarebbero viziati gli assunti del giudice di appello secondo cui l'eccezione di nullità sollevata dall'imputata sarebbe stata, da una parte, generica, e, dall'altra, tardiva perché dedotta all'udienza del 9 giugno 2020 davanti al Tribunale e non nell'udienza immediatamente successiva alla data della decisione della Corte costituzionale; secondo la Corte di appello sarebbe comunque dirimente, ai fini della questione dedotta, il rilievo per cui, trattandosi di norma processuale, gli effetti della pronuncia di incostituzionalità della norma non retroagirebbero, atteso il principio del tempus regit actum.
Secondo invece i difensori:
- quanto alla genericità della eccezione, questa in realtà sarebbe stata sviluppata in uno specifico paragrafo dell'atto di appello, che si allega al ricorso (pag. 37, atto di appello);
- quanto alla assunta tardività, la nullità in questione sarebbe a regime intermedio e si richiama una parte della motivazione della sentenza delle Sezioni unite n. 5396 del 2015 "Bianchi" (Rv. 263023) secondo cui, nel caso in cui la nullità di un atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, la sua deducibilità da parte dell'indagato o dell'imputato che non vi abbia assistito non è soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p. Nel caso di specie, la parte non avrebbe assistito all'atto e dunque, in applicazione dell'art. 180 c.p.p., la nullità sarebbe stata deducibile entro la deliberazione della sentenza di primo grado;
- quanto al tema degli effetti della sentenza della Corte ed al carattere processuale della norma, si evidenzia come la declaratoria di illegittimità costituzionale abbia effetti ex tunc, elidendo dall'origine la norma viziata.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di reato; il tema riguarda l'affermazione della Corte secondo cui il delitto sarebbe configurabile anche nei casi in cui la deliberazione a contrarre, per effetto della turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara bensì l'affidamento diretto; una interpretazione secondo la Corte di appello "di segno ampio e conforme alla ratio legis" ed espressione di una giurisprudenza maggioritaria.
La questione, si argomenta, attiene a se la fattispecie di cui all'art 353-bis c.p. sia configurabile anche nei casi in cui non vi sia un bando di gara e le opere siano aggiudicate in affidamento diretto, ed attiene alla definizione del sintagma "altro atto equipollente" contenuto nella norma incriminatrice.
La tesi difensiva è che dovrebbe invece essere privilegiata una interpretazione della norma tassativizzante, rigorosa, scevra da tentazioni di interpretazioni analogiche in malam partem, ossequiosa del principio di sussidiarietà dell'intervento penale.
La fattispecie dovrebbe essere ricostruita nel senso di ritenere necessaria la esistenza di procedure selettive che implichino una pluralità di potenziali contraenti in una dimensione concorrenziale; ciò nella specie non si sarebbe verificato, attesa la inesistenza di un bando, di una gara, di una valutazione comparativa di posizioni.
In tal senso si richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione, negando che sulla questione vi sia un effettivo contrasto di indirizzi e si chiede, nel caso in cui si ritenesse esistente l'ipotizzato contrasto, la rimessione della questione alle Sezioni unite.
I fatti in esame, si aggiunge, non sarebbero riconducibili né alla fattispecie invocata e neppure a quella di cui all'art. 353 c.p., atteso il consolidato orientamento secondo cui detto reato non sussisterebbe in relazione a condotte, come nel caso di specie, tenute prima che la procedura di gara abbia inizio.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale "al più" escluso la riqualificazione dei fatti e la loro riconducibilità al reato di abuso d'ufficio.
L'assunto è che nella specie, comunque, non sarebbe configurabile in concreto nemmeno il reato previsto dall'art. 323 c.p., attesa l'inesistenza del requisito strutturale della violazione di legge.
Secondo l'imputata l'urgenza sarebbe stata effettiva, atteso che le Universiadi furono assegnate a Trento dopo la rinuncia di altre sedi - a meno di un anno dal loro svolgimento - e che, in relazione ad un evento di amplissime dimensioni che coinvolgeva 52 paesi stranieri, il problema si pose solo dal luglio del 2013.
Si aggiunge che in ogni caso la valutazione sulla sussistenza della urgenza costituirebbe una valutazione tipicamente discrezionale ormai priva di rilievo penale ai sensi della nuova dizione dell'art. 323 c.p.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità a titolo concorsuale dell'imputata e, in particolare, alla sua partecipazione all'accordo collusivo intervenuto il 23 maggio 2013.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non vi sarebbe prova che in occasione dell'incontro del 23 maggio 2013 si sia parlato tra gli imputati del problema della sicurezza delle Universiadi.
Sul punto, il ragionamento indiziario sarebbe viziato e sarebbe fondato solo su una mail spedita a P. da un collaboratore di B. (tale S.) il 9 luglio 2013 con cui questi trasmise una bozza di protocollo delle Universiadi che aveva come data di formazione del documento quella del 17 maggio del 2013.
Si evidenzia come: a) quella bozza sarebbe stata reperita dagli inquirenti su siti aperti al pubblico; b) non sarebbe stato accertato quando S. avrebbe "scaricato" quel documento; c) si tratterebbe di un unico indizio, né grave né preciso.
La Corte inoltre avrebbe omesso di valutare altre mail che spiegherebbero il contenuto dell'incontro del 23 maggio 2021.
2.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.
3. Ha proposto ricorso per cassazione B. Corrado articolando quattro motivi.
3.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità. Il tema attiene alla notifica della citazione in giudizio in appello; B. in sede di interrogatorio aveva eletto domicilio presso la propria impresa in via [omissis], ma la citazione sarebbe stata notificata il 24 dicembre 2021 alla moglie convivente, senza peraltro indicare nella relata di notifica né il luogo di consegna, né le ricerche compiute per effettuare la comunicazione.
La nullità sarebbe stata dedotta all'udienza del 15 gennaio 2021 ma la Corte avrebbe ritenuto l'eccezione infondata sul presupposto che l'atto fosse stato consegnato alla moglie, che nulla aveva eccepito.
La notifica dell'atto a mani di B., ovvero nel luogo di elezione di domicilio, non sarebbe stata neppure tentata.
3.2. Il secondo motivo attiene all'omesso avviso nel decreto di giudizio immediato della facoltà di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova: il tema è quello già descritto.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie contestata nel caso di affidamento diretto.
3.4. Con il quarto si deduce vizio di motivazione quanto alla prova della esistenza di un accordo collusivo.
4. Ha proposto ricorso per cassazione P. Ivan articolando cinque motivi.
4.1. Con il primo si deduce violazione di norma processuale prevista a pena di nullità; il tema attiene anche in questo caso alla notifica del decreto di citazione in appello.
La Corte di appello all'udienza del 23 dicembre 2020, rilevata la intervenuta dichiarazione di domicilio in via [omissis] e la nullità della precedente notifica, aveva disposto la rinnovazione della notificazione del decreto a mani proprie dell'imputato; l'atto sarebbe stato tuttavia notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore.
Alla successiva udienza, si argomenta, la Corte aveva rigettato l'eccezione di nullità sul presupposto che l'imputato e i di lui familiari non fossero stati reperiti presso la sua abitazione.
Secondo il difensore la notifica sarebbe nulla, oltre che per il differente modulo procedimentale comunicativo seguito rispetto a quello indicato dalla Corte - che, come detto, aveva disposto la notifica a mani - perché non sarebbe stata indicata la ragione che aveva reso impossibile la notifica presso il domicilio e neppure quali ricerche nella specie sarebbero state compiute.
Si assume che sarebbe assente una relata di notifica negativa, quella cioè riguardante l'impossibilità di comunicare l'atto presso il domicilio eletto.
La tesi è che non ogni assenza legittimerebbe la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., che sarebbe legittima solo in caso di assenza "tendenzialmente definitiva" e per così dire qualificata (così il ricorso).
4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità; il tema attiene alla comunicazione dell'avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova.
4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto alla sussistenza degli elementi strutturali del reato contestato.
Il tema è quello già descritto in precedenza.
4.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un accordo collusivo.
4.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità; il tema attiene all'acquisizione - senza contraddittorio - al fascicolo del dibattimento del certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, poi utilizzati al fine della determinazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati quanto ai motivi, che hanno valenza assorbente per le ragioni che saranno indicate, relativi alla riconducibilità dei fatti alla fattispecie di reato contestata (secondo motivo ricorso Z., terzo motivo ricorsi B. e P.).
Il ragionamento giuridico della Corte di appello muove da un dato fattuale costitutivo, e cioè che la Trento Rice, al fine di eludere l'obbligo di indire una gara, abbia illegittimamente affidato le opere direttamente all'impresa di Corrado B., sulla base di una inesistente ragione di urgenza.
La prospettazione di una falsa situazione di urgenza avrebbe dunque consentito di addivenire alla stipula del contratto con la impresa di B. senza procedere alla pubblicazione di un bando di gara e comunque senza compiere una procedura selettiva.
Il delitto previsto dall'art. 353-bis c.p., argomenta la Corte di appello, sarebbe configurabile anche nei casi, come quello in esame, in cui la condotta perturbatrice sia finalizzata non a turbare ma ad evitare la gara, consentendo l'affidamento diretto in assenza delle condizioni previsti dalla legge.
2. La disposizione normativa di cui all'art. 353-bis c.p. è stata introdotta dal legislatore con l'art. 10 della l. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) con l'obiettivo di sterilizzare le condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara, così da arginare i possibili vuoti di tutela che la disposizione di cui all'art. 353 c.p. aveva creato anche a seguito di indirizzi giurisprudenziali secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti, anche sub specie di tentativo, non sarebbe configurabile nei casi in cui alla commissione di una delle condotte ivi enucleate non faccia seguito la pubblicazione del bando di gara e, quindi, il formale avvio della stessa procedura selettiva (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 26556 del 13 aprile 2021, Giamogante, Rv. 281470).
Come si legge nei lavori preparatori, con il reato in questione sarebbe stato colmato un vuoto di tutela.
La ratio della norma è normalmente individuata nella esigenza di anticipare la tutela penale, rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara; la norma, si sostiene, mira a prevenire la preparazione e l'approvazione di bandi personalizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ed a preservare il principio di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione.
La disposizione è concepita per punire contegni orientati a favorire taluno degli interessati alla commessa a scapito di altri e, più esattamente, a conculcare la parità tra i concorrenti e la libera dialettica economica, ponendosi, dunque, al servizio della libertà di concorrenza intesa quale bene funzionale ad assicurare ai pubblici poteri l'individuazione del migliore offerente.
Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando, in ciò consumandosi il suo turbamento.
Non è necessario cioè che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, venga effettivamente inquinato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 29267 del 5 aprile 2018, Baccari, Rv. 273449; Sez. 6, n. 1 del 2 dicembre 2014, dep. 2015, Pedrotti, Rv. 262917).
Le condotte dirette ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, o dell'atto ad esso equipollente, assumono rilevanza a condizione che l'organo o l'ente pubblico abbia in essere un procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, che cioè vi sia una procedura amministrativa finalizzata alla gara, alla predisposizione di un bando o di un atto ad esso equipollente (Sez. 6, n. 26840 del 14 aprile 2015, Boschi, Rv. 263834).
3. In tale contesto si pone la questione del se il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sia configurabile anche quando, come nel caso di specie, la condotta perturbatrice non sia finalizzata ad inquinare lo sviluppo di una procedura selettiva, ma ad evitare la gara e a consentire l'affidamento diretto in assenza delle condizioni previste dalla legge.
Il tema attiene alla esatta individuazione del tipo e dell'ambito del procedimento amministrativo, nonché alla interpretazione del sintagma "contenuto del bando e di altro atto equipollente" di cui alla norma incriminatrice prevista dall'art. 353-bis c.p.
3.1. Secondo una prima opzione interpretativa, l'art. 353-bis c.p., facendo riferimento al "contenuto del bando o di altro atto equipollente", dovrebbe essere interpretato nel senso che per "altro atto equipollente" dovrebbe intendersi "ogni atto che - così come recita la rubrica della norma - abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, venendo così in considerazione, sulla scorta di un'interpretazione di segno ampio, pienamente conforme alla ratio legis, anche la deliberazione a contrarre qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, bensì l'affidamento diretto ad un determinato soggetto economico" (così testualmente Sez. 6, n. 13431 del 16 febbraio 2017, Imperadore, Rv. 269384, in fattispecie di procedura di affidamento diretto avviata in violazione della normativa allora vigente ed in cui si valorizza anche la motivazione di Sez. 6, n. 43800 del 23 ottobre 2012, n.m., e di Sez. 6, n. 1 del 2 dicembre 2014, dep. 2015, Rv. 262917).
Il principio di diritto indicato è richiamato in senso adesivo da Sez. 6, n. 1016 del 22 ottobre 2019, dep. 2020, Del Duca, n.m., in fattispecie - del tutto sovrapponibile a quella in esame - di affidamento diretto illegittimo, perché posto in essere senza la sussistenza del requisito della somma urgenza (nello stesso senso, sempre in tema di affidamento diretto illegittimo, Sez. 6, n. 10016 del 13 febbraio 2019, Fernandez, n.m.; Sez. 6, n. 10111 del 13 febbraio 2019, Fuscaldo, n.m.).
Le decisioni in esame, ricomprendendo nella nozione di "atto equipollente" i casi in cui l'affidamento diretto sia utilizzato in maniera distorta per eludere l'indizione della gara, ritengono configurabile il reato previsto dall'art. 353-bis c.p.
Una ricostruzione che, attraverso la evocazione della eadem ratio, valorizza la necessità, da una parte, di colmare un vuoto di tutela, e, dall'altra, di attribuire rilevanza penale a condotte "sostanzialmente" sovrapponibili a quelle disciplinate dalla norma incriminatrice attraverso una interpretazione extratestuale - considerata meramente estensiva - della stessa.
3.2. Si tratta di una opzione interpretativa che non può essere condivisa e che deve essere superata.
La Corte di cassazione aveva già evidenziato che, se è vero che la selezione del contraente mediante trattativa privata può non essere preceduta da nessun confronto tra offerte antagoniste, è altrettanto vero che la legge consente di derogare al modulo generale.
Vi sono casi in cui, cioè, nonostante l'affidamento diretto, il procedimento prevede segmenti concorrenziali tra gli aspiranti che rendono omologabile la trattativa privata - perlomeno in relazione alla fase iniziale del procedimento - a una procedura di gara, considerata "ufficiosa", "informale", "esplorativa", "di sondaggio", di "consultazione".
Dunque, si era chiarito - seppur con riguardo al reato previsto dall'art. 353 c.p. - che anche la trattativa privata, se anticipata da una qualsiasi fase di preselezione competitiva delle ditte con cui contrattare, acquista l'attitudine ad essere ricondotta, in presenza di un'azione perturbatrice, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 353 c.p. (cfr. Sez. 6, n. 12238 del 30 settembre 1998, De Simone, Rv. 213033, secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile nell'ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale, a meno che la trattativa privata, al di là del nomen juris, si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale; nella specie la Corte ha precisato che ciò non integra una applicazione analogica della fattispecie criminosa - vietata in materia penale - in quanto non ne allarga l'ambito di applicazione, bensì concreta una interpretazione estensiva, sulla base dell'eadem ratio che la sorregge e che è unica, volta a garantire il regolare svolgimento sia dei pubblici incanti e delle licitazioni private sia delle gare informali o di consultazione, le quali finiscono con il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni private. In difetto, però, di una reale e libera competizione tra più concorrenti non è a parlarsi di gara, come nel caso in cui singoli potenziali contraenti, individualmente interpellati, presentino ciascuno le proprie offerte e l'amministrazione resti libera di scegliere il proprio contraente secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1412 del 23 ottobre 1998, Coccimiglio, n.m.).
L'opzione interpretativa indicata è stata successivamente ripresa e sviluppata anche con riguardo al delitto previsto dall'art. 353-bis c.p.
Si è affermato in molteplici occasioni che, ai fini della integrazione del reato, deve aversi riguardo ad ogni istituto competitivo, pregiudiziale alla perfezione di un contratto con la pubblica amministrazione, purché il suo funzionamento sia sottoposto - per volontà della stazione appaltante o per previsione legislativa - a regole, seppure meno stringenti e penetranti rispetto a quelle congenite ai pubblici incanti e alle licitazioni private, ma comunque predeterminate, alle quali i privati devono attenersi e i pubblici poteri devono adeguarsi.
Qualunque condotta tesa a interferire sulla libera concorrenza, anche se calata nell'ambito di paradigmi concorrenziali diversi, coopera alla genesi della lesione di quegli interessi posti a giustificazione della tutela penale.
Il reato è cioè configurabile in ogni situazione in cui si debba sviluppare la libera attività di concorrenza.
Le uniche situazioni che si sottraggono all'applicazione della fattispecie, spiega l'indirizzo in esame, sono quelle in cui la ricerca del contraente sia sganciata da ogni giudizio comparativo, anche di tipo informale, ed in cui, quindi, non si può riscontrare alcuna spinta "agonistica" tra le parti, venendo meno in radice la possibilità stessa che il diritto degli imprenditori a gareggiare in condizioni di parità per gli appalti pubblici subisca un nocumento (in tal senso, in particolare, Sez. 6, n. 57000 del 6 dicembre 2018, Caruso, n.m., in cui la Corte ha escluso il reato previsto dall'art. 353-bis c.p. in fattispecie di affidamento di un servizio legittimamente disposto in via diretta e senza gara in cui all'indagato si contestava di avere sottoscritto la delibera di affidamento temporaneo, nella consapevolezza di irregolarità documentali e di accordi collusivi tra altri pubblici amministratori ed i privati interessati; nello stesso senso, Sez. 6, n. 44700 del 13 luglio 2021, Giunchiglia, Rv. 282289, secondo cui costituiscono "atti equipollenti" al bando di gara l'avviso con il quale, nella procedura contrattuale di pre-commerciai procurement, si dà inizio alla fase di ricerca e scelta del contraente, nonché l'allegato tecnico descrittivo del contenuto del futuro contratto; Sez. 5, n. 25290 del 2 marzo 2021, De Martino, n.m.; Sez. 6, n. 6603 del 5 novembre 2020, dep. 2021, Maroni, Rv. 280836, in tema di turbata libertà degli incanti; Sez. 6, n. 30730 del 28 marzo 2018, C., n.m.; Sez. 6, n. 36806 del 6 aprile 2018, Gatta, n.m.; Sez. 6, n. 36065 del 26 giugno 2018, Santoro, n.m.; Sez. 6, n. 9385 del 13 aprile 2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227; Sez. 6, n. 8044 del 21 gennaio 2016, Cerada, Rv. 266118; Sez. 6, n. 29581 del 24 maggio 2011, Tatò, Rv. 250732; Sez. 6, n. 13124 del 28 gennaio 2008, Mancianti, Rv. 239314).
Secondo l'opzione interpretativa in esame, dunque, in presenza di una condotta perturbatrice, la trattativa privata ed il conseguente legittimo affidamento diretto delle opere, se non anticipata da un segmento procedimentale di valutazione concorsuale, non consente di ritenere configurabile il delitto previsto dall'art. 353-bis c.p.
3.3. In tale articolato quadro di riferimento si pone la questione specifica già in precedenza indicata: se, cioè, il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contrante sia configurabile in presenza di un affidamento diretto illegittimamente disposto per effetto della condotta perturbatrice volta ad impedire la gara.
A differenza di quanto previsto dall'art. 353 c.p., in cui l'evento naturalistico del reato è costituito in via alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, l'art. 353-bis fa riferimento al solo turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando - o di un altro atto a questo equipollente - e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente.
La norma incriminatrice richiede sul piano della tipicità un'azione finalizzata ad inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo.
La condotta perturbatrice deve quindi riguardare un procedimento amministrativo funzionale ad una "gara", nel senso in precedenza indicato, e deve volgere sul piano finalistico ad inquinare il contenuto di un atto funzionalmente tipico, cioè di un atto esplicativo del modo con cui si devono selezionare i concorrenti per individuarne il migliore; un atto che pone le regole, le modalità di accesso, i criteri di selezione, che disciplini il modo con cui compiere una comparazione valutativa tra più soggetti.
Il turbamento del procedimento amministrativo si manifesta con il disturbo, l'alterazione, il condizionamento, lo sviamento del normale iter di questo in ragione della finalità di inquinamento del futuro contenuto del bando o di un atto a questo equipollente; uno sviamento volto a strumentalizzare la fissazione delle regole di partecipazione per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
Ne discende che la condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 353-bis c.p., deve innestarsi ed intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione.
Questo è il senso della norma incriminatrice nella parte in cui fa riferimento ad un atto equipollente al bando; deve trattarsi del contenuto di un atto che assolva la stessa funzione del bando.
Rispetto al dato letterale della norma incriminatrice, non sono dunque condivisibili torsioni interpretative volte a conformare il dato testuale per attribuirgli un significato ulteriore, distinto e più ampio, rispetto a quello desumibile dalla sua immediata lettura.
Si tratta di opzioni interpretative che finiscono per estendere l'ambito della norma incriminatrice e la tipicità della fattispecie con un procedimento analogico in malam partem in cui, attraverso considerazioni di natura teleologica, si varcano i paletti fissati dalla lettera della legge.
La condotta perturbatrice non finalizzata ad inquinare il contenuto del bando - o di un atto ad esso equipollente -, ma volta ad impedire la gara attraverso l'affidamento illegittimo diretto dei lavori, è esterna rispetto al perimetro testuale della norma.
La valorizzazione della componente finalistica, ove pure fosse realmente sottesa - come ipotizza la Corte - alla ratio della disposizione criminosa, produrrebbe una tensione con il principio di legalità perché finirebbe per introdurre un nuovo e diverso elemento di struttura (l'inquinamento del procedimento finalizzato ad evitare la gara, rispetto all'inquinamento volto a condizionare la gara) che la lettera della norma incriminatrice obiettivamente non prevede.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2021 ha nuovamente spiegato come il divieto di analogia non consenta di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo.
Si è chiarito come sia il "testo della legge - non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza - che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore".
Dunque, la stretta osservanza del principio di legalità preclude all'interprete di abbandonare il dato letterale della norma incriminatrice ed il suo significato semantico, per ricercare profili ulteriori in grado di colorare ulteriormente il perimetro dell'illecito.
3.4. Ne consegue che: "in caso di affidamento diretto, il delitto previsto dall'art. 353-bis c.p.: a) è configurabile quando la trattativa privata, al di là del nomen juris, prevede, nell'ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una "gara", sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale; b) non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il procedimento è svincolato da ogni schema concorsuale; c) non è configurabile quando la decisione di procedere all'affidamento diretto è essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara".
La questione giuridica interferisce con il profilo processuale di accertamento probatorio dei fatti.
Al di là del dato obiettivo costituito dalla conclusione di un contratto con affidamento diretto dei lavori, il giudice deve ricostruire il procedimento amministrativo, accertare come esso abbia avuto origine, quali fossero gli intendimenti della pubblica amministrazione, secondo quali sviluppi si sia addivenuti all'affidamento diretto, se il procedimento prevedesse comunque, in qualche segmento, una valutazione comparativa in funzione selettiva dei concorrenti.
3.5. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, che peraltro oggi sono espressione dell'orientamento condiviso della Sezione, emerso nel corso della riunione tenutasi, ai sensi dell'art. 47-quater r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), per superare letture disomogenee sull'art. 353-bis c.p.
Rispetto alle questioni devolute, la Corte avrebbe dovuto, da una parte, verificare se il procedimento amministrativo - per come concepito - prevedesse "una gara", e, dall'altra, posto che non la prevedesse, escludere, per le ragioni indicate, la sussistenza del reato contestato e accertare se il fatto fosse comunque sussumibile in un'altra fattispecie delittuosa.
Con una motivazione instabile e compiendo una non consentita estensione analogica della tipicità della fattispecie, si è invece erroneamente ritenuto sussistente il reato contestato per il solo fatto dell'affidamento diretto dei lavori - ritenuto illegittimo -, senza tuttavia spiegare alcunché in ordine al procedimento in cui la condotta perturbatrice si sarebbe innestata; dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato in particolare comprendere se il procedimento amministrativo - in uno dei suoi segmenti - prevedesse una qualsiasi procedura selettiva e neppure come si giunse sul piano amministrativo alla stipula di quel contratto.
Sul punto la sentenza è silente.
Né è chiaro, nel ragionamento della Corte di appello, perché, al di là di generici riferimenti valoristici, l'inquinamento finalizzato ad evitare la gara e, quindi, ad affidare le opere direttamente senza procedura di selezione dovrebbe considerarsi un elemento strutturale implicito della fattispecie di cui all'art. 353-bis c.p., in aggiunta alla condotta, invece tipicamente descritta, volta a turbare un procedimento che invece prevede una "gara".
Solo un più puntuale accertamento dei fatti avrebbe consentito di chiarire se condotte del tipo di quelle contestate agli imputati fossero sussumibili nel reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ovvero eventualmente, posto che non lo fossero, in altre fattispecie incriminatrici.
4. La sentenza, pur viziata per le ragioni indicate, deve tuttavia essere annullata non per un nuovo giudizio ma senza rinvio, essendosi il reato estinto per prescrizione.
Il delitto previsto dall'art. 353-bis c.p. è un delitto istantaneo, che si consuma nel momento e nel luogo in cui si turba il procedimento amministrativo di scelta del contraente.
Nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione d'accusa, la condotta perturbatrice sarebbe stata volta ad inquinare il procedimento che portò l'11 ottobre 2013 alla stipula del contatto tra la Trento Rise e la impresa di Corrado B.
Dunque, una condotta antecedente alla conclusione del contratto; ne consegue che, pur volendo fare riferimento alla data del contratto, il reato, in ragione del tempo di sette anni e sei mesi necessario a prescrivere e del periodo di sospensione del decorso del termine, è estinto per prescrizione.
In presenza di una causa di estinzione del reato residua il tema della possibilità di addivenire ad una pronunzia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Le Sezioni unite hanno chiarito che il giudice, ove - come nel caso in esame - non vi sia una parte civile, è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Nella specie, la possibilità di pronunciare con una operazione meramente constatativa una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste - in ragione della non riconducibilità al reato contestato della condotta attribuita ai ricorrenti - è obiettivamente condizionata dalla mancanza di un rigoroso accertamento dei fatti da cui possa escludersi che il procedimento, conclusosi con l'affidamento diretto dei lavori a B., prevedesse una fase valutativa in funzione selettiva dei possibili concorrenti.
Detto accertamento, come già detto, non solo non è stato compiuto, ma la Corte non si è nemmeno confrontata con quanto emerge dalla sentenza del Tribunale in cui, nell'ambito di una motivazione non chiarissima, si fa riferimento ad un pre-commercial procurement per le piccole e medie imprese ed alla presenza di un bando per la sicurezza "CUE Universiadi" (cfr. pagg. 6 e ss.).
Ciò impedisce di rilevare in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto.
I residui motivi dei ricorsi sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Depositata il 16 febbraio 2022.