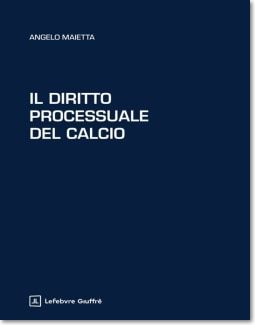Corte dei conti
Sezione I centrale d'appello
Sentenza 24 ottobre 2025, n. 154
Presidente: Lasalvia - Estensore: Petrucci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato in data 16 dicembre 2022, la Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia conveniva in giudizio il prof. Andrea B., professore ordinario di elettronica presso il Dipartimento di Fisica "G. Occhialini" dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al risarcimento del danno complessivo di euro 619.060,00, oltre interessi, rivalutazione e spese processuali, per lo svolgimento, nel periodo 2017-2020, di attività extra-professionale, in assenza dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
L'azione del Requirente contabile traeva origine dall'informativa del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano pervenuta alla competente Procura regionale il 4 marzo 2022 e che comunicava gli esiti dell'indagine, a carico dell'odierno appellato, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61, n. 2, c.p. e 3 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, aggravata dalla finalità di consentire a terzi il riciclaggio dei proventi della frode fiscale), per aver indicato, nelle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta 2017 e 2018, componenti attivi per un ammontare inferiore a quello reale compiendo operazioni soggettivamente simulate, ovvero avvalendosi di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e consistiti nell'utilizzo della società panamense Pomera Inc e del veicolo societario Sunflowers Overseas sa, allo scopo di far documentare fiscalmente le operazioni, farne incassare all'estero il corrispettivo e riottenere in contanti, al netto delle commissioni per l'illecita intermediazione, il compenso per consulenze e cessione di materiali tecnico-didattici.
Con sentenza n. 120/2023, depositata in data 6 luglio 2023, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Lombardia accoglieva integralmente la domanda attorea e condannava il prof. B. al risarcimento del danno di euro 619.060,00, già rivalutato, a favore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, oltre interessi legali e con conversione in pignoramento del sequestro conservativo autorizzato, con decreto presidenziale n. 35/2022, e parzialmente confermato, con successiva ordinanza del Giudice designato n. 70/2022.
Avverso la su richiamata sentenza n. 120/2023, con ricorso ritualmente notificato, interpone appello il prof. B. eccependo, con il primo motivo di gravame, l'insussistenza del preteso credito erariale, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010 e dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
Deduce, in particolare, la parte appellante che l'art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010 consentirebbe di svolgere senza autorizzazione l'attività di collaborazione scientifica e di consulenza richiamando, al riguardo, la norma di interpretazione autentica, dettata dall'art. 9, comma 2-ter, del d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023, intervenuta dopo l'emissione della sentenza impugnata, ma ritenuta applicabile anche alle attività svoltesi prima della sua entrata in vigore e che, ai fini della valutazione delle attività extra istituzionali, richiamerebbe unicamente i parametri dell'assenza del vincolo di subordinazione e della mancanza di un'organizzazione di mezzi e persone.
Reputa l'appellante, con riferimento a quanto osservato dalla Corte regionale in tema di comunicazione preventiva richiesta dal regolamento di Ateneo per le attività non soggette ad autorizzazione, che "la mancata comunicazione non può far diventare illecita un'attività che la legge considera lecita" e che tale previsione dovrebbe, comunque, essere disapplicata in quanto illegittima.
Lamenta, inoltre, l'appellante che la Sezione territoriale sarebbe incorsa in un grave errore per aver equiparato l'esistenza di intermediari, cui era affidato solo il compito di frapporsi rispetto ai fruitori delle prestazioni al fine di occultare al fisco la corresponsione del compenso pattuito, con l'esistenza di una stabile organizzazione preordinata allo svolgimento delle prestazioni stesse che non potrebbe, comunque, essere comprovata dall'entità del compenso.
Passando all'esame delle singole prestazioni contestate, l'appellante eccepisce che la collaborazione con il Max Planck Institute - Germania (compenso euro 184.000,00), in quanto finalizzata allo sviluppo di circuiti elettronici da utilizzare nel corso dell'esperimento Atlas (da altri condotto) presso il CERN di Ginevra, integrerebbe una "collaborazione scientifica" non soggetta a preventiva autorizzazione e che anche la collaborazione con all'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) - Svizzera (compenso euro 24.000,00) avrebbe natura scientifica, attesa la futuribilità delle applicazioni sperimentali. Invece, la collaborazione con l'Università di Pavia e la multinazionale Synaptics (compenso euro 159.800,00), finalizzata alla eventuale riprogettazione di un dispositivo elettronico commerciale (denominato "Alexa") ed i cui risultati costituirebbero oggetto di un brevetto richiesto negli USA, dovrebbe ricomprendersi nella nozione di consulenza per la rispondenza ai requisiti per il libero svolgimento.
Secondo l'appellante, sussisterebbe, poi, il carattere occasionale per l'attività seminariale a favore delle società STMicroelectronics e Pomera (compenso euro 34.800,00).
Aggiunge, poi, la parte appellante che, in merito alla collaborazione scientifica coperta da accordo di riservatezza (compenso euro 140.460,00), la Procura regionale non avrebbe fornito la prova dell'incompatibilità con la normativa di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
Quanto alla contestata cessione di documentazione tecnico-scientifica (compenso euro 124.000,00), l'appellante sostiene di non essere il docente incaricato dei corsi e che il relativo materiale non presentava contenuti originali, avendolo preparato in precedenza ed utilizzato per diversi seminari e conferenze, con conseguente esenzione da autorizzazione, trattandosi di cessione di opere dell'ingegno.
Secondo l'appellante, i compensi per le predette prestazioni andrebbero rettificati da euro 619.060,00 a euro 543.060,00 e, in ogni caso, stante il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria, "ogni e qualsivoglia obbligazione tributaria derivante dalla corresponsione di quei compensi" si sarebbe "irrecuperabilmente estinta".
Con il secondo motivo di impugnazione, la parte appellante si duole per violazione dell'art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20/1994 e per carente ed erronea motivazione della sentenza su questione prospettata dal convenuto.
Lamenta, in particolare, l'appellante che dalla relazione del direttore del Dipartimento universitario di appartenenza, depositata nel giudizio di primo grado, emergevano i contratti di finanziamento alla ricerca, per euro 4.469.100,00 circa, che non sarebbero stati stipulati dall'Università di Milano - Bicocca senza il suo intervento dovendosi, quindi, tener conto del vantaggio conseguito dall'Ateneo per effetto del contratto di euro 200.000,00 con il Max Plank Institute, poi, rinnovato per analogo importo, nonché dell'ulteriore contratto di euro 165.000,00 con la ditta icAlps e del finanziamento di euro 555.000,00 ottenuto "nell'ambito del partenariato in Quantum Computing".
Ad avviso dell'appellante, non potrebbe condividersi l'assunto della sentenza impugnata secondo cui l'ottenimento di finanziamenti per progetti di ricerca rientrerebbe nelle attività riconducibili ai doveri istituzionali del docente posto che, se esistente, tale dovere contrasterebbe con il principio di libertà della ricerca.
Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante lamenta, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, per violazione dell'art. 36, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede che l'obbligo di riversamento sia limitato a quanto eccede il giusto compenso del responsabile per l'attività lavorativa svolta.
In conclusione, l'appellante chiede, in via principale, di riformare ed annullare la sentenza gravata; in via subordinata, qualora sia ravvisata la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, di azzerarne o ridurne l'importo in applicazione art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20/1994 ed in via, ulteriormente subordinata, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. In ogni caso, l'appellante chiede che sia ordinata la cancellazione o corrispondente riduzione del pignoramento trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
Con memoria depositata in data 17 luglio 2025, l'appellante ha richiamato la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2025/QM/PROC nella parte in cui affermerebbe la natura interpretativa e, quindi, retroattiva dell'art. 9, comma 2-ter, del d.l. n. 44/2023.
L'appellante aggiunge, inoltre, che i compensi percepiti risulterebbero in linea con gli standard di mercato, come emergerebbe da recenti contratti depositati agli atti e che la condanna, statuita in primo grado, non ricomprenderebbe i compensi percepiti da Infineon, come peraltro, desumibile, dalle contestazioni attoree.
Con memoria depositata in data 28 luglio 2025, ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale precisando, dopo aver segnalato la presenza della sentenza penale gravante sull'appellante e l'irrogazione di una sanzione disciplinare, che la norma introdotta nel 2023, in tema di attività consulenziale, non potrebbe condurre all'effetto di liberalizzare qualsiasi attività professionale extra-lavorativa svolta dai docenti universitari, non potendo ritenersi consentito, sotto ogni profilo sostanziale (e in disparte il problema fiscale), "il comportamento del docente universitario che si costruisce un vero e proprio complesso macchinario societario e finanziario atto a fargli condurre, del tutto in ombra dalla sua Università di appartenenza, quella che non può che definirsi una - imponente - attività lavorativa parallela".
Aggiunge la Procura generale che il termine "consulenza" è strutturalmente polisenso ricomprendendo fenomeni differenti e che la "consulenza" che la norma derogatrice delineerebbe andrebbe ricondotta ad un'attività caratterizzata da alcuni tratti peculiari afferenti alla qualità di esperto del soggetto che rende la prestazione ed all'assenza di abitualità e non certo all'attività di consulente aziendale, figura che seppur "esterna", risulta permanente e si colloca a fianco dell'impresa.
Nella fattispecie in esame, secondo il Requirente, tali attività avrebbero comportato una presenza costante nel tempo, tutt'altro che occasionale, non limitata a singoli e specifici temi, ma generica o legata alla partecipazione a delle ampie "progettualità", con un'organizzazione di mezzi e persone preordinata allo svolgimento delle attività professionali extralavorative posto che, per tenere occultata al fisco ed all'Università l'attività parallela svolta, l'appellante "si serviva di scatole societarie e intermediari, senza i quali l'effettuazione delle prestazioni in quella forma e con quelle modalità non sarebbe stata possibile".
Reputa, poi, la Procura generale che l'attività di cessione di materiali didattici non possa ricondursi allo sfruttamento di opere dell'ingegno, concretizzandosi, invece, nella vendita "a nero" di un vero e proprio corso.
Peraltro, ad avviso della Procura, dai contratti depositati dall'appellante, in sede di memorie difensive e ritenuti equiparabili a quelli che regolamentavano le prestazioni parallele al lavoro accademico svolto, si trarrebbe conferma della natura di accordi di collaborazione per la partecipazione a specifiche progettualità aziendali ove il nomen "consulenza" risulterebbe adottato anche per lo svolgimento dell'attività tipica di una specifica figura aziendale, quale il Chief Technical Officer.
Eccepisce infine, che la competente Procura territoriale risulta aver adeguatamente provato l'effettuazione delle attività extra-istituzionali, la remunerazione e la mancanza di autorizzazione: tutti elementi ampiamente sufficienti ad affermare la responsabilità, spettando, invece, all'appellante l'onere di fornire la prova che le sue prestazioni non ricadevano nel genere delle consulenze.
In conclusione, la Procura generale, dopo aver affermato che non vi sarebbe dimostrazione alcuna dell'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 paventata dall'appellante in via subordinata, chiede il rigetto dell'atto di appello proposto da B. Andrea, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.
All'udienza di discussione della causa del 19 settembre 2025, le parti presenti hanno illustrato le proprie argomentazioni, ribadendo le richieste in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di doglianza, la parte appellante lamenta l'assenza di danno erariale e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010 e dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 eccependo, in particolare, che lo ius superveniens, costituito dall'art. 9, comma 2-ter, del d.l. n. 44/2023, retroattivamente applicabile, consentirebbe di superare le contestazioni mosse, trattandosi, comunque, di attività non soggette ad autorizzazione.
Osserva il Collegio che l'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e, al comma 9, precisa che: "gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi".
Trattasi di normativa improntata a specifici obblighi di comunicazione atti a consentire alle amministrazioni pubbliche di appartenenza, di verificare, in primo luogo, l'effettiva autorizzabilità degli incarichi in questione e, poi, ogni valutazione circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché in merito alla compatibilità dell'incarico stesso rispetto al proficuo svolgimento del rapporto lavorativo (I app., sent. n. 78/2025).
Ad avviso del Collegio, occorre procedere alla ricostruzione dell'articolato quadro ordinamentale in materia di incarichi di consulenza svolti da docenti universitari in regime di tempo pieno e che ha subito una recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 382/1980, il regime a tempo pieno del professore universitario: a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale.
Relativamente all'ambito delle attività di consulenza, notevole rilievo assume la disciplina dettata dall'art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010 nella parte in cui prevede espressamente che: "i professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza".
La Consulta, con sentenza n. 3/2024, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del su richiamato art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010, ha chiarito la distinzione tra attività totalmente incompatibili, attività liberamente esercitabili ed attività consentite, previa autorizzazione del rettore. E precisamente, il Giudice delle leggi individua: 1) attività extra-istituzionali incompatibili con la carriera universitaria: «esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» (art. 6, comma 9, primo periodo); 2) attività che i professori e i ricercatori a tempo pieno: a) non possono svolgere: «esercizio di attività libero-professionale [...] fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo» (art. 6, comma 9, secondo periodo); b) attività che possono essere svolte liberamente «anche con retribuzione» senza necessità di autorizzazione: «attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali» (art. 6, comma 10, primo periodo); c) attività che possono essere esercitate, previa autorizzazione del Rettore, ovvero: «funzioni di didattica e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza» (art. 6, comma 10, secondo periodo).
Con il comma 2-bis dell'art. 9 del d.l. n. 44 del 2023, convertito dalla l. n. 74 del 2023, è stato aggiunto, al su richiamato art. 6 della l. n. 240/2010, il comma 10-bis, con il quale si prevede la possibilità, per i professori ed i ricercatori a tempo pieno, di svolgere, «previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza» e purché sussistano talune specifiche condizioni negative quali: l'assenza di esercizio di poteri esecutivi individuali, di situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e di detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali dalla stessa affidate.
Con il successivo comma 2-ter dell'art. 9 del su richiamato d.l. n. 44 del 2023, è stata, poi, introdotta una disposizione di interpretazione autentica del su richiamato art. 6, comma 10, prevedendo, nel solco dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, che: "il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".
Emerge, quindi, che i più recenti interventi legislativi hanno, nei termini sin qui esposti, ampliato le attività consentite ai ricercatori ed ai docenti universitari in regime di impegno a tempo pieno e codificato il concetto di consulenza elaborato dalla giurisprudenza (Sez. riun. in sede giur., sent. n. 1/2025/QM/PROC).
Tale oramai consolidata giurisprudenza afferma, al riguardo, che la consulenza, per essere liberamente esercitabile, deve avere carattere scientifico, essere svolta in modo non subordinato, ma anche non organizzato e non implicante il compimento di attività tipicamente riconducibili alle figure professionali di riferimento; non deve comprendere prestazioni di carattere strumentale o esecutivo; deve, di norma, concludersi con un parere, una relazione o uno studio ed essere svolta in modo occasionale, non abituale, né continuativo (III app., sent. n. 473/2023; II app., sent. n. 172/2023; III app., sent. n. 7/2025).
Su tale linea interpretativa si pone, peraltro, l'atto di indirizzo M.I.U.R. n. 39 del 14 maggio 2018 che richiama i medesimi presupposti affinché l'attività di consulenza prestata dal docente universitario a tempo pieno rientri nella nozione di cui all'art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010.
Reputa, dunque, il Collegio che tali consolidati indirizzi giurisprudenziali continuino a dispiegare effetto anche in seguito all'introduzione della normativa di interpretazione autentica dettata dal su richiamato art. 9, comma 2-ter, del d.l. n. 44 del 2023 dovendosi considerare che, in tema di incarichi extra istituzionali, primaria rilevanza assume il rispetto del principio costituzionale dettato dall'art. 98 Cost. ai sensi del quale i pubblici dipendenti "sono al servizio esclusivo della Nazione".
L'esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico è, infatti, strumentale a garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Anche l'art. 11 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018, depositato dall'appellante, specifica che il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.
La giurisprudenza contabile di appello ha già avuto modo di chiarire che l'attività di consulenza, non va intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica, di cui conserva la stessa natura e caratteristiche e non può, in ogni caso, coincidere, confondendosi, con l'attività libero-professionale svolta per conto di privati o di enti pubblici che rimane espressamente vietata dall'art. 6, comma 9, della l. n. 240/2010 ai sensi del quale l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Diversamente opinando, se si desse un'interpretazione più estensiva della normativa, un docente a tempo pieno sarebbe libero di fare qualsiasi attività genericamente definita di consulenza con il pubblico e con il privato in maniera continuativa, il che sarebbe in aperto contrasto con lo spirito dello stesso comma 10 e, in particolare, con il su richiamato comma 9 della citata l. n. 240/2010 (I app., sent. n. 80/2017; II app., sent. n. 112/2025).
Pertanto, la locuzione attività di collaborazione scientifica e di consulenza deve essere interpretata in chiave restrittiva, non essendo consentita qualsiasi attività di consulenza esterna, bensì soltanto quella di carattere scientifico, ossia tale da involgere peculiari conoscenze e competenze maturate ad un livello di altissima specializzazione nella materia (II app., sentt. n. 172/2023, n. 147/2022), nonché avente quel carattere di occasionalità, indispensabile al fine di una piana qualificazione in termini di attività liberamente esercitabile (III app., sent. n. 7/2025).
Con condivisibile ragionamento, il Giudice di prime cure ha, quindi, posto attenzione allo svolgimento, da parte dell'appellante, di un'attività di natura non già occasionale, ma stabile e professionale esercitata mediante una "articolata ed organizzata struttura" emersa dagli interrogatori resi nel corso dell'indagine penale e caratterizzata da prestazioni professionali di cui si avvantaggiavano sia gli intermediari, sia i commercialisti e sia le società veicolo, "segno evidente della circostanza che vi fosse una ben definita organizzazione "imprenditoriale" di mezzi e persone, remunerate per effetto delle reiterate e pluriennali attività del B.".
Osserva, al riguardo, il Collegio che il quadro probatorio in atti rivela lo svolgimento di attività dissimulate per le quali risultava predisposto dall'appellante un articolato sistema che conduceva non solo a frodare il fisco, ma anche a celare all'Università di appartenenza l'esercizio di attività extra-istituzionali, ove i compensi per le prestazioni in favore di società estere venivano erogati a società fiduciarie per poi essere riversati in contanti all'appellante, al netto dei servizi di intermediazione.
Emerge, infatti, dal verbale di interrogatorio dell'11 novembre 2020 che un amico e socio dello studio commerciale di cui era cliente, "previa richiesta" proprio dell'appellante, gli proponeva di fare incassare il compenso ad una società fiduciaria con sede in Singapore che avrebbe stipulato il contratto con il committente ed avrebbe, poi, restituito il denaro contante, al netto di una commissione del 20%. Tale schema veniva, poi, reiterato anche per ulteriori prestazioni professionali ricorrendo anche a società situate in Albania, Svizzera ed a Panama (società Pomera).
Ritiene, dunque, il Collegio che, alla luce dei predetti elementi, con ragionamento logico immune da censure, la Sezione di primo grado abbia compiutamente delineato l'esercizio "sostanziale di attività professionale-imprenditoriale" da parte dell'appellante.
Il Collegio non può, quindi, non condividere quanto efficacemente affermato dalla sentenza impugnata sia in tema di ripetitività, frequenza ed abitualità dell'operato del B., che in merito alla circostanza per cui non si comprende per quale motivo allora tali attività non potessero essere notulate personalmente dall'appellante, ove la natura delle prestazioni fosse stata effettivamente riconducibile a quelle ammesse dall'ordinamento giuridico.
Rileva, inoltre, il Collegio che l'assenza di idonea documentazione scritta atta a disciplinare le attività concretamente svolte dall'appellante, pure evidenziata dalla Sezione territoriale, si pone in aperto contrasto con la necessità di un'apposita relazione o parere, richiesta, al fine di collocare l'attività di consulenza nell'alveo dell'art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010, dalla su richiamata consolidata giurisprudenza in materia e dall'atto di indirizzo M.I.U.R. n. 39 del 14 maggio 2018.
Invero, ad avviso del Collegio, l'analisi delle singole prestazioni elencate dall'appellante in sede di atto di impugnazione e la parziale correlata documentazione richiamata e depositata in prime cure, non pare assumere carattere dirimente posto che, nella vicenda in esame, come evidenziato dal Giudice di prime cure, l'appellante "risulterebbe aver reso le proprie prestazioni non nei confronti degli istituti di ricerca che sono stati menzionati negli interrogatori e negli atti difensivi, bensì nei confronti delle società veicolo".
Peraltro, osserva il Collegio che, relativamente alle prestazioni rese al Max Planck Institute - Germania (compenso euro 184.000,00) ed all'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) - Svizzera (compenso euro 24.000,00), la documentazione in atti è costituita da pubblicazioni di cui l'appellante risulta coautore unitamente ad altri molteplici autori e, precisamente, otto per il primo incarico e cinque per il secondo.
Parimenti, per la asserita "consulenza" resa a favore della multinazionale Synaptics (compenso euro 159.800,00), il Collegio rileva un articolo redatto con altri cinque coautori e la richiesta di brevetto negli Stati Uniti presentata dalla predetta società estera privata, non emergendo, tuttavia, come osservato dal Giudice di primo grado, l'attività di collaborazione con l'Università di Pavia, l'oggetto di questa, le modalità di determinazione dei compensi e la relativa fatturazione.
Inoltre, il Collegio non può non considerare che proprio le attività prestate nei confronti del Max Planck Institute e della multinazionale Synaptics hanno costituito oggetto dei capi di imputazione in sede penale "per fatti commessi anche al fine di consentire l'esecuzione del reato di riciclaggio"; per tali fatti il Tribunale, in sede di applicazione della pena su richiesta, ha dichiarato l'impossibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento, emergendo gli elementi di accusa da intercettazioni, da perquisizioni, da accertamenti della Guardia di finanza e dalle parziali ammissioni rese dall'odierno appellante, elementi questi ultimi che contribuiscono a delineare le modalità con le quali venivano svolti gli incarichi extra-istituzionali e che finivano per assumere, piuttosto, i connotati di un'attività parallela a quella di docenza universitaria.
Quanto all'avvenuta cessione alla società Pomera Inc di materiale tecnico-scientifico, il documento n. 15, depositato dall'appellante in primo grado e sottoscritto dal CEO della predetta società estera, indica, in via dettagliata, i seguenti compensi corrisposti: euro 109.500,00 per attività di "consulenza tecnica"; euro 29.000,00 per attività seminariale occasionale verso i clienti ed euro 75.000,00 per la cessione di documentazione tecnico-scientifica per corsi ulteriormente specificata in distinte voci.
Trattasi di elementi che, ad avviso del Collegio, delineano lo svolgimento di una reiterata e non occasionale attività didattica in favore di tale società estera per la quale, come affermato in prime cure, l'art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010 avrebbe richiesto l'apposita autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
Ad avviso del Collegio, deve porsi, poi, attenzione anche al rilevante importo complessivo, pari a euro 619.060,00, percepito dall'appellante, per le annualità dal 2017 al 2020, superiore alla retribuzione erogata dall'Ateneo ed emerso solo all'esito dell'indagine penale, non risultando le fatture attestanti l'entità dei corrispettivi, né come affermato dalla sentenza gravata, i dati afferenti alle società veicolo estere che consentivano di schermare le operazioni.
Con ulteriore documentazione, depositata dall'appellante unitamente alle memorie difensive, si segnala, al fine di illustrare gli standards di mercato dei compensi, che in un contratto, stipulato, in data 29 ottobre 2023, tra la società MBTechnoServices s.r.l. di cui è socio l'appellante e la società Ste Industries s.r.l. per la consulenza da fornire è stabilito il compenso di euro 350 all'ora, oltre iva, al pari di quanto concordato nel 2015 e 2016 fra la società SparklingIC s.r.l. e l'Università di Milano - Bicocca per prestazioni dello stesso tipo.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, dalla lettura dell'accordo tra la predetta società MBTechnoServices s.r.l. di cui è socio l'appellante e la società Ste Industries s.r.l., si trae, piuttosto, conferma dello svolgimento di attività professionale caratterizzata da ampia progettualità in quanto, non limitata a singoli e specifici temi, ma destinata a spaziare dalla formazione del personale alla selezione e formazione di specialisti sino al supporto "diretto" nelle interlocuzioni con partner e fornitori ed al supporto ad attività progettuali.
Rammenta, in proposito, il Collegio che l'attività di consulenza non deve incentrarsi sulla risoluzione di problematiche concrete, né essere volta a soddisfare unicamente interessi e necessità di soggetti terzi committenti (Sez. riun., sent. n. 1/2025/QM/PROC).
Peraltro, il predetto contratto risulta sottoscritto direttamente dall'appellante e non dall'amministratore unico della società (Alessandro B.), nonostante quest'ultimo risulti indicato, quale contraente, sia nel preambolo che nel rigo antecedente alla sottoscrizione.
Passando all'esame del secondo motivo di gravame con il quale l'appellante eccepisce la sussistenza di vantaggi comunque conseguiti dall'Università di appartenenza per effetto della conclusione di contratti di finanziamento alla ricerca, il Collegio rammenta che, secondo la consolidata giurisprudenza, il riconoscimento giudiziale della compensatio risulta subordinato al riscontro della sussistenza di rigorosi presupposti: identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'utilitas; effettività dell'utilitas conseguita; corrispondenza dell'utilità ai fini istituzionali dell'amministrazione; appropriazione dei vantaggi da parte dell'amministrazione (Sez. I app., sentt. n. 42/2025, n. 52/2024, n. 123/2024, n. 215/2024).
Al riguardo, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, hanno precisato che: "nei rapporti pubblicistici l'utilità gestoria deve essere valutata secondo i parametri fissati dalla legge a tutela di preminenti interessi pubblici quali sono apprezzati in primo luogo dallo stesso legislatore" (Sez. riun. in sede giur., sent. n. 24/2020).
Ad avviso del Collegio, non emerge, nella fattispecie in esame, alcun elemento idoneo a ravvisare la corrispondenza dell'utilità ai fini istituzionali dell'amministrazione, considerato che trattasi di evento dannoso conseguente alla dolosa violazione delle specifiche norme in materia di pubblico impiego.
Inconferente e priva di rilevanza appare, infine, al Collegio la prospettata questione di costituzionalità della norma dettata dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 che non consentirebbe di limitare l'obbligo di riversamento dei compensi a quanto eccede la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato sancita dall'art. 36 Cost. dovendosi, innanzitutto, rilevare che l'odierna fattispecie non verte in tema di diritto alla retribuzione, ma di emolumenti estranei al concetto di retribuzione poiché afferenti a compensi per incarichi extra-istituzionali il cui svolgimento, come già rilevato, deve, piuttosto, trovare adeguato contemperamento nel rispetto degli artt. 97 e 98 della Costituzione.
In ogni caso, tale questione non risulta al Collegio adeguatamente motivata in tema di specifica rilevanza, dovendosi, al riguardo, rammentare che la Consulta, già con pronunce n. 41/2015 e n. 90/2015, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di analoga questione di legittimità costituzionale.
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l'atto di appello proposto da B. Andrea, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 61148 del ruolo generale, rigetta l'atto di appello proposto da B. Andrea, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 160,00 (centosessanta/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.