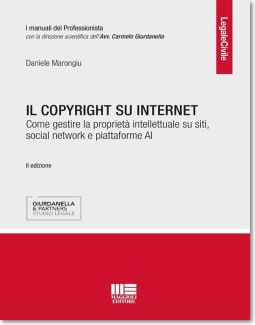Consiglio di Stato
Adunanza plenaria
Sentenza 7 novembre 2025, n. 16
Presidente: Maruotti - Estensore: Simeoli
FATTO
1. Con la sentenza non definitiva 29 ottobre 2024, n. 15 (a cui si rinvia per la descrizione dei fatti di causa e per lo svolgimento del processo), questa Adunanza plenaria, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe, ha dichiarato inammissibili gli interventi della s.p.a. Acquedotto Pugliese, ha respinto una eccezione di giudicato ed ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, ad integrazione di quella precedentemente disposta dalla Sezione Seconda (ed eseguita dal Direttore del Dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza) nel giudizio di appello n. 537 del 2023.
2. Dopo il deposito della perizia (redatta da un collegio di tre esperti, coordinato dal Rettore del Politecnico di Torino), le parti hanno ampiamente esposto, con rispettive memorie e repliche, la loro opinione sugli esiti dell'istruttoria.
3. All'udienza del 16 luglio 2025, la causa è stata discussa ed è stata decisa nei termini che seguono.
DIRITTO
1. Gli appelli in epigrafe - già riuniti con la sentenza non definitiva n. 15 del 2024 ed aventi ad oggetto delibere emesse per periodi regolatori diversi (quella che ha approvato il metodo tariffario idrico per il periodo «MTI-2» per gli anni 2016-2019, oggetto del ricorso in appello n. 537 del 2023, e la successiva sulla regolazione tariffaria del periodo «MTI-3», per agli anni 2020-2023, oggetto del ricorso in appello n. 4939 del 2023) - riguardano il medesimo tema del riconoscimento degli oneri finanziari sui conguagli corrisposti con differimento biennale.
Per la comprensione della questione controversa, va premesso l'esame dei principi rilevanti in materia tariffaria.
2. Il servizio idrico integrato rientra tra i «servizi di interesse economico generale» [art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201], trattandosi di attività che, in assenza di regole pubblicistiche, sarebbe svolta in modo non uniforme ovvero a condizioni di accessibilità inadeguate rispetto a quelle reputate coerenti con gli obiettivi di interesse generale.
Gli obiettivi perseguiti dalla regolazione tariffaria (che sottrae il corrispettivo del gestore alle libere negoziazioni di mercato) variano a seconda dei settori di mercato.
Nel settore del servizio idrico - il cui esercizio, al pari degli altri servizi "a rete", richiede infrastrutture non duplicabili, gestite in forza di specifici titoli concessori e "diritti di esclusiva" - il fondamento della regolazione tariffaria è costituito, in primo luogo, dal c.d. monopolio naturale.
In questa tipologia di mercato soltanto l'impresa che soddisfa l'intera domanda del mercato può operare a costi unitari ragionevoli, valorizzando le economie di scala.
La regolazione del corrispettivo, tuttavia, non mira soltanto a risolvere i "fallimenti di mercato", tipici dei contesti monopolistici o di quasi-liberalizzazione.
L'acqua, infatti, non è un prodotto commerciale al pari di altri, bensì un bene fondamentale e scarso, che va protetto con regole che ne preservino la qualità e ne garantiscano un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo.
Appartiene ai valori comuni dell'Unione europea, in materia di servizi di interesse economico generale, ricercare la sintesi tra i fini di sostenibilità economica (art. 14 del TFUE), concorrenza (art. 106, paragrafo 2, del TFUE), accessibilità (protocollo n. 26 del TFUE), coesione sociale e territoriale (art. 36 della CDFUE) e tutela dell'ambiente (artt. 11 del TUE e 191 del TFUE). Analogo sistema di valori è desumibile dall'art. 41 della Costituzione (come modificato dalla legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1) ed è alla base del riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (di cui al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201).
3. Dalla disciplina di fonte primaria emergono, in materia tariffaria, i seguenti criteri direttivi: redditività della gestione, regolazione incentivante, internalizzazione dei costi ambientali e delle risorse, equità sociale.
3.1. La regolazione tariffaria deve, in primo luogo, prevedere che i servizi funzionino in base a condizioni, economiche e finanziarie, che consentano ai gestori di assolvere i propri compiti.
Qualora, infatti, non venga remunerato adeguatamente, il servizio non sarebbe in grado di offrire garanzia di continuità e di sviluppo nel tempo. Anche quando l'interesse pubblico richiede che il servizio sia erogato gratuitamente o sottocosto, il principio di economicità è rispettato, perché l'Amministrazione prevede la compensazione trasparente degli oneri di servizio pubblico.
Il legislatore, sia con disposizioni di carattere generale - riferite cioè a tutti i servizi di interesse economico generale (artt. 12 della l. 23 dicembre 1992, n. 498; 1 e 2, commi 17 e 18, della l. 14 novembre 1995, n. 481; 117 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 26 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201) - sia con disposizioni specifiche del settore idrico, ha disposto che la tariffa deve assicurare la «copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Per la giurisprudenza costituzionale, il riconoscimento della rilevanza economica di un servizio pubblico si delinea tramite l'adozione di un modello organizzativo efficiente, in grado di remunerare, in un determinato periodo di tempo, i costi mediante i ricavi (sentenze n. 26 del 2011 e n. 325 del 2010).
Affinché la tariffa sia tendenzialmente idonea ad equilibrare i costi dei fattori produttivi e i ricavi da proventi, in essa vanno computati:
- i costi operativi, sostenuti per la gestione corrente delle attività, per mantenere in funzione l'impianto;
- i costi di manutenzione, necessari per mantenere gli asset in buono stato di funzionamento fino alla fine della loro vita utile;
- i costi di capitale, comprendenti gli investimenti, gli ammortamenti, nonché il c.d. costo opportunità del capitale (ossia una stima del costo che una impresa sostiene per raccogliere le risorse finanziarie occorrenti per l'attività, sotto forma di capitale di rischio presso gli investitori o sotto forma di capitale di credito: cfr. C.d.S., n. 2481 del 2017, secondo cui i costi di capitale «devono ritenersi immanenti» alla natura di servizio di rilevanza economica propria del servizio idrico integrato).
3.2. Non è tuttavia sufficiente che il regolatore calcoli l'ammontare dei ricavi che sono richiesti per coprire i costi previsti dell'impresa.
La privativa comporta infatti il rischio che il monopolista imponga prezzi superiori a quelli che prevarrebbero in un parallelo e ipotetico mercato concorrenziale.
Le attività remunerate tramite il riconoscimento ("a piè di lista") dei costi storici hanno dimostrato - sulla base degli studi di settore - la patologica tendenza a comportamenti opportunistici di sovracapitalizzazione e alla inefficienza produttiva.
L'ordinamento, per tale motivo, assegna alla regolazione il compito di mitigare il rischio di "abuso di potere economico", attraverso una metodologia tariffaria che (sopperendo alla mancanza di pressione concorrenziale) stimoli l'efficientamento produttivo e la minimizzazione dei costi.
L'obiettivo del tendenziale allineamento delle tariffe ai costi efficienti di erogazione (sancito dalla l. 14 novembre 1995, n. 481) è stato ribadito dall'art. 26, comma 1, del citato d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.
Il principale dispositivo tariffario - volto a spingere le imprese ad essere più efficienti e ad evitare sprechi - è quello del price cap (cfr. art. 2, commi 18 e 19, della l. 14 novembre 1995, n. 481; art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 201 del 2022; artt. 151 e 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006), il quale consiste nell'individuare, per un certo periodo, il prezzo massimo dei costi riconosciuti in misura inferiore a quello praticato in un (ipotetico) monopolio non regolato, modificandolo periodicamente tramite un fattore correttivo che stima l'incremento di produttività.
3.3. Oltre ai costi finanziari, l'art. 119 del d.lgs. n. 152 del 2006 (che ha attuato l'art. 9 della direttiva 60/2000/CE) impone di considerare, sempre sotto il profilo tariffario, anche le esternalità del consumo di acqua o dei suoi usi alternativi.
I costi ambientali rappresentano i costi dei danni che gli usi dell'acqua impongono all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che utilizzano l'ambiente.
I costi delle risorse riflettono invece il valore di scarsità della risorsa e si riferiscono al costo della privazione del prossimo possibile utilizzatore, conseguente all'esaurimento della risorsa al di là del suo tasso naturale di ricarica o di recupero.
I costi ambientali e delle risorse sono quindi legati alle «esternalità» generate dall'uso delle risorse, ovvero alle perdite di benessere che non sono inglobate nel prezzo di scambio.
Su queste basi, le entrate derivanti dalle tariffe ambientali e da altri strumenti economici devono essere in grado di finanziare interamente, oltre ai costi di fornitura dei servizi idrici, anche i costi (aggiuntivi) per rimediare, mitigare o prevenire le pressioni quantitative (scarsità) o qualitative (inquinamento) sulle risorse idriche e sull'idromorfologia dei corsi idrici.
3.4. Il regolatore deve inoltre tenere conto delle «ripercussioni sociali», oltre che ambientali ed economiche, del recupero dei suddetti costi (art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006; vedi anche l'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 201 del 2022, sulla possibilità per gli enti affidanti di prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale).
3.5. Non è necessario che tutti tali costi del servizio idrico siano recuperati attraverso la tariffa, poiché il recupero può avvenire anche attraverso una modulazione di tariffe, tasse e trasferimenti (cfr. C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 6108 del 2019).
4. Una volta individuate le regole di fonte primaria, va analizzata la struttura tariffaria oggetto di impugnazione, al fine di verificarne la rispondenza ai primi.
I metodi tariffari MT1 e MT2 riproducono un meccanismo di price-cap, nel quale i ricavi sono pari ai costi riconosciuti dal regolatore, sulle base delle informazioni che i gestori sono tenuti a trasmettere all'Autorità di regolazione.
L'importo complessivo riconosciuto al gestore a copertura dei costi di gestione e di investimento viene denominato «vincolo ai ricavi del gestore (VRG)».
Tale importo complessivo è la risultante della somma delle seguenti componenti:
- costi delle immobilizzazioni, che includono oneri finanziari, oneri fiscali e ammortamenti (𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥a: capital expenditures);
- l'eventuale anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti (𝐹𝑜𝑁𝐼a: fondo nuovi investimenti), in quanto i gestori idrici hanno l'obbligo di destinare una quota del proprio "vincolo" ai ricavi alla realizzazione di nuovi investimenti individuati come prioritari;
- i costi operativi della gestione, quali energia elettrica, forniture all'ingrosso, mutui, canoni riconosciuti agli enti locali (𝑂𝑝𝑒𝑥a: operating expenditures);
- i costi ambientali e della risorsa (𝐸𝑅𝐶a: environmental and resource costs).
A tali voci, si aggiunge la componente - su cui si incentra la presente controversia - che attiene al calcolo dei conguagli (𝑅𝑐a-tot), la quale consente il recupero dello scostamento tra il VRG calcolato inizialmente sulla base di stime (nell'anno a-2), e quanto effettivamente dovuto, in ragione di quanto rendicontato a consuntivo, ad ogni gestore (nello stesso anno a-2).
Il meccanismo va meglio precisato nel punto seguente.
4.1. Il metodo tariffario, strutturato per periodi regolatori di durata quadriennale (c.d. regulatory lag: ovvero il lasso temporale entro cui i criteri tariffari spiegano efficacia, periodo attualmente portato a sei anni), prevede una revisione biennale per l'aggiornamento delle componenti a conguaglio.
Il "ritardo temporale" di due anni scaturisce dalla necessità di accedere a tutte le informazioni necessarie. In sede di predisposizione tariffaria, infatti, non sempre si dispone di tutti i dati "consuntivati", necessari all'allineamento di costi e gettito tariffario.
La liquidazione differita, per un biennio rispetto alla loro effettiva manifestazione, determina uno sfasamento temporale tra il momento nel quale il costo viene sostenuto e quello nel quale la tariffa lo recepisce, andando per questa via ad alimentare un conguaglio.
Il conguaglio, riferibile al metodo tariffario, è formato da diverse componenti e specificatamente interessa: i costi operativi «esogeni» (sulla cui nozione si tornerà dopo), i costi previsionali e i volumi venduti, i quali vengono registrati nell'anno in cui si realizzano sulla base di stime, e successivamente vengono rettificati sulla base del dato effettivo.
Il conguaglio, in sintesi, riflette:
a) per i costi esogeni, la differenza tra l'importo riconosciuto in tariffa e la loro valorizzazione a consuntivo;
b) per i costi previsionali (in qualche misura efficientabili), la differenza tra quanto stimato e quanto effettivamente speso;
c) per i volumi lo scostamento tra gettito tariffario «teorico» calcolato nel precedente aggiornamento tariffario (a-2) e le entrate effettivamente registrate in bilancio (a).
Il metodo tariffario prevede l'aggiornamento del conguaglio rispetto al tasso di inflazione relativo al periodo di tempo intercorrente fra il momento in cui il costo è sostenuto e quello in cui il medesimo viene rimborsato, ma non riconosce l'onere finanziario derivante dalla prolungata indisponibilità delle somme dovute.
5. Si pone, a questo punto, la questione se il meccanismo regolatorio sopra indicato - il quale può indurre il gestore ad anticipazioni finanziarie per fare fronte al differimento biennale nella corresponsione dei conguagli - richieda o meno, per essere rispettoso del principio del recupero integrale dei costi, il riconoscimento di oneri finanziari e non solo del tasso di inflazione (che in quanto tale tiene conto soltanto del valore nominale dei costi).
Preliminarmente, va definita la natura del "costo" da conguaglio e, conseguentemente, sia verificato come esso vada considerato all'interno del metodo tariffario in contestazione.
La consulenza tecnica, rispondendo al primo quesito formulato dal Collegio [cfr. par. 10.3, lett. b), del considerato in diritto della sentenza non definitiva n. 15 del 2024], ha offerto un notevole ausilio conoscitivo.
5.1. Gli oneri da conguaglio non possono configurarsi come costi di investimento, perché non sono relativi alla realizzazione di investimenti nuovi, bensì si generano per effetto del ritardo con cui sono corrisposti alcuni costi operativi (legati a spese correnti).
Ma essi nemmeno sono propriamente riconducibili ai costi operativi, in quanto questi ultimi sono già integralmente coperti dalla tariffa, sebbene con uno sfasamento temporale rispetto al momento in cui sono stati sostenuti.
Propriamente gli oneri da conguaglio possono assumere due qualificazioni diverse:
- come oneri finanziari, laddove i gestori, in conseguenza del menzionato sfasamento temporale, abbiano sostenuto interessi e altri oneri in relazione all'ottenimento di finanziamenti necessari a coprire, temporaneamente, i costi sostenuti, in attesa del loro differito ristoro tariffario;
- come costi opportunità, laddove i gestori non abbiano sostenuto oneri finanziari per l'ottenimento della provvista utile alla copertura dei costi sostenuti, ma - in attesa del differito ristoro tariffario - abbiano impiegato a tal fine risorse proprie (tale costo è quantificabile come una stima del tasso di rendimento che si sarebbe potuto ottenere da un investimento alternativo delle risorse impiegate dal gestore per coprire, temporaneamente, i costi riconosciuti dalla tariffa solo in un momento successivo a quello in cui sono stati sostenuti).
5.2. Secondo l'Autorità, la censura degli operatori sarebbe infondata, in quanto il costo generato dai conguagli sarebbe già intercettato sul piano tariffario, sia dalle valutazioni sulla rischiosità dell'attività di gestione, corrispondente al valore tariffario «beta», sia dalla disciplina del capitale circolante netto.
Gli esiti dell'istruttoria svolta, rispondendo al terzo e quarto quesiti formulati dal Collegio (per i quali nuovamente si rinvia al par. 10.3 della sentenza non definitiva), hanno invece dimostrato che il costo da differimento del conguaglio - nella duplice configurazione che può astrattamente assumere - non è coperto dal metodo tariffario.
Gli oneri finanziari vengono valorizzati all'interno del «costo medio ponderato del capitale» (art. 11 MIT3) ed includono anche una componente «alfa» a copertura della rischiosità.
Tale componente è a propria volta calcolata in funzione di un parametro «beta», che ha come finalità quello di calcolare la rischiosità di un'impresa operante nel settore idrico rispetto alla rischiosità media del mercato.
Ma poiché nello stesso modello tariffario gli oneri finanziari sono riconosciuti solo se relativi alle immobilizzazioni, allora anche la componente «beta» deve ritenersi funzionale, unicamente, a determinare gli oneri riconoscibili in relazione alle immobilizzazioni (il che, tuttavia, non rileva per il caso in esame).
Il costo opportunità, rientrando sotto il profilo categoriale tra i "costi di capitale", potrebbe, in astratto, essere incluso nel capitale investito netto del gestore (𝐶𝐼𝑁𝑎), posto che tale grandezza - cfr. MTI3, art. 9 - include anche la quota (𝐶𝐶𝑁𝑎) a compensazione del capitale circolante netto riferita all'anno (a). Tale quota è, infatti, calcolata tenendo conto dell'importo delle voci «B6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci» e «B7) Costi per servizi», come risultanti dal bilancio dell'anno (a-2) del gestore. Tuttavia, il modello tariffario adottato da ARERA non riconosce l'inclusione dei costi opportunità nella quota 𝐶𝐶𝑁𝑎.
5.3. La tesi di Acqualatina - secondo cui i conguagli, influenzando il capitale circolante sarebbero invece assimilabili a costi di investimenti - non risulta condivisibile.
Come persuasivamente replicato dai consulenti incaricati dal Collegio, il capitale circolante è sì influenzato dai flussi finanziari, a debito ma anche a credito al momento in cui i conguagli sono incassati. Tuttavia, tali flussi non cambiano natura solo perché, a livello regolatorio, tale voce è inserita nel CIN. È corretto ritenere che la qualificazione del conguaglio debba dipendere e derivare dalla voce di costo che lo ha originato.
5.4. Pertanto, non resta che verificare se la mancata considerazione (se non ai fini inflattivi) dell'onere derivante dallo sfasamento temporale del conguaglio sia legittimo o meno.
6. Prima di scrutinare il quesito nel merito, sono opportune alcune precisazioni sull'intensità del sindacato giurisdizionale.
Nella materia tariffaria, la legge rimette al regolatore l'individuazione della concreta misura "compositiva" tra fini sociali, tutela ambientale e sostenibilità economica delle gestioni, stabilendo che l'Autorità ha il compito di definire «le componenti di costo per la determinazione della tariffa», tenendo conto «sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse» [cfr. art. 10, comma 14, lett. d), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106].
Il legislatore, non risultando prevedibili le possibili reciproche interazioni tra i beni ed i soggetti interessati, si è limitato a predisporre soltanto i congegni per il loro confronto dialettico, senza prefigurare un esito predeterminato, attribuendo il potere di definire le regole di funzionamento del sistema tariffario ad un regolatore indipendente, dotato di risorse umane e materiali che consentono di raccogliere e di analizzare le informazioni sui costi, sui prezzi e sui livelli di qualità dei servizi erogati.
Quando la materia da disciplinare è complessa e lo stato delle conoscenze è estremamente dinamico, l'attribuzione dei poteri regolatori all'Autorità mira ad attuare il principio di buona amministrazione, in quanto il procedimento consente l'analisi partecipata delle diverse soluzioni possibili e costituisce uno strumento di razionalità.
La relativa tutela giurisdizionale è piena ed effettiva «secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo» (art. 1 del c.p.a.).
In presenza dell'esercizio di un potere regolatorio, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo riguarda tipicamente il raffronto tra una norma primaria attributiva del potere e la regola applicativa elaborata dall'Autorità (e non la riconduzione di un "fatto" nel perimetro applicativo di una fattispecie normativa, come avviene per la verifica di legittimità di una sanzione amministrativa punitiva: C.d.S., sent. 15 luglio 2019, n. 4990).
I criteri direttivi indicati nella legge esprimono una ratio che può essere implementata da diverse regole di settore, sicché il sindacato del giudice amministrativo - pur basandosi sulla diretta conoscenza dei fatti rilevanti - non è "di tipo sussuntivo", bensì "funzionale", in quanto incentrato sui principi della ragionevolezza (anche tecnica) e della proporzionalità.
L'interessato, oltre a far valere il rispetto delle garanzie procedimentali, può contestare in ogni punto di fatto e diritto quanto argomentato dall'Autorità (in osservanza dei «principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione»: art. 2 del c.p.a.), prospettando quei motivi da cui possano emergere seri profili di irrazionalità e di inattendibilità tecnico-scientifica della scelta regolatoria.
Resta fermo che se, all'esito dell'istruttoria, si fronteggiano opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare la decisione.
In quest'ultimo caso, non si può ravvisare un "privilegio" di insindacabilità dell'azione amministrativa, ma si deve constatare come la legge, decidendo di non disciplinare direttamente il conflitto di interessi e di apprestare solo i criteri ed i procedimenti per la loro risoluzione dialettica, abbia demandato all'Amministrazione il potere di decidere motivatamente quale debba prevalere (cfr. C.d.S., 23 settembre 2022, n. 8167).
7. Su queste basi, la scelta regolatoria di considerare, nel riconoscimento dei conguagli, solo l'inflazione e non anche gli oneri finanziari (o i costi opportunità) non si pone in contrasto con le disposizioni che regolano la materia tariffaria, né risulta irragionevole o sproporzionata.
7.1. L'entità della variazione da conguaglio può dipendere sia da variabili «endogene» - in qualche misura dipendenti dallo sforzo, volitivo e tecnico, profuso dall'operatore economico per aumentare l'efficienza produttiva e la qualità dei propri servizi - sia da variabili «esogene», associate alla rischiosità della gestione del servizio e incomprimibili con azioni di efficientamento.
7.2. La scelta di non considerare gli oneri finanziari nella determinazione dei conguagli è - con riguardo ai conguagli influenzati da variabili endogene - coerente con la direttrice normativa sopra indicata (par. 3.2), che impone al regolatore di incentivare i comportamenti virtuosi degli operatori economici.
L'istruttoria svolta (in particolare, la consulenza disposta nel giudizio di appello n. 537 del 2023) ha consentito di identificare alcuni fattori tecnici e gestionali che influenzano l'entità dei conguagli e che sono suscettibili di efficientamento, e segnatamente:
a) i sistemi di misurazione e di contabilizzazione dei consumi;
b) i livelli di perdita delle reti di adduzione e di distribuzione;
c) l'efficienza energetica degli impianti di sollevamento, di potabilizzazione e di depurazione.
L'insorgenza di conguagli generati dalla differenza fra i volumi di vendita previsti e quelli realmente consumati è in parte riconducibile alle inefficienze della fatturazione dei consumi.
Un maggior grado di efficienza e di tempestività del sistema di misurazione dei consumi (consentendo di disporre di dati effettivi e certificati relativi ai volumi di vendita) permetterebbe di verificare, sin dall'inizio, se i ricavi sono corrispondenti ai costi.
Le componenti di conguaglio che riguardano i costi connessi al consumo dell'energia elettrica - oppure quelli dell'acquisto all'ingrosso (dipendenti dai volumi immessi e circolanti in rete) - sono influenzate dalle attività di modellazione idraulica della rete utilizzate dal gestore per la gestione delle pressioni in rete, al fine di contenere le perdite idriche.
L'elevato livello di perdita, imponendo un approvvigionamento di risorsa maggiore rispetto a quello necessario, impatta evidentemente sulla componente energetica, qualora le fonti di approvvigionamento impongano l'uso di impianti di sollevamento.
Analoga conclusione può essere estesa alle reti di drenaggio e degli impianti di depurazione.
I costi energetici - correlati ai volumi idrici immessi in rete dopo i necessari sollevamenti (captazione da pozzi e rilanci in rete), a quelli circolanti in rete (volumi consegnati e dispersi) - possono essere ridotti anche tramite l'adozione di un modello organizzativo e gestionale efficiente di modellazione idraulica della rete (c.d. "distrettualizzazione", con conseguente gestione delle pressioni in rete e riduzione delle perdite), in grado di efficientare tutto il sistema di distribuzione idrica.
In definitiva, le componenti che, nella maggioranza dei casi, rappresentano la percentuale maggiore dei conguagli, ovvero quelle relative ai volumi e all'energia, non sono del tutto «esogene», cioè non derivano da fattori del tutto esterni e non soggetti al controllo delle parti.
Rispetto all'ammontare dei conguagli influenzati dai fattori gestionali efficientabili appena indicati - per i quali resta ferma la possibilità per il regolatore di prevedere anche specifici e autonomi obblighi di qualità tecnica, ad esempio relativi all'anzianità dei contatori e all'attivazione della telelettura dei contatori - il riconoscimento di un onere finanziario si risolverebbe in un incentivo a posticipare investimenti infrastrutturali e modelli organizzativi efficienti, trasferendone i costi agli utenti in tempi successivi.
7.3. L'istruttoria ha consentito di appurare che la differenza fra volumi fatturati previsti e consumati può essere influenzata anche da fattori posti al di fuori del controllo delle parti (dinamica demografica, configurazione abitativa, cambiamenti climatici, modifiche dei consumi, prezzo dell'acqua, articolazione tariffaria per fasce di utenza), dipendenti da condizioni sociali ed ambientali sito-specifiche.
Ed anche lo scostamento di alcuni costi operativi può essere dovuto a cause imprevedibili (legate, ad esempio, alla crisi epidemiologica e all'impennata dei prezzi dell'energia).
Tuttavia, anche quando il fatto generativo del conguaglio è «esogeno», l'onere finanziario (o il costo opportunità) derivante dalla sua liquidazione differita non è imposto dal principio normativo del recupero integrale dei costi, il quale (come indicato sopra al par. 3.1) impone che il modello tariffario:
a) garantisca la «correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione» [art. 26, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 201 del 2022];
b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari, anche in considerazione degli effetti moltiplicatori che derivano dall'inefficienza dell'uso della risorsa;
iii) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero.
L'art. 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 - il cui scopo dichiarato è quello di istituire un quadro per la protezione delle acque che ne impedisca un ulteriore deterioramento e agevoli un utilizzo idrico sostenibile - dispone che la tariffa (da sola o insieme a tasse o trasferimenti) deve coprire non solo i costi finanziari, ma anche quelli derivanti dal degrado quantitativo e qualitativo della risorsa (considerando 38).
Il concetto di recupero «integrale» è dunque quello di considerare anche gli impatti del servizio idrico in termini di sostenibilità ambientale e sociale, e di equità.
L'equilibrio economico e finanziario della gestione - il quale «sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire, per un operatore efficiente, i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio» (art. 177, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) - implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all'operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto.
Una volta attuato l'equilibrio economico-finanziario della gestione, la regolazione tariffaria non implica la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non impone sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.
La regolazione del servizio idrico non pone a carico del gestore né il rischio della domanda, in quanto il conguaglio permette di recuperare integralmente il minore gettito tariffario, né il rischio dei costi «esogeni», i quali sono integralmente coperti dalla tariffa, sebbene liquidati con uno sfasamento temporale biennale rispetto al momento in cui sono stati sostenuti.
L'accollo in capo all'operatore del solo rischio di dovere anticipare i costi esogeni o previsionali stimati in modo incompleto - rischio peraltro circoscritto temporalmente al biennio, nonché mitigato dal riconoscimento dell'inflazione e dai meccanismi di riequilibrio che saranno descritti nel punto seguente - risulta coerente con la traslazione del rischio operativo tipico del modello concessorio, che si applica anche ai servizi di interesse economico generale (art. 176, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; art. 15 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201).
Il rischio operativo (che nel servizio idrico è sostanzialmente traslato sul lato dell'offerta, ovvero in funzione del raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione, come incentivati dalla regolazione) è infatti «quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti» (art. 177, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Nel caso in esame, le società non hanno dimostrato che il mancato riconoscimento degli oneri da differimento biennale abbia pregiudicato o messo in pericolo l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni (in senso contrario, nel caso specifico di Siciliacque, depongono anzi gli utili maturati in bilancio ed i risultati positivi del conto economico presenti nelle predisposizioni tariffarie: doc. 19 e 20, deposito primo grado).
La scelta regolatoria (del mancato riconoscimento dell'onere finanziario da conguaglio differito) è inoltre coerente con gli obiettivi ambientali del risparmio idrico (di cui all'art. 1, commi da 61 a 65, della l. n. 178 del 2020, e all'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006).
Sarebbe, infatti, contraddittorio per il sistema normativo da un lato «incentivare gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente», dall'altro rendere oneroso per gli stessi utenti la realizzazione di tale finalità, imponendo loro di farsi carico anche di oneri finanziari sui conguagli in caso di diminuzione dei volumi rispetto alle stime tariffarie (fermo restando che, in ipotesi, la corresponsione di interessi dovrebbe basarsi sul principio di reciprocità nei casi di conguagli negativi, in cui sarebbe l'utenza a percepirli con una riduzione tariffaria).
La determinazione contestata, inoltre, mitiga il rischio di "azzardo morale del monopolista".
La doppia natura degli oneri oggetto del giudizio ("onere finanziario" o "costo opportunità") è in sostanza rimessa alle scelte aziendali del gestore che, in caso di riconoscimento di oneri finanziari, potrebbe adottare comportamenti opportunistici come quello di ricorrere al mercato del finanziamento, anziché reimpiegare gli utili aziendali per far fronte alla dilazione temporale, ovvero rimandare la riscossione di proventi tariffari da parte degli utenti.
7.4. La ragionevolezza e la proporzionalità dell'impianto regolatorio sono avvalorate dall'esistenza di meccanismi di riequilibrio, di tipo regolatorio e contrattuale, in grado di moderare - a fronte di talune sopravvenienze qualificate, idonee ad alterare le condizioni di equilibrio economico della gestione - l'impatto delle anticipazioni finanziarie imposte dal meccanismo del conguaglio.
Per quanto riguarda repentini aumenti dei costi per energia elettrica, l'Autorità ha approntato rimedi che prevedono il riconoscimento integrale dei maggiori costi sostenuti in sede di conguagli per eventi eccezionali (come gli aumenti di costo imprevedibili dell'energia) e forme di anticipazione dei maggiori costi da sostenere (con anticipazione fino al 25% a carico della tariffa e fino ad un ulteriore 35% a carico del sistema, mediante la Cassa per i servizi energetici e ambientali: cfr. le delibere ARERA 580/2019/R/idr; 639/2021/R/idr; 229/2022/R/idr; n. 495/2022/R/idr).
La circostanza che, per l'anticipazione finanziaria della CSEA, il gestore sostenga un onere finanziario (pari al tasso di interesse applicato correlato a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio istituto bancario) non è in contraddizione col fatto che nel VRG al gestore venga riconosciuta solo l'inflazione sul valore dei conguagli differiti nel tempo.
Le anticipazioni finanziarie necessarie per far fronte a circostanze straordinarie sono, in questo caso, corrisposte da un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale e sono dunque ben differenti dagli eventuali costi da sostenere, derivanti dalla determinazione delle diverse componenti del VRG.
Vi sono inoltre ulteriori misure per mantenere l'equilibrio economico-tariffario, tra cui la «revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a: - trattamento dei costi di morosità; - allocazione temporale dei conguagli; - rideterminazione del deposito cauzionale; - revisione dell'articolazione tariffaria; - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati» [così l'allegato alla deliberazione 656/2015/R/idr, art. 10.1, lett. a); la successiva lett. e), dello stesso art. 10.1, ammette anche «eventuali ulteriori misure definite dalle parti», ovvero concordate tra ente di governo dell'ambito e gestore].
Lo stesso regolatore, a partire dal MTI - per attenuare l'impatto sui conguagli - in presenza di nuovi tecniche o di variazioni di gestioni, ha previsto la possibilità di anticipare la quantificazione di talune componenti di costo connesse a specifiche circostanze eccezionali, secondo una logica previsionale (comma 25.3 del MTI; tali accorgimenti sono stati estesi e consolidati nei metodi tariffari successivamente varati, come il MTI-2 e il MTI-3; la consulenza tecnica ha fatto emergere come tali interventi regolatori abbiano limitato, progressivamente, l'incidenza della componente di conguaglio sul VRG, con un peso che è passato dal 2% e 3%, nelle proposte tariffarie degli anni 2014 e 2015, allo 0,7%, nelle proposte tariffarie del 2020).
Vi è poi anche il rimedio revisionale di tipo contrattuale, previsto dalla disciplina dei contratti pubblici (cfr. l'art. 192 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che, in presenza di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, consente di chiedere la «revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto»).
7.5. Risulta pertanto infondata la deduzione di Siciliacque secondo cui l'Autorità di regolazione, per la sua carenza di legittimazione democratica, in sede di determinazione delle tariffe non potrebbe svolgere apprezzamenti discrezionali basati sulla ponderazione degli interessi.
La scelta di considerare nel riconoscimento dei conguagli solo l'inflazione è volta ad influenzare il comportamento degli operatori economici per obiettivi di efficienza e razionale ripartizione dei rischi contrattuali e non consiste di per sé in un meccanismo redistributivo di regolazione c.d. sociale.
7.6. È dunque legittimo e ragionevole che i conguagli - riconosciuti all'interno del periodo regolatorio di competenza - siano rivalutati al solo tasso di inflazione. Gli operatori possono stimare ex ante il proprio fabbisogno finanziario, tenendo conto anche della dilazione temporale dei ricavi rispetto ai costi sostenuti, nei termini prefigurati dal metodo tariffario, potendo quindi operare le opportune decisioni al riguardo.
L'istruttoria svolta ha fatto però emergere anche la prassi di conguagli c.d. "discrezionali", derivanti cioè dalla scelta degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO) di contenere le tariffe ad un livello inferiore rispetto a quello consentito dal metodo tariffario, limitando gli incrementi tariffari nel breve termine e spostando in periodi successivi l'inserimento in tariffa dei conguagli, per ragioni connesse alla sostenibilità sociale delle tariffe.
Ne deriva che il conguaglio, riconosciuto dal metodo tariffario con una dilazione biennale, potrebbe essere ulteriormente posticipato nel tempo e quindi manifestarsi sotto il profilo finanziario con una dilazione anche superiore.
Sennonché, come appurato anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Seconda Sezione nella causa n. 537 del 2023, questa tipologia di conguaglio "discrezionale" (frutto di una scelta dell'EGATO che decide di non applicare integralmente gli aumenti tariffari teoricamente possibili) non è prevista quale elemento autonomo del metodo tariffario adottato (il quale prevede la possibilità, da parte degli EGATO, di spostare la componente dei conguagli negli anni successivi, al fine di ricondurre gli incrementi tariffari al di sotto del limite di prezzo, price-cap, previsto dalla regolazione: cfr. comma 3.4 della deliberazione 664/2015/R/idr; ovvero la possibilità di richiedere un incremento della tariffa c.d. sovra-cap nelle ipotesi di cui all'art. 4.6, deliberazione 639/2023/R/idr).
Anzi, l'Autorità - al fine di armonizzare una serie di esigenze di segno contrario, quali la tutela dell'utenza rispetto a pressioni tariffarie eccessive, il contenimento del rinvio dei conguagli e la necessità di garantire i fondi necessari per la realizzazione degli investimenti necessari all'erogazione del servizio - richiede che vi sia uno specifico accordo tra il gestore e l'EGATO, affinché quest'ultimo possa proporre un rinvio dei conguagli successivamente al periodo regolatorio in corso (per MTI-2, vedi la determina 3/2016-DSID, allegato 2; per il metodo MTI-3, vedi la determina 1/2020-DSID, allegato 3: con tali provvedimenti, l'Autorità ha fornito istruzioni agli EGATO sulle predisposizioni tariffarie, includendo l'indicazione che eventuali recuperi di conguagli oltre l'orizzonte temporale del metodo debbano essere concordati con il gestore).
Tale impostazione è stata confermata nel metodo MTI-4, dove è stato esplicitato che: «È facoltà dell'Ente di governo dell'ambito - in accordo con il pertinente gestore - di presentare motivata istanza per il rinvio di taluni costi ammissibili (prevedendo le modalità per il relativo recupero successivamente al 2029) anche nei casi di variazioni annuali del moltiplicatore tariffario al di sotto dei limiti stabiliti dalla regolazione qualora ciò fosse motivato dall'esigenza di mitigare l'impatto sull'utenza e comunque garantendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione interessata» (art. 28.2 del MTI-4).
Un recupero tariffario differito al di là del periodo contrattuale originariamente previsto configura una modifica della concessione, che non potrebbe essere imposta unilateralmente all'affidatario del servizio (le determine sopra menzionate richiedono all'ente d'ambito di attestare l'intesa con il gestore sul differimento, oppure offrono al gestore la possibilità di segnalare all'Autorità eventuali dissensi).
L'Autorità, coerentemente, impedisce il rinvio di conguagli "negativi" a favore degli utenti.
A fronte di un assetto regolatorio che prevede (in applicazione peraltro dei principi generali in materia di contratto) l'accettazione, da parte del gestore, del rinvio dei conguagli al periodo regolatorio successivo, risulta infondata, anche in questo caso, la pretesa degli operatori di ottenere la copertura dei conseguenti «oneri finanziari».
7.7. Per completezza, va precisato che gli interessi sui conguagli non sono dovuti neppure sulla base della disciplina sulle obbligazioni e sui contratti, poiché i conguagli non sono un credito certo ed esigibile da parte del gestore.
Prima della sua determinazione costitutiva (da parte dell'Autorità), il conguaglio non è né esigibile, né liquido (come si ricava anche da Corte di cassazione, Sez. un., 11 ottobre 2022, n. 29593, che ha ritenuto erronea la sentenza del giudice di merito, che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione della pretesa basata sui costi oggetto di conguaglio prima che questi fossero determinati dalle autorità amministrative) e, pertanto, neppure spettano gli interessi disciplinati dall'art. 1282 del codice civile (C.d.S., Sez. II, n. 10185 del 2023).
8. Acqualatina, ancorché in via subordinata, ha più volte insistito per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione europea (in particolare, con l'art. 9 della dir. 60/2000) di una interpretazione del diritto nazionale per la quale vi sarebbero costi finanziari del gestore del servizio idrico non coperti sul piano tariffario anche dove non vi sia alcuna evidenza oggettiva di connessione tra il costo non coperto (ovvero il fatto generativo del conguaglio) e una possibilità potere di intervento o incidenza da parte del gestore.
8.1. Ritiene il Collegio che il rinvio pregiudiziale non sia necessario.
A differenza dei tradizionali rimedi processuali ispirati ad una logica prettamente verticale, il rinvio pregiudiziale è un meccanismo di «coordinamento», attraverso il quale la Corte di giustizia supporta i giudici nazionali a cui è affidato, in massima parte, l'onere di garantire il controllo giurisdizionale nell'ordinamento giuridico europeo (sentenza del 27 febbraio 2018, C-64/16, par. 32).
L'istituto, quale «chiave di volta» del sistema giurisdizionale dell'Unione, è volto ad instaurare «un dialogo da giudice a giudice», tra la Corte e i giudici degli Stati membri, al fine di assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, garantendone la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia (sentenza del 6 marzo 2018, C-284/16, punto 37).
Il sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali «è estraneo ad ogni iniziativa delle parti», le quali «non possono privare i giudici nazionali della loro indipendenza [...] obbligandoli a presentare una domanda di pronunzia pregiudiziale» (sentenze del 18 luglio 2013, C-136/12, punto 28; 3 giugno 2021, C-910/19, punto 22).
L'«applicazione» del diritto dell'Unione spetta ai giudici nazionali, mentre il rinvio alla Corte di giustizia è richiesto solo ove sorgano dubbi sulla sua «interpretazione» (sentenze del 9 settembre 2015, C-160/14, punto 37; 5 dicembre 2017, C-42/17, punto 23): il giudice, anche di ultima istanza, non è tenuto automaticamente ad effettuare un rinvio alla Corte ogni volta che si trovi ad applicare il diritto dell'Unione.
Con giurisprudenza costante, la Corte ha chiarito che l'obbligo del giudice nazionale di ultima istanza non sussiste se:
a) la questione di interpretazione di norme comunitarie non è pertinente al giudizio (vale a dire nel caso in cui la soluzione non possa in alcun modo influire sull'esito della lite);
b) la questione è identica ad altra già decisa dalla Corte o comunque il precedente risolve il punto di diritto controverso;
c) la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione (sentenze del 6 ottobre 1982, in C-283/81, Cilfit; 5 settembre 2005, C-495/03, punto 33; 4 ottobre 2018, C-416/17, punto 110).
La configurabilità di quest'ultima ipotesi (denominata dell'«atto chiaro») deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione (sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19).
Alla luce delle ultime pronunce della Corte europea, la condizione secondo cui il giudice nazionale deve aver maturato il convincimento che la stessa soluzione si imporrebbe, con la stessa evidenza, anche ai giudici supremi di altri Stati membri, non impone al giudice di uno Stato membro di «dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione» (ordinanze del 15 dicembre 2022, C-144/22, Eredi Raimondo Bufarini S.r.l.; 15 dicembre 2022, C-597/21, Centro Petroli Roma S.r.l.), costringendolo ad effettuare ricerche in lingue straniere e su sistemi giuridici che non conosce.
La Corte di giustizia sottolinea solo la necessità che il giudice tenga conto di eventuali precedenti di Corti supreme nazionali o di eventuali evidenti difformità interpretative, di cui sia a venuto conoscenza, come fatto notorio o in quanto allegato dalle parti in causa.
In questi casi, infatti, sussisterebbe un dubbio ragionevole sull'interpretazione della norma europea.
Analoghe considerazioni valgono anche per il caso di difformità (conosciute dal giudice per fatto notorio, o in quanto allegate dalle parti) fra le diverse versioni linguistiche della norma europea da applicare.
Su queste basi, le regole sull'«atto chiaro» risultano coerenti con i principi costituzionali (art. 111, comma secondo, Cost.) ed europei (art. 47, comma 2, CDFUE) sulla ragionevole durata del processo e sulla indipendenza della magistratura (art. 101, comma 2, Cost.; art. 47, comma 2, CDFUE; art. 6, comma 1, CEDU).
8.2. Rilevano dunque le considerazioni sopra esposte nei paragrafi 7 e seguenti per le quali non può sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che il diritto dell'Unione non imponga di riconoscere, in materia tariffaria, oneri finanziari sui conguagli ulteriori rispetto al tasso di inflazione, qualora sia comunque garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione, fermo restando che il giudice nazionale è l'unico competente a conoscere i fatti della controversia ed a valutare se il metodo tariffario in esame consenta l'equilibrio economico finanziario della gestione.
La normativa europea in materia di acque non contiene indicazioni rigide sull'organizzazione del servizio idrico.
La Corte di giustizia ha più volte rimarcato come la direttiva 2000/60 sia una direttiva quadro adottata sul fondamento dell'art. 175, paragrafo 1, CE (divenuto art. 192 TFUE). Essa stabilisce principi comuni e un quadro globale di azione per la protezione delle acque e comporta il coordinamento, l'integrazione e, nel lungo periodo, lo sviluppo ulteriore dei principi generali e delle strutture idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque nell'Unione europea.
I principi comuni e il quadro globale definiti dalla direttiva devono essere sviluppati ulteriormente dagli Stati membri, i quali sono tenuti ad adottare misure specifiche (per mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno dell'Unione) entro i termini assegnati dalla direttiva stessa.
Tuttavia quest'ultima non persegue un'armonizzazione totale delle normative degli Stati membri in materia di acque (cfr. sentenze del 30 novembre 2006, C‑32/05, punto 41; 11 settembre 2014, C‑525/12, punto 50; 7 dicembre 2016, C‑686/15).
Secondo la Corte di giustizia, gli Stati membri - qualora rispettino l'obbligo di recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e quelli relativi alle risorse - possono scegliere tra i diversi modi di tariffazione quelli che più si confanno alla loro situazione specifica nell'ambito del potere discrezionale ad essi lasciato dalla direttiva 2000/60, che non impone alcuna precisa modalità di tariffazione (sentenza 7 dicembre 2016, C‑686/15, punto 23)
La direttiva 2014/23/UE, all'art. 2, paragrafo 1, a sua volta, ribadisce che le Autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.
Rispetto ai profili menzionati non sono state allegate dalle parti, né sono altrimenti conosciute da questo Collegio, difformità interpretative da parte di altre Corti europee ovvero discrepanze fra le diverse versioni linguistiche della normativa europea.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Adunanza plenaria enuncia i seguenti principi di diritto:
1) «Il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario:
a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari;
c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero».
2) «L'equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all'operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione».
9.1. Non è necessario restituire il giudizio alla sezione remittente, ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p.a., in quanto i principi enunciati consentono di definire l'intera materia controversa.
Difatti, nell'atto di appello n. 537 del 2023, l'Autorità ha proposto un unico motivo di censura avverso la sentenza appellata n. 2493 del 2022, che ha annullato la disciplina dei conguagli del MTI2 nella parte in cui non riconosceva sugli stessi il rimborso degli oneri finanziari, ma solo il tasso di inflazione.
A sua volta, nell'atto di appello n. 4339 del 2023, Siciliacque ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. unicamente in relazione al capo che ha deciso, rigettandolo, il terzo motivo di ricorso inerente al mancato riconoscimento degli oneri generali sui conguagli.
9.2. Va quindi accolto l'appello proposto dall'Autorità nell'ambito del giudizio con Acqualatina s.p.a. (n.r.g. 537 del 2023) e va respinto l'appello proposto da Siciliacque s.p.a. (n.r.g. 4939 del 2023).
10. Per quanto riguarda il regime delle spese, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado, con riguardo all'appello n. 4939 del 2023 del ruolo della Sezione Seconda, e per compensare le spese del doppio grado di giudizio, con riferimento all'appello n. 537 del 2023 del ruolo della Sezione Seconda.
10.1. Le spese della CTU disposte dalla Sezione Seconda nel giudizio n. 537 del 2023 sono poste a carico di Acqualatina. Le spese della CTU disposta dall'Adunanza plenaria sono poste a carico di Acqualatina e Siciliacque, in solido tra loro nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti interni, e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- enuncia i principi di diritto di cui al punto 9) del considerato in diritto della motivazione;
- accoglie il ricorso n. 9 del 2024 del ruolo dell'Adunanza plenaria (n. 537 del 2023 del ruolo della Sezione Seconda), proposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge in parte qua il ricorso di primo grado;
- respinge il ricorso n. 2 del 2024 del ruolo dell'Adunanza plenaria (n. 4939 del 2023 del ruolo della Sezione Seconda), proposto dalla s.p.a. Siciliacque e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio, con riferimento all'appello n. 9 del 2024 del ruolo dell'Adunanza plenaria (n. 537 del 2023 del ruolo della Sezione Seconda);
- compensa le spese del presente grado, con riguardo all'appello n. 2 del 2024 del ruolo dell'Adunanza plenaria (n. 4939 del 2023 del ruolo della Sezione Seconda).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2493/2022, e sez. I, sent. n. 499/2023.