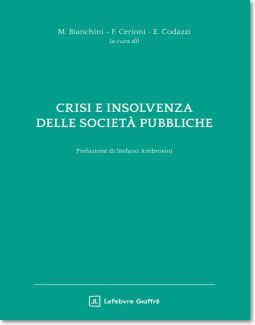Corte costituzionale
Sentenza 16 ottobre 2025, n. 152
Presidente: Amoroso - Redattore: Antonini
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 1° marzo 2025, depositato in cancelleria il successivo 5 marzo, iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2025 il Giudice relatore Luca Antonini;
uditi l'avvocata Almerina Bove per la Regione Campania, nonché gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni e Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ricorso notificato il 1° marzo 2025 e depositato il successivo 5 marzo (reg. ric. n. 13 del 2025), la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato l'art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione.
1.1.- Delle suddette disposizioni, le prime sei prevedono e disciplinano una misura di concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali, così articolata:
«784. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui al comma 788 gli enti in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724. [...]
786. Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione. [...]
789. Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [...]. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo di cui al primo periodo del presente comma è iscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario. [...] La costituzione del fondo, sul quale non è possibile disporre impegni, è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.
790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto. [...]
792. Entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 del presente articolo e dell'accantonamento di cui al comma 789 del presente articolo. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per gli enti di cui al secondo periodo è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi trenta giorni, tali enti sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:
a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo;
b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788.
793. Per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento con le modalità previste dal comma 792. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate».
1.2.- Le altre disposizioni impugnate, i commi 796 e 797, lettere a) e d), incidono rispettivamente sui commi 139 e 134 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), prevedendo, il primo, la riduzione di contributi agli investimenti dei comuni e, il secondo, l'azzeramento di quelli assegnati alle regioni.
In particolare, il citato comma 796 riduce «di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030» l'autorizzazione di spesa per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, mentre il successivo comma 797 determina la soppressione, a decorrere dall'anno 2027, delle assegnazioni alle regioni a statuto ordinario per investimenti, in precedenza previste fino all'anno 2034 per complessivi 2.376,5 milioni di euro e la sostituzione della Tabella 1, che determina gli importi spettanti a ciascuna regione a valere su tali contributi, con una nuova Tabella, contenuta nell'Allegato II della stessa legge n. 207 del 2024.
1.3.- Il ricorso segnala anzitutto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel parere reso sul testo del disegno di legge di bilancio 2025, ha evidenziato profili critici del contributo alla finanza pubblica, in quanto aggiuntivo rispetto a quelli già stabiliti dalle precedenti manovre di bilancio e quindi difficilmente sostenibile per le regioni, per la maggioranza delle quali sarebbe, peraltro, risultata inattuabile la disposizione che consente di utilizzare gli accantonamenti in bilancio per finanziare investimenti.
Aggiunge che tali rilievi sono stati ribaditi nella nota del 30 gennaio 2025, con la quale la citata Conferenza, nel comunicare l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento tra le regioni sul riparto del contributo esclusivamente per l'anno 2025, ha chiesto l'avvio di un confronto con lo Stato per gli anni 2026 e seguenti, nonché la convocazione in tempi rapidi della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in quanto sede di coinvolgimento degli enti territoriali richiamata dalla sentenza n. 195 del 2024 di questa Corte.
Ciò premesso, la Regione ricorrente ricorda di essere impegnata a recuperare un consistente disavanzo di amministrazione, risalente all'esercizio finanziario 2015, mediante un piano di rientro che incide sui bilanci di previsione con una quota annua pari a più di centoventotto milioni di euro, e sottolinea che, alla data del 31 dicembre 2023, la riduzione conseguita è maggiore rispetto all'obiettivo risultante dal piano.
2.- Introducendo i motivi di impugnazione, il ricorso rileva che sebbene l'art. 1, comma 784, della legge n. 207 del 2024 qualifichi espressamente le previsioni di cui ai successivi commi da 785 a 794 come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», l'importo, le modalità e i termini di contribuzione delle regioni alla finanza pubblica previsti dalle disposizioni impugnate non sarebbero qualificabili come tali alla luce degli approdi, anche recenti, della giurisprudenza costituzionale.
Nel complesso, infatti, le disposizioni statali: a) imporrebbero «una specifica modalità di contribuzione alla finanza pubblica» - mediante l'accantonamento di ingenti risorse con conseguente «uso vincolato delle stesse» - che si aggiunge alle altre già in corso «senza prevedere alcuna verifica istruttoria sulla congruità rispetto agli obiettivi e sulla sostenibilità della misura imposta»; b) sottrarrebbero «alle Regioni in disavanzo la facoltà di utilizzare» le suddette risorse finanziarie; c) in maniera irragionevole e contraria ai principi di eguaglianza sostanziale e di capacità contributiva non distinguerebbero la posizione delle regioni già impegnate nel rientro dal disavanzo da quella delle regioni non in disavanzo, imponendo solo alle prime una ulteriore sottrazione di risorse, a discapito delle comunità amministrate; d) prevederebbero «gravose sanzioni» per la mancata attuazione della misura, senza rispettare il principio di leale collaborazione; e) sopprimerebbero risorse destinate a investimenti, in contraddizione con il vincolo a conseguire un determinato livello di spesa di tale natura, per le regioni impegnate nel rientro dal disavanzo.
2.1.- Con un primo gruppo di questioni, quanto ai commi 784, 786 e 789 dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024, il ricorso si duole che il legislatore abbia «omesso del tutto di imporre il doveroso approfondimento istruttorio» sulla sostenibilità dell'importo del contributo da parte degli enti ai quali è stato richiesto, pur a fronte della sollecitazione, allo stesso rivolta da questa Corte nella sentenza n. 195 del 2024, a coinvolgere, al fine di rispettare il principio di leale collaborazione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
La misura di contribuzione introdotta, pertanto, risulterebbe «del tutto arbitraria e irragionevole ed illegittima» alla stregua degli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.
Inoltre, il comma 786, prevedendo un accordo tra le regioni in sede di autocoordinamento in ordine al riparto del contributo, non assicurerebbe il rispetto sostanziale del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dal momento che la «precisa individuazione degli importi del contributo alla finanza pubblica» che le regioni debbono assicurare per ogni annualità lascerebbe alle regioni stesse «solo un formale margine di discrezionalità», vincolandole ad attenersi a criteri di riparto discendenti «da condizioni di mero fatto».
La stessa disposizione, nella parte in cui disciplina il meccanismo di riparto in assenza di accordo tra le regioni, violerebbe i parametri costituzionali evocati «commisura[ndo] asetticamente» l'ammontare del contributo alla grandezza finanziaria della spesa corrente, senza considerare l'effettiva capacità di contribuzione alla spesa pubblica di ciascuna regione, non essendovi alcun legame diretto tra quest'ultima e l'importo della spesa corrente, preso a riferimento dalla norma.
Al riguardo, richiamando i dati di una relazione della direzione generale per le risorse finanziarie della Regione Campania, il ricorso evidenzia che il meccanismo dei contributi alla finanza pubblica avrebbe inciso sulla possibilità per la Regione «di svolgere le proprie finalità istituzionali», costringendola, al fine di ripianare i disavanzi, ad attivare la leva fiscale. Con il risultato che nel periodo dal 2015 al 2023 le risorse aggiuntive ottenute dagli incrementi delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non sarebbero state utilizzate «per erogare maggiori servizi ai cittadini, ma per finanziare il concorso della Campania agli obiettivi di finanza pubblica».
2.2.- Con un secondo motivo di ricorso, l'art. 1, comma 790, della legge n. 207 del 2024 è impugnato nella parte in cui, differenziando significativamente l'utilizzo del fondo di cui al comma 789, nel quale va accantonato l'importo del contributo alla finanza pubblica, a seconda che la regione si trovi o meno «in situazione di disavanzo di amministrazione», realizzerebbe una «illogica quanto evidente disparità di trattamento tra Regioni», in contrasto con il principio di eguaglianza, e produrrebbe effetti sulle comunità amministrate, determinando un ulteriore ampliamento delle disuguaglianze tra cittadini, a seguito dell'incremento della sperequazione infrastrutturale e dei conseguenti effetti sul prodotto interno lordo (PIL) regionale, svantaggiando, in contrasto con i principi costituzionali, i territori con minore capacità contributiva.
In modo doppiamente paradossale, le regioni che più contribuiscono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, contraendo maggiormente la spesa corrente, verrebbero penalizzate dal divieto di utilizzare i risparmi così ottenuti per finanziare spesa in conto capitale; inoltre, le regioni «già in disavanzo» verrebbero a disporre di minori risorse «per rilanciare il PIL regionale» e, con esso, le entrate del bilancio dell'ente.
Pertanto, in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., che imporrebbe la previsione di misure legislative compensative o correttive delle differenti posizioni originarie, la disposizione in esame contribuirebbe piuttosto «ad aggravare le disuguaglianze già presenti (e scaturenti da condizioni ataviche)».
Sarebbe violato altresì il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., precludendo l'utilizzo dell'accantonamento per finanziare investimenti anche alle regioni, come la Campania, che già sono obbligate a incrementare i pagamenti annui per investimenti in forza della disciplina del ripiano del disavanzo di cui all'art. 1, commi 779 e 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
Tutte le suddette censure presenterebbero «chiari riverberi nella sfera di attribuzioni regionali costituzionalmente garantita», posto che la denunciata violazione di parametri costituzionali verrebbe a menomare le autonomie e prerogative regionali riconosciute dagli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., impedendo di esercitare l'autonomia regionale di programmazione e di spesa e, addirittura, di assolvere gli obblighi di investimento connessi al regime di rientro dal disavanzo.
2.2.1.- Il ricorso argomenta «un ulteriore profilo di disparità di trattamento» della disposizione di cui al suddetto comma 790, osservando che la possibilità riconosciuta agli enti non in disavanzo di utilizzare l'importo del contributo per finanziare investimenti nell'esercizio successivo comporterebbe «un costo per l'erario», specificato dalla relazione tecnica al disegno di legge governativo per gli anni dal 2026 al 2035. Tuttavia, le regioni in disavanzo non potrebbero «accedere al riparto delle risorse destinate agli investimenti», nei limiti delle capacità del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost.
Sarebbe dunque costituzionalmente illegittima la previsione secondo la quale l'onere relativo al contributo di finanza pubblica è ripartito, ai sensi dell'art. 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024, tra tutti gli enti, sia in avanzo, sia in disavanzo, mentre «il beneficio correlato alla copertura a carico del bilancio dello Stato per spese di investimento», in base all'impugnato comma 790, va a favore dei «soli enti che presentano un avanzo».
2.2.2.- Il terzo periodo del richiamato comma 790 presenterebbe «ulteriori ed autonomi profili di illegittimità» costituzionale, prevedendo in maniera ritenuta irragionevole e arbitraria che, ai fini della individuazione degli enti ammessi a utilizzare il contributo per finanziare investimenti, «le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto» (in seguito, anche: DANC).
Al riguardo, la Regione ricorrente osserva che per effetto della citata disposizione il PIL delle regioni non in disavanzo oppure «in disavanzo solo da debito autorizzato e non contratto» risulterebbe incrementato, a seguito dell'ampliamento della capacità di spesa, sia corrente, sia di investimento, generato dalla disposizione medesima; all'opposto, il PIL delle regioni in disavanzo si contrarrebbe.
A sostegno della censura è richiamata la sentenza n. 274 del 2017 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di una legge regionale di assestamento al bilancio perché, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., aveva previsto l'applicazione al bilancio di una quota di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, pur in presenza di un risultato negativo, avendo erroneamente considerato quale componente attiva, tra l'altro, la voce del «complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti che, invece, [...] si concretano in cespiti inesistenti».
Pertanto, rileva il ricorso, laddove l'istituto del DANC determini disavanzo, questo «deve essere trattato come tale», come sarebbe confermato dalla esistenza di «una precisa modalità di recupero della quota di disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», contenuta nei principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria (è citato il paragrafo 5.3.4-bis dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»).
Non si comprenderebbero, dunque, le motivazioni del trattamento differenziato previsto dalla disposizione in esame, tanto più considerando che, invece, nel disciplinare il contributo alla finanza pubblica stabilito dalla legge di bilancio 2024, il legislatore avrebbe espressamente ricompreso il disavanzo da DANC nel disavanzo di amministrazione, prescrivendo alle regioni in tale situazione di appostare nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 un fondo pari all'importo del contributo dovuto e di destinare l'economia, registrata nel rendiconto dello stesso esercizio, a riduzione del suddetto disavanzo (in base al disposto dell'art. 1, comma 527-ter, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», inserito dall'art. 19, comma 1, lettera b, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 143).
In conclusione, risulterebbero violati gli artt. 3, 81, 97 e 119 Cost.; il contrasto con quest'ultimo darebbe conto altresì della ridondanza della lesione della sfera di attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente, impegnata nel piano di recupero del disavanzo, in considerazione degli effetti negativi della disposizione in esame sul PIL regionale e sulle condizioni economiche e sociali dei cittadini del proprio territorio.
2.3.- Secondo quanto argomentato nel terzo motivo di ricorso, le disposizioni di cui ai commi 792 e 793 dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024 violerebbero gli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., prevedendo «gravose sanzioni, in termini di incremento del contributo alla finanza pubblica», per le ipotesi del mancato accantonamento in bilancio dello stesso e della mancata trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente.
Esse, in particolare: a) «aggrav[erebbero] l'importo del contributo in mancanza di un'effettiva necessità sul piano economico-finanziario», ma solo quale conseguenza «diretta ed automatica del mancato rispetto dei termini sanciti»; b) ometterebbero di prevedere che sia la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a determinare «la quantificazione» o a concorrere a tale operazione; c) violerebbero la ratio del contributo, dal momento che il relativo incremento sarebbe quantificato «senza alcuna attività istruttoria in ordine alla concreta sostenibilità» da parte della regione interessata, la quale non verrebbe coinvolta «nel procedimento», peraltro nemmeno delineato, in quanto la disposizione configurerebbe una sanzione automatica.
2.4.- Con l'ultimo motivo sono, infine, impugnati i commi 796 e 797, lettere a) e d), dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024, i quali, rispettivamente, incidono sui commi 139 e 134 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018.
Il ricorso osserva che le suddette previsioni hanno messo a disposizione di regioni e comuni risorse statali, «a prescindere dalla condizione finanziaria» di tali enti, per una serie di finalità concernenti diritti dei cittadini - quali la sicurezza, la mobilità, la riduzione dell'inquinamento - e prevedendo una priorità di assegnazione per i comuni del Mezzogiorno.
Tuttavia, per effetto delle disposizioni impugnate, il finanziamento statale destinato alle regioni risulta soppresso a partire dall'anno 2027 - facendo così venire meno lo stanziamento già previsto nel bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 della Regione Campania, per l'esercizio 2027, per circa 32 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al richiamato art. 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018 -, mentre quello rivolto ai comuni è stato ridotto in misura consistente.
Tali previsioni, oltre a porsi esse stesse in contrasto con tutti i parametri evocati «per le medesime ragioni svolte con riferimento ai precedenti commi», espressamente richiamate, renderebbero «evidente la fondatezza» delle censure specificamente articolate nei confronti delle disposizioni degli impugnati commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, in particolare, sotto i profili della irragionevolezza e arbitrarietà, nonché della carenza di istruttoria.
Il ricorso sottolinea che, con riferimento alla combinazione delle suddette misure - dei tagli ai trasferimenti e dell'ampliamento della spesa per investimenti - previste nel disegno di legge governativo, l'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'audizione alle Commissioni bilancio, riunite, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del 5 novembre 2024 ha segnalato gli effetti netti «complessivamente negativi» sulla spesa in conto capitale degli enti territoriali.
Osserva infine che, al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di cofinanziamento regionale dei programmi finanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, la Regione Campania, dopo oltre un decennio dall'ultima accensione di prestiti, «ha dovuto autorizzare il ricorso all'indebitamento» con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, sostenendo pertanto i costi correlati al servizio del debito. Sotto questo profilo, l'impossibilità di utilizzare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 penalizzerebbe le regioni svantaggiate.
In conclusione, i commi 796 e 797, lettere a) e d), dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024, anche in combinato disposto con il precedente comma 790, violerebbero gli artt. 3, 97 e 119, nonché gli artt. 81 e 120 Cost., dovendosi ritenere oggettiva ed evidente la ridondanza della lesione nella sfera delle attribuzioni regionali, anche perché le disposizioni indicate, omettendo di prevedere «strumenti perequativi» e, anzi, realizzando «un meccanismo proteso ad acuire le disparità tra territori», contribuirebbero «alla perpetrazione e cristallizzazione di condizioni di fatto» tali da limitare, per le regioni più svantaggiate, l'esercizio delle prerogative costituzionali.
3.- Con atto depositato il 10 aprile 2025 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
3.1.- Con le disposizioni impugnate lo Stato avrebbe inteso stabilire le modalità di partecipazione degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea.
Considerata la necessità di rispettare a livello nazionale la traiettoria dell'indicatore della spesa netta, il legislatore statale, mediante norme qualificabili come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, si sarebbe limitato a determinare complessivamente il contributo richiesto alle regioni a statuto ordinario, lasciando alle stesse adeguati margini di autonomia sulle voci di spesa alle quali applicare i risparmi, come emergerebbe dal meccanismo descritto dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, il quale non indicherebbe «misure specifiche di riduzione, che sono rimesse all'autonomia di bilancio del singolo ente». Peraltro, già in sede di riparto del contributo, la previsione che questo sia effettuato sulla base dell'accordo tra le regioni stesse, in sede di autocoordinamento, lascerebbe «ampi spazi di libertà» sugli ambiti su cui incidere; anche nell'ipotesi dell'intervento sostitutivo statale non sarebbero stati aggiunti vincoli in ordine ai settori sui quali concentrare i contenimenti di spesa, venendo anzi esclusi quelli maggiormente inerenti ai diritti sociali.
L'Avvocatura generale, prospettata l'inammissibilità delle questioni promosse in riferimento all'art. 53 Cost., «non vertendosi in materia tributaria», ritiene rispettate, nella specie, le condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale per la previsione di legittimi principi di coordinamento finanziario. Infatti, le revisioni della spesa sarebbero temporanee ed assicurerebbero il coinvolgimento degli enti territoriali in ossequio al principio di leale collaborazione.
Quanto alla censura sulla sostenibilità del contributo da parte delle regioni, la difesa statale rileva che la ricorrente non avrebbe fornito la prova di non potere farvi fronte e che, in ogni caso, il rapporto del contributo a carico della Regione Campania rispetto al totale della spesa corrente del bilancio regionale «non [sarebbe] tale da incidere sulla capacità dell'ente di assolvere ai suoi compiti istituzionali».
Anche le censure mosse ai commi 796 e 797, lettere a) e d), dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024 andrebbero rigettate, dovendosi valutare l'effetto della revisione dei contributi, da questi disposta nei confronti delle regioni e dei comuni, «tenendo conto delle risorse straordinarie assegnate ai medesimi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare».
3.2.- La difesa statale contesta anche la fondatezza della censura che, interpretando la sentenza n. 195 del 2024 di questa Corte, ritiene violato il principio di leale collaborazione, per avere le disposizioni impugnate omesso di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La suddetta pronuncia, infatti, non sarebbe riconducibile alla categoria delle decisioni di illegittimità costituzionale accertata ma non dichiarata, costituendo, piuttosto, «un'espressione più blanda dei poteri di indirizzo esercitabili dalla Corte nei riguardi del legislatore».
3.3.- La stessa sentenza, nella parte in cui ha ricordato la necessità che il ripiano dei disavanzi avvenga in tempi contenuti, varrebbe a confutare la doglianza mossa al diverso trattamento riservato alle regioni in disavanzo di amministrazione, impossibilitate a utilizzare le risorse del contributo alla finanza pubblica per finanziare investimenti.
D'altro canto, guardando all'obiettivo finale e unitario che la disciplina dell'impugnato comma 790 concorre a perseguire, essa consentirebbe di realizzare obiettivi a favore degli enti territoriali, quali «il riequilibrio dei bilanci degli enti in crisi finanziaria» e «la riqualificazione della spesa e il sostegno alla crescita» di quelli non in disavanzo.
3.4.- Non sarebbe, poi, irragionevole né arbitraria la prevista esclusione della quota del disavanzo derivante da DANC dal meccanismo applicativo del richiamato comma 790, date le «caratteristiche di tale forma di disavanzo, funzionali alle esigenze del percorso di aggiustamento dei conti pubblici» richieste dalle nuove regole economiche europee.
Infatti, diversamente dalle altre forme di disavanzo di amministrazione, quello derivante da DANC «favorisce la realizzazione di investimenti senza incrementare il debito pubblico ed è destinato a essere ripianato senza determinare riduzioni di spesa corrente, attraverso il ricorso a nuovo debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».
Nemmeno sarebbe significativo il richiamo, da parte della Regione ricorrente, al trattamento riconosciuto al disavanzo derivante da DANC dall'art. 1, comma 527-ter, della legge n. 213 del 2023, essendo stata questa disposizione definita «nelle more delle nuove regole della governance europea».
3.5.- Infine, sarebbero non fondate anche le censure mosse agli impugnati commi 792 e 793, i quali, disciplinando gli effetti sanzionatori del mancato rispetto dei termini previsti per l'attuazione del contributo alla finanza pubblica, costituirebbero misure «necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica» e non violerebbero l'art. 120 Cost., limitandosi a sanzionare un inadempimento da parte del singolo ente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 13 del 2025), la Regione Campania ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge n. 207 del 2024.
1.1.- In base alle prime sei disposizioni, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e dell'osservanza dei vincoli derivanti dalla nuova governance economica europea, attraverso disposizioni qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (comma 784) alle regioni a statuto ordinario è stato richiesto un contributo, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029 (comma 786, primo periodo) e il cui riparto è effettuato in sede di autocoordinamento tra le regioni, oppure, in assenza di accordo, mediante un provvedimento statale, in proporzione alla spesa corrente sostenuta da ciascuna regione, ma con l'esclusione, tra l'altro, dell'intero perimetro sanitario e delle spese della Missione 12, relativa a «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (comma 786, secondo e terzo periodo).
L'attuazione del contributo richiede alle regioni di comprimere la spesa corrente in ciascuno degli anni dal 2025 al 2029; ciò avviene mediante l'iscrizione in bilancio di un fondo di importo pari al contributo dovuto, sul quale non è possibile disporre impegni di spesa e che deve essere finanziato attraverso le risorse di parte corrente (comma 789).
Alla fine di ciascun esercizio il fondo in esame costituisce quindi un'economia, che, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione, contribuisce a ripianare tale disavanzo in misura aggiuntiva rispetto all'ordinario piano di rientro. Per gli enti non in disavanzo, invece, l'importo del contributo alla finanza pubblica, iscritto nel richiamato fondo, è destinato a finanziare investimenti nell'esercizio successivo. Ai fini dell'alternativa appena descritta le regioni considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto (comma 790).
La disciplina del contributo alla finanza pubblica è completata dalla previsione di una sanzione per gli enti inadempienti agli obblighi di accantonare il fondo e di trasmettere i rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (commi 792 e 793).
1.2.- In forza delle altre due previsioni impugnate, i commi 796 e 797, lettere a) e d), si determina, rispettivamente, la riduzione e la cancellazione di contributi per investimenti assegnati ai comuni e alle regioni a statuto ordinario dai commi 139 e 134 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018.
2.- La Regione impugna, anzitutto, con un primo gruppo di censure le disposizioni di cui ai commi 784, 786 e 789 dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024, che violerebbero, sotto vari profili, gli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.
2.1.- In via preliminare, va dichiarata inammissibile la questione promossa in riferimento all'art. 53 Cost., come esattamente eccepito dal Presidente del Consiglio dei ministri, trattandosi di un parametro inconferente rispetto alle disposizioni impugnate, non aventi a oggetto statuizioni tributarie ma principi di coordinamento finanziario applicabili agli enti territoriali.
2.2.- La prima censura lamenta, innanzitutto, il carattere di dettaglio delle previsioni contenute nelle suddette disposizioni, che non potrebbero quindi qualificarsi come principi fondamentali della materia, di competenza legislativa concorrente, «coordinamento della finanza pubblica».
La censura non è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal carattere transitorio» (ex plurimis, sentenza n. 195 del 2024).
In linea con tale giurisprudenza, il legislatore statale, con le disposizioni impugnate, si è limitato a determinare l'importo complessivo dei contributi richiesti, nel circoscritto arco temporale del quinquennio, alle regioni a statuto ordinario, lasciando alle stesse adeguati margini di autonomia sulle voci di spesa cui applicare i risparmi, dal momento che il relativo riparto è espressamente rimesso all'accordo tra le regioni in sede di autocoordinamento.
Peraltro, anche in assenza di tale accordo, l'intervento sussidiario dell'autorità statale si limita a quantificare gli importi complessivamente dovuti da ciascuna regione, senza aggiungere vincoli in ordine ai settori sui quali concentrare i contenimenti di spesa, salvo escludere quelli inerenti ai diritti sociali e alla sanità, e ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che richiede il rispetto della spesa costituzionalmente necessaria (da ultimo, ancora sentenza n. 195 del 2024).
Quanto alle modalità della contribuzione, va ricordato che questa Corte ha ricondotto nell'ambito dei principi di coordinamento anche norme puntuali, quando le stesse sono state adottate dal legislatore per realizzare in concreto la «finalità» del coordinamento finanziario (sentenza n. 78 del 2020): è, infatti, «il finalismo» (sentenza n. 38 del 2016) insito in tale genere di disposizioni che consente di escludere il ricorrere di una norma di dettaglio, qualora queste risultino legate da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione ai medesimi principi di coordinamento (ex plurimis, sentenza n. 137 del 2018).
Peraltro, la dinamica del contributo strutturata dalle disposizioni impugnate presenta importanti differenze rispetto a quella dei due precedenti contributi, previsti rispettivamente dalla legge di bilancio 2021 e, in origine, da quella 2024, che in realtà sono stati impostati in termini più invasivi dell'autonomia regionale: mentre questi disponevano un versamento diretto delle risorse proprie degli enti territoriali al bilancio dello Stato, quello ora in esame le mantiene al bilancio degli enti, sebbene vincolandone la destinazione.
Anche la disposizione sulle modalità di contribuzione è, da questo punto di vista, quindi idonea a perseguire correttamente l'obiettivo finalistico sotteso ai principi fondamentali del coordinamento dinamico della finanza pubblica.
2.3.- Un secondo profilo di censura fa derivare la violazione dei parametri evocati dal carattere aggiuntivo del contributo alla finanza pubblica, che si sommerebbe alle misure di coordinamento già in corso, senza che sia stata svolta una adeguata istruttoria sulla congruità e sulla sostenibilità della misura.
Al riguardo, la ricorrente precisa che il concorso richiesto alle regioni a statuto ordinario dalla legge di bilancio 2025 per gli anni dal 2025 al 2029 si sovrappone, per gran parte del periodo, a quello già introdotto dalla precedente legge di bilancio per gli anni dal 2024 al 2028 e, per l'anno 2025, anche a quello stabilito dalla legge di bilancio 2021 per il triennio 2023-2025.
In particolare, sotto il profilo della leale collaborazione, la ricorrente ritiene violata la sollecitazione rivolta al legislatore dalla sentenza n. 195 del 2024 di questa Corte sulla necessità del coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Nel merito, va rilevato che, in effetti, secondo la suddetta pronuncia tale coinvolgimento è funzionale a salvaguardare l'assetto costituzionale, e cioè «a scongiurare l'adozione di "tagli al buio", i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali, con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare. In relazione a questa esigenza e nella prospettiva della nuova governance economica europea, che prevede [...] anche l'allungamento temporale delle misure di contenimento della spesa netta menzionate nel Piano strutturale di bilancio, si palesa vieppiù la necessità di un ossequio sostanziale, e non meramente formale, al principio di leale collaborazione».
Erra quindi l'Avvocatura generale dello Stato quando afferma che la sollecitazione della richiamata sentenza costituirebbe «un'espressione più blanda dei poteri di indirizzo esercitabili dalla Corte».
Per effetto delle ricordate sovrapposizioni, il contributo complessivamente dovuto dalle regioni a statuto ordinario risulta pari a 805 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029.
Si tratta di importi considerevoli, che impattano in modo significativo sull'autonomia finanziaria delle regioni, la cui voce deve, necessariamente, essere almeno sentita nelle sedi appositamente preposte dall'ordinamento, anche al fine di poter fornire al Parlamento gli indispensabili elementi istruttori necessari per assumere le decisioni.
Altrimenti è forte il rischio che si scarichino eccessivamente sulle autonomie regionali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, frustrando così la stessa loro possibilità di porsi in termini generativi all'interno di quel pluralismo istituzionale che la Costituzione mira a garantire.
Ciò chiarito, tutte le censure devono tuttavia ritenersi non fondate, poiché la richiamata sentenza è stata depositata il 6 dicembre 2024, dopo quindi che le Commissioni bilancio delle due Camere avevano ormai acquisito gli elementi informativi sui contenuti del disegno di legge di bilancio con un ciclo di audizioni informali (svolte, sui temi della finanza degli enti territoriali, il 5 novembre 2024). Considerata la serrata scansione temporale per l'approvazione parlamentare della manovra di bilancio, può ritenersi che la pretesa di usufruire dell'apporto istruttorio fornito dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica non sarebbe stata in concreto esigibile prima dell'adozione della legge impugnata.
Il coinvolgimento della suddetta Conferenza permanente, per quanto prima precisato, deve però ritenersi certamente indefettibile già in riferimento alla prossima manovra di bilancio.
Conseguentemente, lo Stato non potrebbe in futuro invocare i tempi procedimentali serrati onde neutralizzare l'esigenza di un più compiuto coinvolgimento delle autonomie nell'iter di adozione delle decisioni fondamentali di finanza pubblica in sede di legge di bilancio.
2.4.- Non sono fondate le ulteriori censure incentrate sulla disciplina del riparto del contributo, riguardo sia alla grandezza della spesa pubblica, assunta a criterio in via sussidiaria in caso di mancato accordo, sia all'autocoordinamento che, secondo il ricorso, non lascerebbe adeguati margini di discrezionalità in capo alle regioni.
Sotto il primo profilo, la ricorrente allega i dati relativi alle risorse aggiuntive acquisite azionando la leva tributaria regionale sull'addizionale all'IRPEF e sull'IRAP, evidenziando che tali risorse, dato l'impatto dei contributi alla finanza pubblica nel periodo dal 2015 al 2023, non sarebbero state utilizzate «per erogare maggiori servizi ai cittadini, ma per finanziare il concorso della Campania agli obiettivi di finanza pubblica».
La censura in esame non coglie nel segno, perché adottando il criterio della spesa corrente, il legislatore ha inteso, in realtà, vincolare la discrezionalità dell'autorità ministeriale, alla quale è demandata la delicata operazione di riparto del contributo quando non sia stato raggiunto l'accordo in sede di autocoordinamento tra le regioni. A questi fini, tale grandezza poggia su un dato oggettivo, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, a sua volta riconducibile alle scelte gestionali autonomamente adottate dal singolo ente territoriale. Si tratta quindi di un indicatore finanziario idoneo a distribuire il carico del contributo tra gli enti e difficilmente surrogabile con altri; d'altro canto, nemmeno la ricorrente prospetta un criterio alternativo adeguato a evitare i vulnera evocati.
Va inoltre considerato che, siccome il censurato contributo alla finanza pubblica non sottrae risorse finanziarie alle regioni ma le mantiene al loro bilancio, non è pertinente il richiamo, così come formulato, all'utilizzo della leva fiscale.
Come già precisato, il nuovo contributo si differenzia dai precedenti; profilo del resto rilevato anche dall'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio: «[n]el recente passato il concorso degli Enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica è avvenuto attraverso diverse forme: ricorrendo ai tagli dei trasferimenti statali (come negli anni dal 2011 al 2015), prelevando le risorse proprie dei vari comparti e facendole affluire al bilancio dello Stato (come avvenuto per una parte del concorso a carico delle Province negli anni tra il 2011 e il 2015 e per le misure di spending review introdotte dal 2023 [...]) o imponendo agli Enti l'obbligo di conseguire avanzi positivi che venivano acquisiti a beneficio dei saldi di finanza pubblica (come quando vigeva il Patto di stabilità). Oltre che attraverso misure dirette, la spesa corrente è stata tenuta sotto controllo anche mediante interventi indiretti come, ad esempio, il blocco del turnover o l'imposizione di altri vincoli all'assunzione del personale» (documento dell'Ufficio parlamentare di bilancio, depositato in occasione dell'audizione del 5 novembre 2024).
Quanto al secondo profilo di censura, la previsione legislativa non lede il principio di leale collaborazione, dal momento che il riparto è espressamente rimesso all'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento, attraverso la Conferenza delle regioni e delle province autonome, «lasciando così anche ampi spazi di libertà in riferimento agli ambiti su cui intervenire» (ancora, sentenza n. 195 del 2024).
3.- La Regione impugna, poi, con il secondo motivo di ricorso, il comma 790, che violerebbe, sotto vari profili, gli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., prescrivendo modalità diverse, a seconda della presenza o meno di disavanzo, di utilizzo del fondo appostato in bilancio per un importo pari al contributo alla finanza pubblica dovuto.
3.1.- Rispetto all'ordine di illustrazione delle censure del motivo di ricorso, è logicamente prioritario l'esame di quelle mosse al terzo periodo della suddetta disposizione, in forza del quale «[a]i fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto», dovendosi valutare anzitutto la legittimità costituzionale di tale criterio.
Al riguardo, la ricorrente lamenta che, stabilendo lo scomputo dall'importo del disavanzo di amministrazione della quota derivante da DANC, la disposizione violerebbe gli artt. 3, 81, 97 e 119 Cost., differenziando il trattamento di tale tipologia di disavanzo in maniera irragionevole e in contrasto con i principi di equilibrio di bilancio.
La questione è ammissibile, in quanto è stato chiaramente individuato l'ambito di competenza legislativa indirettamente inciso dalla disciplina statale e adeguatamente illustrato il requisito di ridondanza, evidenziando, inoltre, l'interesse della ricorrente a fare valere la censura, che deriverebbe dalla necessità di una par condicio tra le regioni nell'adozione di misure statali di coordinamento finanziario (sentenze n. 192, punto 8.1. del Considerato in diritto, e n. 139 del 2024, punto 2.2. del Considerato in diritto).
La censura non è però fondata.
È ben vero che questa Corte, nella sentenza n. 274 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge regionale di assestamento al bilancio dell'esercizio finanziario 2016, perché, in violazione dell'obbligo di copertura di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., aveva applicato al bilancio di quell'esercizio una quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, laddove, invece, tale risultato doveva ritenersi di segno negativo, essendosi erroneamente considerato quale componente attiva, tra l'altro, «il complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti che, invece, [...] si concretano in cespiti inesistenti»: la sentenza, aveva infatti richiamato le patologie cui l'istituto dei suddetti mutui autorizzati ma non contratti aveva dato luogo nella prassi delle regioni.
Ciò è quanto emerge dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 40 del d.lgs. n. 118 del 2011 - aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - e dell'art. 1, comma 688-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».
Tuttavia, va precisato che a tale conclusione la sentenza perveniva sulla base della disciplina contabile allora applicabile, dove la pratica dell'autorizzazione alla contrazione di mutui poi non stipulati era stata interdetta dal legislatore statale, il quale, al contempo, con un intervento eccezionale, aveva dettato una disciplina temporanea che, prendendo atto dei dissesti pregressi, ha consentito il recupero dei prestiti già autorizzati in passato ma non perfezionati e ciò solo fino alla fine dell'esercizio 2016.
Tale disciplina, successivamente alla citata sentenza, è stata però innovata con l'art. 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, che, inserendo il comma 2-bis nell'art. 40 del d.lgs. n. 118 del 2011, ha reintrodotto nell'ordinamento contabile delle regioni l'istituto del DANC «con l'obiettivo di favorire la realizzazione degli investimenti pubblici, senza far crescere il debito pubblico, e risparmiando la spesa per interessi» (A.C. n. 1334 - XVIII Legislatura - Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio 2019, in riferimento all'art. 70).
Accanto a tale disposizione, che, per evitare il rischio di tensioni di liquidità di cassa, condiziona espressamente al rispetto da parte della regione dei tempi di pagamento delle obbligazioni commerciali il ricorso allo strumento del DANC, il successivo comma 938, «[a]l fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto», ha immesso nello stesso d.lgs. n. 118 del 2011, all'art. 11, comma 6, lettere d-bis) e d-ter), la previsione di puntuali adempimenti di trasparenza contabile.
Alle regioni è quindi imposto di elencare nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto sia gli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto, sia gli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione.
In conclusione, rispetto alle affermazioni contenute nella richiamata sentenza n. 274 del 2017, il quadro normativo attualmente in vigore, per un verso, registra nuovamente un istituto che ammette la copertura delle spese di investimento con una modalità derogatoria della ordinaria necessità di utilizzare entrate giuridicamente accertate (tali non potendosi considerare, per definizione, quelle consistenti in mutui da contrarre); per altro verso, tuttavia, risulta avere circoscritto l'impiego del DANC mediante la previsione di diverse misure precauzionali, prima non considerate.
Non può quindi ritenersi manifestamente irragionevole la scelta legislativa di scomputare la quota di disavanzo da DANC dal meccanismo del comma 790 dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024, la cui ratio è quella di velocizzare il rientro dei disavanzi per i quali l'ordinamento prevede il ripiano in un tempo certo.
Per il ripiano di quello da DANC non vale, infatti, la regola, stabilita in via generale dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, che impone il recupero del disavanzo nel primo esercizio in corso di gestione alla data dell'approvazione del rendiconto, oppure nei due successivi esercizi del triennio del bilancio di previsione, e comunque non oltre la durata della legislatura.
In sostanza, poiché la quota di disavanzo derivante da DANC può essere coperta «con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa» (art. 40, comma 2-bis, del d.lgs. n. 118 del 2011), finché queste esigenze non divengano attuali, l'obbligo di ripiano rimane "sospeso".
La suddetta conclusione non è contraddetta dalla previsione - segnalata dalla ricorrente nel tentativo di evidenziare l'irragionevolezza della disposizione impugnata - dell'art. 1, comma 527-ter, della legge n. 213 del 2023, come novellata, che ha consentito alle regioni «in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023», compreso anche il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, di assolvere il contributo alla finanza pubblica, anziché nella forma, originariamente prevista, del versamento diretto al bilancio dello Stato, attraverso l'accantonamento in un fondo diretto a ridurre appunto i disavanzi.
Quest'ultima previsione e quella impugnata hanno rationes diverse: la prima è stata, infatti, funzionale a consentire a tutte le regioni, comprese quelle in cui il disavanzo derivava solo da DANC, di accedere alla forma alternativa di corresponsione del contributo previsto; la seconda, invece, a permettere la spesa di investimento.
Ciò chiarito, tuttavia, rimane da segnalare la particolare prudenza che deve accompagnare la valorizzazione della prassi del ricorso al DANC, che, nonostante le nuove precauzioni introdotte, può comunque portare a distorsioni nell'utilizzo dei flussi di cassa, come rilevato, in sede di parifica del rendiconto generale della Regione Lombardia, esercizio 2024, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (decisione 17 luglio 2025, n. 230, relazione allegata, pagine 11-12).
3.2.- Secondo la ricorrente, l'impugnato comma 790, precludendo alle regioni in disavanzo di finanziare investimenti con il fondo accantonato in bilancio ai sensi del precedente comma 789, violerebbe, poi, anche i principi di eguaglianza, formale e sostanziale, di cui all'art. 3 Cost., aggravando le attuali differenze tra i territori regionali, nonché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., contraddicendo il vincolo, già esistente per le regioni in piano di rientro in forza dell'art. 1, comma 780, della legge n. 205 del 2017, ad assicurare un determinato livello di spesa per investimenti.
3.2.1.- Con riferimento al primo profilo, la censura regionale che pretende di conseguire, anche per le regioni in disavanzo, l'utilizzabilità dell'intero contributo per la spesa di investimento non è fondata. Questa Corte ha già evidenziato che l'obbligo di ripianare con sollecitudine i disavanzi di amministrazione «risponde anche al principio di responsabilità nell'amministrazione delle risorse della collettività territoriale» (sentenza n. 195 del 2024). La previsione impugnata, mirando a velocizzare la realizzazione del piano di rientro, non è dunque in sé irragionevole.
Tuttavia, occorre rilevare che, in effetti, il meccanismo previsto dal comma 790 si rivela eccessivamente rigido perché le regioni in disavanzo sono escluse del tutto dalla possibilità di utilizzare le risorse corrispondenti al contributo per finanziare investimenti, riservata esclusivamente alle regioni senza disavanzo di amministrazione (peraltro al netto, come si è visto, del disavanzo dal DANC).
Tale eccessiva rigidità determina esternalità negative sulla perequazione infrastrutturale tra le diverse regioni a statuto ordinario, dal momento che solo poche di esse nel corso del quinquennio di applicazione del contributo, dati i tempi di recupero dei disavanzi, potranno implementare la spesa di investimento.
È pur vero che nel periodo interessato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare sono stati stanziati, come dimostrato in udienza pubblica dall'Avvocatura generale dello Stato in risposta allo specifico quesito formulato da questa Corte ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, circa diciannove miliardi di euro di spesa di investimento per progetti che hanno come soggetti attuatori le regioni a statuto ordinario e che, pro capite, la spesa è stata maggiore in regioni come la Campania, anche in considerazione delle esigenze di perequazione infrastrutturale.
Tuttavia, è anche vero che l'orizzonte temporale dei suddetti Piani è destinato ad esaurirsi ben prima del quinquennio di riferimento del nuovo contributo e che nella stessa legge di bilancio 2025, con l'impugnato comma 797, sono stati cancellati specifici finanziamenti statali destinati agli investimenti delle regioni a statuto ordinario per importi rilevanti - difficilmente suscettibili di essere compensati dalla assegnazione del contributo alla spesa di investimento, che potrà realisticamente riguardare, come detto, poche regioni - in precedenza autorizzati fino all'anno 2034, e ora definanziati a partire dal 2027.
Del resto, sia nella audizione della Corte dei conti che in quella dell'Ufficio parlamentare di bilancio, già citate, sono state segnalate criticità al riguardo.
Nella prima, infatti, pur essendosi positivamente rilevato l'incremento dei fondi per il Servizio sanitario nazionale e per la perequazione comunale, nonché l'istituzione di un nuovo fondo - ma solo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato - per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, si è evidenziato il rischio, in riferimento al «periodo post PNRR», di «depotenziare fortemente la spinta impressa dalle progettualità» in esso previste e dell'acuirsi delle «divaricazioni nella dotazione di capitale tra aree territoriali» (documento della Corte dei conti, depositato in occasione dell'audizione del 5 novembre 2024, pagine 95-96).
Nella seconda, si è sottolineata «la mancata attuazione della L. 42/2009 per la parte relativa alla perequazione infrastrutturale», l'assenza di indicatori efficaci al fine di rilevare le criticità territoriali e l'esistenza di effetti netti «complessivamente negativi» sulla spesa in conto capitale degli enti territoriali (documento dell'Ufficio parlamentare di bilancio, depositato in occasione dell'audizione del 5 novembre 2024, pagine 134 e 136).
La totale preclusione per l'intero quinquennio dell'impiego per investimenti da parte delle regioni in disavanzo risulta, in effetti, potenzialmente idonea a determinare, al termine del periodo di applicazione del contributo alla finanza pubblica, eccessivi divari infrastrutturali tra i territori, a causa di una discriminazione tra le regioni che si può riflettere in un pregiudizio al principio di eguaglianza sostanziale.
Questa Corte, quindi, ritiene necessario sollecitare il legislatore, per le annualità successive a quella in corso, a rivedere, in una fisiologica dialettica con le regioni orientata al bene comune, l'eccessiva rigidità del meccanismo, consentendo anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento.
È pur vero che l'«obbligo di evitare la produzione di disavanzi e, comunque, di ripianarli in termini contenuti, secondo le modalità declinate dalle regole statali dell'armonizzazione contabile, consegue, da un lato, ai principi di buona amministrazione, di copertura delle spese e dell'equilibrio di bilancio» (sentenza n. 195 del 2024).
Tuttavia, è anche vero che tali principi non possono diventare "tiranni", comprimendo del tutto, nella specie, la possibilità della spesa di investimento delle regioni in disavanzo, che è comunque funzionale anche a colmare il grave deficit infrastrutturale che ancora penalizza le potenzialità di sviluppo di diverse aree del nostro Paese.
3.2.2.- Non è fondata nemmeno la censura che investe lo stesso comma 790 in riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., dal momento che la disciplina richiamata dalla ricorrente - relativa al ripiano dei disavanzi maturati al 31 dicembre 2015, tra cui quello della Campania - richiede, a fronte della significativa deroga al termine di rientro dal disavanzo, l'impegno della regione a incrementare i pagamenti complessivi per investimenti per gli anni dal 2018 al 2026. Ciò significa che l'incremento da conseguire per l'anno 2026 - l'unico che, in ipotesi, si sovrappone con l'operatività del meccanismo impugnato - presuppone che i finanziamenti degli investimenti siano stati stanziati in precedenza nel bilancio regionale e, soprattutto, che l'avanzamento degli interventi abbia determinato pagamenti effettivi.
La disposizione impugnata è invece destinata a finanziare nuovi investimenti in un arco temporale nel quale la disciplina cui la ricorrente fa riferimento avrà in buona sostanza esaurito la sua applicazione.
Si deve dunque escludere la prospettata interferenza tra la richiamata disciplina speciale del ripiano del disavanzo e la disposizione impugnata.
3.4.- Infine, secondo la Regione Campania, la preclusione risultante dall'impugnato comma 790 impedirebbe alle regioni in disavanzo, irragionevolmente e in violazione dell'art. 119, quinto comma, Cost., di fruire del «beneficio correlato alla copertura a carico del bilancio dello Stato per spese di investimento».
La censura non è fondata.
Essa poggia sull'assunto che la possibilità di utilizzare il fondo per investimenti riconosciuta agli enti in avanzo abbia «un costo per l'erario, puntualmente specificato» nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, e che il finanziamento degli investimenti consentito ai predetti enti avvenga a carico del bilancio dello Stato, con risorse assimilabili a quelle di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., dalle quali sarebbero esclusi gli enti in disavanzo.
Tale assunto è fallace.
In realtà, quello che la ricorrente qualifica «costo per l'erario» non rappresenta un onere al quale il bilancio dello Stato ha fatto fronte con un'apposita copertura, ma soltanto la quantificazione degli effetti finanziari della disposizione sui saldi che riguardano le pubbliche amministrazioni.
L'intero meccanismo del contributo non determina, infatti, passaggi di risorse né dagli enti territoriali allo Stato, e neanche in senso inverso, a vantaggio degli enti in avanzo: infatti, il finanziamento degli investimenti a questi consentito avviene utilizzando i risparmi registrati al termine dell'esercizio sul fondo appostato in bilancio con risorse dell'ente.
In conclusione, l'inesattezza del presupposto mina la fondatezza della censura.
4.- Con un terzo gruppo di censure, la ricorrente impugna i commi 792 e 793 dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024 per violazione degli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., in quanto: a) prevederebbero «gravose sanzioni» solo quale conseguenza «diretta ed automatica del mancato rispetto dei termini sanciti»; b) ometterebbero di coinvolgere la Conferenza Stato-regioni nella determinazione della quantificazione della sanzione; c) imporrebbero una misura sanzionatoria senza alcuna attività istruttoria in ordine alla concreta sostenibilità da parte della regione interessata e senza prevedere che questa partecipi al procedimento di applicazione.
4.1.- Per le ragioni già illustrate (supra, punto 2.1.), la questione promossa in riferimento all'art. 53 Cost. è inammissibile.
4.2.- Le residue censure non sono fondate.
Quanto al profilo dell'applicazione in via automatica, non pare dubitabile che nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica spetti al legislatore statale definire un sistema di sanzioni, individuando le necessarie misure che costituiscono «naturale deterrente per ogni singola infrazione degli enti territoriali ai vincoli di finanza pubblica» (sentenza n. 77 del 2019).
Quanto alla specifica censura sulla necessità di una previa verifica di sostenibilità della sanzione, va considerato che la disposizione impugnata non prevede un incremento, a titolo sanzionatorio, del contributo dovuto e non accantonato in bilancio, ma si limita a stabilire che tale importo sia appostato nel fondo nell'esercizio successivo, nel quale si effettua il monitoraggio della misura. Pertanto, l'assenza di un vero e proprio carattere afflittivo del meccanismo in questione esclude in radice la necessità di condizionarne l'applicabilità alla verifica di sostenibilità da parte dell'ente.
Diversa è la previsione nel caso di inadempimento all'obbligo di trasmissione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni dei dati consuntivi, nel quale l'importo del contributo dovuto è incrementato del dieci per cento. La quantificazione di tale sanzione risulta, tuttavia, contenuta in una misura proporzionata a realizzare l'effetto deterrente. Di conseguenza, nemmeno per tale previsione sussiste la denunciata lesione dei parametri evocati.
Nel complesso, quindi, le misure stabilite in risposta agli inadempimenti si presentano congegnate a un livello minimo, tale da escludere anche il contrasto con il principio di leale collaborazione per l'omessa previsione del coinvolgimento del sistema delle conferenze nella quantificazione dell'incremento.
Infine, va altresì esclusa la denunciata lacuna in ordine alla partecipazione della regione interessata al procedimento, dal momento che nell'attuazione del meccanismo sanzionatorio troverebbero comunque applicazione i principi generali sul procedimento amministrativo.
5.- Con un ultimo gruppo di questioni, il ricorso impugna l'art. 1, commi 796 e 797, lettere a) e d), della legge n. 207 del 2024, in quanto, riducendo, il primo, e azzerando, il secondo, le autorizzazioni di spesa per contributi statali per investimenti dei comuni e delle regioni a statuto ordinario, tali previsioni violerebbero, in particolare, gli artt. 3, 97 e 119, nonché gli artt. 81 e 120 Cost., omettendo di prevedere «strumenti perequativi» e, anzi, realizzando «un meccanismo proteso ad acuire le disparità tra territori», così contribuendo «alla perpetrazione e cristallizzazione di condizioni di fatto» tali da limitare, per le regioni più svantaggiate, l'esercizio delle prerogative costituzionali.
Alla luce di quanto precisato al punto 3.2.1., le censure non sono fondate.
Le disposizioni impugnate intervengono su risorse statali qualificabili come aggiuntive, ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost., determinandone una rimodulazione nel contesto di scelte allocative inserite in una manovra di finanza pubblica.
Con riferimento a fondi così connotati, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto possibile che essi siano «oggetto di una nuova programmazione, alla luce di valutazioni di interesse strategico nazionale» (sentenza n. 143 del 2017).
In altri termini, si tratta di risorse statali «non ancora utilizzate, che, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, ricevono nel bilancio dello Stato una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica» (sentenza n. 207 del 2011).
D'altro canto, alla base delle rimodulazioni operate dalle disposizioni impugnate vi è anche il collegamento tra queste e il meccanismo che consente agli enti territoriali in avanzo di amministrazione di utilizzare il contributo alla finanza pubblica per finanziare investimenti. La stessa relazione al disegno di legge di bilancio esplicita che tutti i disposti definanziamenti agli enti territoriali tengono conto della previsione della suddetta modalità applicativa del contributo (A.C. n. 2112 - XIX Legislatura - Relazione al disegno di legge di bilancio 2025 - pagina 151).
In effetti, quanto al comparto degli enti locali, la maggioranza dei quali presenta avanzi di amministrazione, la riduzione dei trasferimenti può trovare compensazione, nel periodo considerato, dalla destinazione del contributo alla spesa di investimento.
Come evidenziato al punto 3.2.1., lo stesso saldo positivo non è però ipotizzabile per le regioni.
Tuttavia, per questi enti territoriali l'operatività dei denunciati definanziamenti non è immediata, bensì differita al 2027, per cui il pregiudizio alla perequazione infrastrutturale potrà essere evitato dal legislatore dando seguito alla sollecitazione di questa Corte a intervenire, nelle annualità successive a quella in corso, per una modulazione meno rigida dell'alternativa sulla utilizzazione del contributo.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 792 e 793, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), promosse, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, della legge n. 207 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 796 e 797, lettere a) e d), della legge n. 207 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.