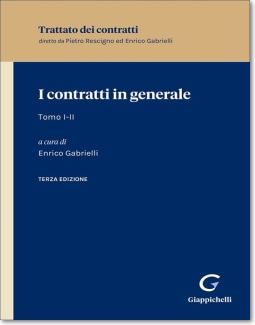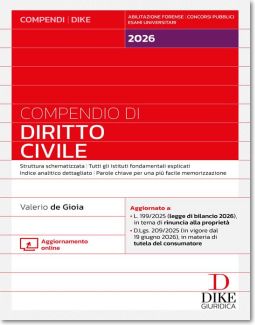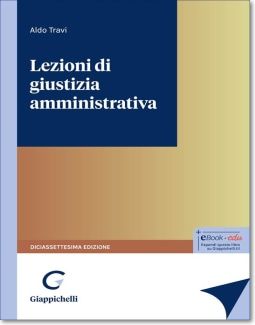Consiglio di Stato
Adunanza plenaria
Sentenza 2 ottobre 2025, n. 11
Presidente: Maruotti - Estensore: Lamberti
FATTO E DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il silenzio serbato dal Ministero della giustizia sull'istanza presentata in data 22 marzo 2023 dall'odierno appellante, cittadino francese, per ottenere il rilascio di una "garanzia preventiva di non estradizione" negli Stati Uniti d'America ai sensi degli artt. 697 e 698 del codice di procedura penale, in considerazione del fatto che le autorità statunitensi (in particolare, l'U.S. Attorney's Office di Los Angeles, California) hanno chiesto all'Interpol l'emissione di una Red Notice ("avviso rosso"), registrata con il n. [omissis], che abilita le forze dell'ordine di tutti i Paesi del mondo a localizzarlo ed arrestarlo provvisoriamente, in attesa di una successiva estradizione.
1.1. L'interessato ha formulato una originaria istanza, analoga a quella di cui al presente giudizio, in data 8 febbraio 2021, e - a seguito del silenzio già allora serbato dal Ministero della giustizia - ha proposto un primo ricorso giurisdizionale, dichiarato inammissibile sia in primo grado (sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 5797 del 2022, che ha rilevato l'assenza dell'obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione) sia in appello (sentenza di questo Consiglio n. 10309 del 2022, che ha riscontrato il difetto di notifica del ricorso di primo grado al Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di parte controinteressata).
1.2. L'interessato ha quindi avanzato, in data 22 marzo 2023, una seconda istanza del medesimo contenuto e, a seguito del perdurante silenzio del Ministero, ha proposto il ricorso di primo grado, spedito per la notifica in data 7 febbraio 2024.
1.3. Il T.A.R., con la impugnata sentenza n. 21822 del 4 dicembre 2024, ha dichiarato inammissibile anche il secondo ricorso, per la ritenuta assenza dell'obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione.
1.4. L'interessato ha interposto appello, spedito per la notifica in data 3 marzo 2025, contestando la ricostruzione in diritto della sentenza e reiterando, nel merito, le prospettazioni e le censure di primo grado.
1.5. Si sono costituiti in resistenza il Ministero della giustizia e il Governo degli Stati Uniti d'America. Quest'ultimo, con memoria depositata in data 12 maggio 2025, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, rilevando che sarebbe nulla la procura alle liti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, 40, comma 1, lett. g), 44, comma 1, lett. a), e 101, comma 1, del codice del processo amministrativo.
1.5.1. L'eccezione è stata così argomentata:
- la procura, notificata unitamente al ricorso in appello, risulta dichiaratamente rilasciata in Francia (ove l'appellante risiede), ma è stata autenticata dal difensore italiano;
- ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge italiana;
- la procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, mentre non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, il cui potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale;
- è esclusa la possibilità di rinnovazione della procura alle liti ai sensi dell'art. 182 del codice di procedura civile, non applicabile al processo amministrativo.
1.5.2. L'appellante, con la memoria di replica del 16 maggio 2025, ha contestato siffatte argomentazioni, sostenendo che:
- la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione integra una forma di "autenticazione minore", la quale non implica né che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che egli assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia la procura;
- comunque, il difetto di valida procura può essere sanato dal deposito di una nuova valida procura, completa di traduzione asseverata, autenticata innanzi a un notaio francese.
1.5.3. L'appellante ha, poi, provveduto al deposito di siffatta procura, in data 27 maggio 2025.
2. La Terza Sezione, all'esito della camera di consiglio del 29 maggio 2025, con l'ordinanza n. 4837 del 4 giugno 2025 ha ritenuto, quanto alla questione della procura, che:
«i) le circostanze in fatto poste a fondamento dell'eccezione di difetto di procura sono pacifiche e incontestate;
ii) altrettanto pacifico, in diritto, è il principio per cui ai sensi dell'art. 12 della l. 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale;
iii) poiché il difensore italiano ha un potere di autenticazione limitato al territorio nazionale, necessariamente la procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede (così Cass. civ., Sez. I, n. 16050/2018; n. 19334/2022; Sez. II, n. 27282/2008);
iv) non può condividersi la tesi dell'autografia della sottoscrizione quale forma di "autenticazione minore", in quanto l'art. 2703, comma 2, c.c. prevede che "l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive";
v) ne consegue che - dovendo la validità del mandato essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci (cit. art. 2703 c.c.) - è indispensabile che dalla sua formulazione "siano desumibili gli elementi tipici dell'autenticazione, e cioè accertamento della identità del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale" (Cass. civ., Sez. II, n. 5065/2025; Sez. I, n. 21566/2021);
vi) in applicazione del medesimo principio si è anche affermato che una procura alle liti conferita all'estero e dalla quale emerga che il sottoscrittore non è comparso davanti al pubblico ufficiale per firmare l'atto, è irrimediabilmente nulla, poiché costituisce principio inderogabile dell'ordinamento italiano che l'attestazione del pubblico ufficiale debba riguardare la firma dell'atto in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore (Cass. civ., Sez. I, n. 34867/2022);
vii) l'ordinanza citata in senso contrario dal ricorrente (Cass. civ., Sez. III, n. 18381/2024, ord.) non è affatto conducente rispetto alla tesi perorata, poiché la stessa non deflette dalla regola della necessaria "contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione dell'avvocato (ciò che trova una qualche rispondenza nella previsione di legge speciale ... di cui all'art. 35-bis¸ comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, la quale - come evidenziato da Cass., Sez. un., n. 15177/2021 - individua, nella certificazione della data di rilascio della procura, 'un autonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all'atto del rilascio della procura speciale')"».
2.1. L'ordinanza, pertanto, ha concluso che "la procura allegata e notificata unitamente al ricorso in appello è certamente nulla e tale quindi da compromettere la valida instaurazione del grado di giudizio".
2.2. Quanto alla "residua questione dell'applicabilità o meno al giudizio amministrativo dell'art. 182, comma 2, c.p.c.", l'ordinanza ha dato atto dell'esistenza di due contrastanti orientamenti "trasversali alle diverse Sezioni di questo Consiglio", posto che:
"a) un primo indirizzo si esprime in senso favorevole all'applicabilità dell'art. 182, comma 2, c.p.c. al processo amministrativo (C.d.S., Sez. II, n. 2311/2024; Sez. III, n. 2606/2018; n. 6371 del 2018; n. 7441/2020; n. 6822/2021; Sez. IV, n. 1119/2014; n. 7370/2024; Sez. V, n. 773/2016; n. 1331/2016; n. 1178/2018; n. 283/2019; 4253/2021; n. 8837/2022; n. 9391/2024);
b) un secondo indirizzo si esprime in senso contrario alla suddetta estensione (fra cui C.d.S., Sez. III, n. 1691/2024; n. 3550/2024; n. 4275/2024; n. 1935/2025; Sez. IV, n. 3887/2021; n. 108/2024; n. 8092/2024; Sez. V, nn. 8340, 8341, 8342 e 8343/2020; n. 2160/2021; Sez. VI, n. 2922/2019; Sez. VII, n. 9241/2023)".
2.2.1. L'ordinanza ha osservato che "il primo indirizzo ritiene applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c. in forza del rinvio esterno che l'art. 39, comma 1, c.p.a. fa alle "disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali".
2.2.2. Tuttavia, ha proseguito l'ordinanza, dai citati precedenti giurisprudenziali:
I) non emerge una compiuta verifica di compatibilità dell'art. 182, secondo comma, c.p.c. con le disposizioni del codice del processo amministrativo;
II) non consta una specifica indagine circa la portata di "principio generale" - quindi "estensibile" ai sensi dell'art. 39 c.p.a. - della regola dettata dall'art. 182, secondo comma, c.p.c.;
III) non è affrontato il tema dell'esistenza di una lacuna del processo amministrativo che giustifichi tale richiamo.
2.2.3. I precedenti giurisprudenziali, invero, si limiterebbero ad osservare che:
- il vizio della procura, attenendo alla capacità processuale (ossia la titolarità da parte del difensore del potere di proporre la domanda) e non alla legittimazione ad agire (riguardante la prospettazione del soggetto assistito dal difensore come titolare del diritto o dell'interesse azionato), sarebbe "sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti";
- la soluzione contraria all'applicazione dell'art. 182, secondo comma, c.p.c. determinerebbe una "seria compromissione del diritto di difesa dell'odierno appellante".
2.2.4. Il secondo indirizzo, ha rilevato l'ordinanza, «evidenzia al contrario che:
- l'art. 182, comma 2, c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo il quale, a differenza di quello civile (che ammette anche il conferimento di un mandato generale alle liti), impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, trattandosi di processo strutturato come prevalentemente di impugnazione (C.d.S., Sez. IV, n. 8092/2024);
- è da escludersi anche che il predetto art. 182, comma 2, c.p.c. sia compatibile con i principi propri del processo amministrativo, in quanto la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione;
- l'ulteriore principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi i diritti dei terzi, non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale;
- è vero poi che ai sensi dell'art. 125, comma 2, c.p.c. "la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata": ma il terzo comma della medesima disposizione aggiunge che tale regola "non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale", come appunto nel caso del ricorso per cassazione e del ricorso al giudice amministrativo;
- nel medesimo senso rileva la previsione dell'art. 40 c.p.a. (ma il discorso è estendibile anche all'art. 101 c.p.a., per quanto riguarda il ricorso in appello), poiché la regola ivi fissata - per cui il ricorso sottoscritto dal solo difensore deve indicare l'esistenza della procura speciale - lascia intendere che questa deve esistere prima del ricorso stesso e non può essere rilasciata in un momento successivo (salvo il caso di sostituzione dell'originario difensore);
- la previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, anche perché detto potere concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità;
- diversamente opinando, si consentirebbe la sanatoria di una decadenza specificamente comminata dal codice del processo amministrativo, qual è quella correlata al rispetto del termine per la proposizione dell'azione di annullamento;
- anche nel processo civile, laddove è richiesta la procura speciale, come nel già menzionato caso del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.), l'art. 182, comma 2, c.p.c. è ritenuto pacificamente inapplicabile (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3832/2024; 28153/2024);
- d'altra parte, non esiste un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle altre giurisdizioni speciali, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (Corte cost., n. 191/1985), oltre che in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento;
- il legislatore può pertanto regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale, purché non ne siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività (Corte cost., n. 49/1979; n. 38/1988; n. 251/1989);
- anche da ultimo la Corte ha ribadito che il legislatore può discrezionalmente conformare gli istituti processuali (v., ex multis, sentt. nn. 172, 160, 139 e 45/2019, nn. 225 e 77/2018, nn. 94 e 241/2017) nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l'azione (tra le tante, sentt. n. 45/2019, n. 6/2018, n. 94/2017 e n. 155/2014), "con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (v., ex plurimis, sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015 e n. 157 del 2014), che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004)" (Corte cost., n. 121/2016)».
2.2.5. La Sezione ha precisato di "prestare adesione in linea di principio agli argomenti addotti dal secondo dei due indirizzi sopra richiamati, in quanto maggiormente coerenti con la disciplina della procura speciale e del regime decadenziale del processo amministrativo".
2.2.6. Purtuttavia, alla luce del ravvisato contrasto giurisprudenziale, che oltretutto "impatta su un numero rilevante di contenziosi davanti al giudice amministrativo, sempre più connotato, specie in taluni settori quali i pubblici appalti e l'immigrazione, da parti processuali aventi sede o residenza all'estero", ha sottoposto a questa Adunanza plenaria i seguenti quesiti:
"i) se la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel c.p.a. sia completa o contenga una lacuna da colmare mediante ricorso al c.p.c.;
ii) se la previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. può ritenersi espressione di un principio generale applicabile al giudizio innanzi al giudice amministrativo".
3. Il giudizio è stato trattato da questa Adunanza ed è passato in decisione nella camera di consiglio del 16 luglio 2025, in vista della quale l'appellante e il Governo degli Stati Uniti d'America hanno depositato difese scritte.
4. Prima di procedere all'esame dei quesiti, rileva l'Adunanza plenaria che ha efficacia di giudicato parziale - e non può, quindi, essere posto in discussione in questa sede - quanto deciso dalla Sezione rimettente, sia pure con la forma dell'ordinanza, sulla questione della nullità della procura rilasciata dall'appellante per il presente grado di giudizio (cfr. quanto deciso dalle sentenze di questa Adunanza plenaria n. 10 del 2025, n. 3 del 2009 e n. 11 del 2008, sulla parziale portata decisoria delle ordinanze di rimessione, quando risolvono preliminari questioni processuali).
Infatti, l'ordinanza di rimessione ha qualificato come "certamente nulla" la procura in questione, sollecitando la definizione di questioni conseguenti a tale statuizione.
4.1. Peraltro, l'Adunanza plenaria condivide e fa propria tale statuizione della Terza Sezione sulla nullità della procura.
4.2. Infatti, la procura allegata all'atto di appello è stata sottoscritta a mano dall'appellante in Francia: non è esplicitato il luogo in cui il legale ha provveduto a siffatta "autentica", ma è del tutto ragionevole ritenere che anche tale incombente abbia avuto luogo in Francia, posto che l'attestazione "di autenticità" della sottoscrizione segue immediatamente la firma stessa dell'appellante, a sua volta preceduta, come visto, dal riferimento al luogo di apposizione ("Paris, 5 febbraio 2025").
4.3. Correttamente, dunque, la Sezione ha rilevato la nullità di siffatta procura, posto che il potere di autenticazione attribuito dall'ordinamento processuale al legale con riferimento all'attestazione dell'autografia della sottoscrizione della procura da parte del proprio assistito (che presuppone che tale firma sia stata apposta in presenza del legale, previo accertamento da parte di questi dell'identità del sottoscrittore) opera unicamente entro il territorio nazionale: il potere autenticativo, infatti, è attribuito dalla legge che disciplina il processo, il cui ambito applicativo è limitato al territorio nazionale.
4.4. Invero, il processo (e, dunque, la legge che lo regola, tra cui le disposizioni afferenti alle modalità di rilascio della procura) è manifestazione della potestà sovrana dello Stato di soluzione dei conflitti e, come tale, ne incontra i limiti territoriali.
4.5. Tale conclusione è vieppiù avvalorata dalla considerazione per cui le disposizioni sul potere di autenticazione del legale hanno natura speciale (al contrario di quanto previsto, ad esempio, per i notai) e, pertanto, vanno interpretate restrittivamente, sicché esso sussiste nelle sole ipotesi in cui è espressamente previsto.
4.6. Per tale ragione, la sottoscrizione del cliente e l'attestazione della sua autenticità da parte del legale, per poter produrre effetti processuali - ossia per poter far ravvisare il rilascio di una valida procura - devono aver luogo entro il territorio della Repubblica (e devono compiersi nel medesimo contesto spazio-temporale).
4.7. L'Adunanza plenaria osserva che il c.p.a. reca, all'art. 40, comma 1, lett. g), una specifica definizione della parola "sottoscrizione" del ricorso: con essa, infatti, il codice non si riferisce genericamente, come nel diritto comune, ad una firma, quale che sia, apposta in calce ad un atto al fine (o, comunque, con l'effetto) di attribuirne la paternità, bensì ad un più circoscritto e specifico istituto.
4.8. Per "sottoscrizione" del ricorso, ai sensi e per gli effetti del c.p.a., si intende alternativamente:
- la sottoscrizione apposta dalla parte che abbia la qualità necessaria per difendersi in proprio;
- la sottoscrizione da parte del legale già munito di procura speciale (conferita nei modi di legge), che, oltretutto, deve essere specificamente "indicata".
4.9. Al di fuori di queste tassative ipotesi, difetta - come nella specie - un elemento fattuale giuridicamente qualificabile come sottoscrizione del ricorso, di cui, dunque, l'atto deve ritenersi de jure sprovvisto, con la conseguenza che il giudizio non può ritenersi validamente instaurato e deve, pertanto, essere dichiarato, anche ex officio (cfr. art. 35, comma 1, c.p.a.), inammissibile, in quanto il difetto di sottoscrizione impedisce di collegare giuridicamente l'atto ad un ricorrente, ciò che osta ad una pronuncia sul merito.
5. I quesiti rimessi all'esame di questa Adunanza plenaria riguardano la possibilità o meno di emendare questo vizio originario mediante "il [successivo] rilascio della procura alle liti o la [successiva] rinnovazione della stessa", ai sensi del combinato disposto dell'art. 39, comma 1, del c.p.a. e dell'art. 182, secondo comma, del c.p.c.
5.1. Va premesso che il testo dell'art. 182, secondo comma, del c.p.c. cui fare riferimento è, ratione temporis, quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 149 del 2022, che, ai sensi del successivo art. 35, "hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data", come nel caso di specie.
5.2. L'art. 182, secondo comma, del c.p.c. stabilisce che, "Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
5.3. In sostanza, il codice di procedura civile disciplina la sanatoria del vizio attinente, per quanto qui di interesse, al rilascio della procura nel modo che segue:
- come iniziativa officiosa del Giudice, senza la necessità di un'apposita istanza della parte;
- come iniziativa doverosa del Giudice, giuridicamente tenuto, senza alcun margine di discrezionalità, ad assegnare alla parte un termine (perentorio) per la sanatoria;
- come adempimento non soggetto a limiti di tempo (se non a quello della definizione del giudizio);
- come istituto comprensivo non solo dei profili di nullità, ma anche del vizio radicale costituito dalla totale mancanza della procura ("Quando rileva la mancanza della procura al difensore"), ipotesi giuridicamente riferibile alla mancata esistenza in rerum natura della procura;
- come istituto con valenza ex tunc e conseguente salvezza di tutti gli effetti sostanziali e processuali che sarebbero conseguiti ad una procura validamente rilasciata ab initio.
6. Questa Adunanza plenaria deve verificare se tale disposizione si applichi anche al processo amministrativo in virtù della "disposizione di raccordo" contenuta nell'art. 39, comma 1, del c.p.a., ai sensi del quale "Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali".
7. Dopo maturo esame, ritiene il Collegio che la risposta debba essere negativa.
8. L'art. 39, comma 1, del c.p.a. individua tre distinti profili condizionanti l'applicazione di disposizioni processualcivilistiche nel processo amministrativo (in assenza di uno specifico ed espresso richiamo da parte di quest'ultimo):
- la sussistenza di una lacuna nell'ordinamento processuale amministrativo ("Per quanto non disciplinato dal presente codice");
- la compatibilità delle disposizioni sul processo civile con il "presente codice", ossia con il c.p.a. ("in quanto compatibili");
- la valenza di tali disposizioni quali principi generali del diritto processuale generale ("espressione di principi generali").
8.1. I quesiti rimessi a questa Adunanza plenaria ["i) se la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel c.p.a. sia completa o contenga una lacuna da colmare mediante ricorso al c.p.c.; ii) se la previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. può ritenersi espressione di un principio generale applicabile al giudizio innanzi al giudice amministrativo"] attengono, per vero, a due soli di tali profili, ma per la loro soluzione occorre esaminarli tutti e tre.
8.2. Peraltro, i criteri della compatibilità e della natura di principio generale sono, a ben vedere, un'endiadi, posto che:
- un principio generale del diritto processuale (cioè di teoria generale del processo) è tale proprio perché compatibile con ogni manifestazione concreta del fenomeno giuridico "processo", attenendo a profili strutturali ovvero funzionali coessenziali all'identificazione stessa, su un piano ontologico, giuridico e assiologico, di un fenomeno processuale;
- di converso, una disposizione non compatibile con la struttura e la funzione del processo amministrativo, evidentemente, non può per ciò stesso essere considerata "principio generale", costituendo semplicemente un "principio settoriale", riferito cioè ad alcune soltanto delle forme processuali previste dall'ordinamento (o, il che è lo stesso, un principio generale di quella specifica forma processuale).
9. Il primo e dirimente tema da affrontare è se esista una lacuna in subiecta materia.
9.1. In campo processuale, sussiste una lacuna in senso tecnico qualora vi sia un ostacolo al buon funzionamento del giudizio e manchi una disposizione per risolvere la questione (sulla nozione di lacuna, cfr. Ad. plen., n. 16 del 2024).
9.2. Si tratta, in sostanza, di un concetto "funzionale" di lacuna, intesa come assenza di una disposizione necessaria affinché il sistema possa fisiologicamente funzionare.
9.3. Non si fa riferimento, invece, ad un "concetto assiologico" di lacuna, ossia ad una declinazione "valoriale" del termine, come carenza di disposizioni che, alla luce di superiori previsioni normative (o di sistemi culturali di riferimento), dovrebbero viceversa esserci.
9.4. La disciplina dell'ordinamento processuale è, infatti, di competenza del legislatore, sì che il Giudice può solo dare applicazione alle normative processuali oppure, qualora ne ravvisi l'incompatibilità con il quadro costituzionale, sollevare una questione di legittimità costituzionale, non certo sindacare nel merito la soluzione risultante dal quadro legislativo.
9.5. È salvo, evidentemente, il potere-dovere di disapplicazione, qualora la disciplina legislativa processuale si ponga in contrasto, non sanabile in via esegetica, con la normativa unionale direttamente applicabile (cfr. la richiamata Ad. plen., n. 16 del 2024): una tale evenienza, tuttavia, esula nella vicenda di specie e, pertanto, non occorre approfondirla.
10. Nel caso di specie, l'Adunanza plenaria non ritiene sussistente alcuna lacuna in senso tecnico.
10.1. La disciplina legislativa del processo amministrativo, infatti, risulta organica anche in assenza della previsione della sanabilità di una procura nulla o del rilascio ex novo di una procura dopo il riscontro del suo iniziale mancato rilascio.
10.2. In termini di teoria generale del diritto, la nullità, in particolare nella forma (sussistente nella specie) di un vizio strutturale di un atto di gravità tale da inibirne ex ante l'idoneità alla produzione di effetti giuridici (sostanziali o, come in questo caso, processuali), è una regula juris compiuta e pianamente applicabile, che non abbisogna di alcuna etero-integrazione.
10.3. Un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto difetta l'indispensabile nesso giuridico fra il ricorso ed il titolare della relativa situazione giuridica: l'erroneo conferimento dello jus postulandi determina la nullità della procura e, a valle, l'inevitabile inammissibilità del ricorso.
10.4. La chiara e testuale regola sulla insanabilità di questa nullità si basa sul principio di auto-responsabilità, che permea l'intero ordinamento giuridico.
10.5. L'istituto della sanatoria della nullità ha natura eccezionale, in quanto consente di attribuire ex tunc la capacità di produrre effetti ad un atto che, originariamente, ne era strutturalmente privo: proprio in quanto eccezionale, la sanatoria non è un complemento indispensabile e, per così dire, naturale delle ipotesi di nullità (cfr., per la corrispondente regola sostanziale, l'art. 1423 del codice civile).
10.6. Ne consegue che non è ravvisabile una lacuna dell'ordinamento nei casi in cui il legislatore non abbia previsto la possibilità di sanare una nullità processuale, come nel caso in esame.
10.7. La mancanza di una espressa deroga legislativa ad un principio generale enunciato dalla legge stessa consente (recte, impone) il richiamo al brocardo ubi lex noluit tacuit, che ha un saldo (ed imperativo) fondamento di diritto positivo nell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse".
10.8. Orbene, l'assenza in un testo codicistico - dunque in un testo con dichiarata attitudine, proiezione ed ambizione sistemica - della previsione di un istituto derogatorio di una regola generale significa, secondo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole", che tale istituto non rientra nella disciplina legislativa.
10.9. Né può sostenersi, a contrario, che il legislatore - se avesse voluto impedire la sanatoria - lo avrebbe dovuto disporre esplicitamente: la chiara regola generale è quella della nullità della procura non conferita nelle forme del codice di rito, sicché la sua sanatoria rappresenta l'eccezione, che, come tale, avrebbe richiesto un'espressa previsione.
10.10. Di converso, la mancata applicazione nel processo amministrativo dell'art. 182, secondo comma, del c.p.c. non determina alcuna lesione del diritto di difesa in termini di garanzia ed effettività, posto che il ricorrente può far valere le sue pretese nei termini, nelle forme e con le modalità previste dal legislatore, con tecniche di tutela che la giurisprudenza nazionale e quella della Corte di giustizia hanno più volte ritenuto adeguate (cfr., in termini di diritto positivo unionale, l'art. 263, ultimo comma, del TFUE).
10.11. Le argomentazioni che precedono riguardano tutti i giudizi amministrativi (con l'eccezione di quelli che la parte può avanzare personalmente: cfr. artt. 22, comma 3, e 23 del c.p.a.), anche quando non si tratti della tutela di interessi legittimi, avendo il legislatore previsto le stesse regole processuali - senza eccezioni - anche quando il ricorso sia presentato in sede di giurisdizione esclusiva: l'applicazione dei principi del processo civile è condizionata alla ritenuta sussistenza, all'esito di una analisi condotta volta per volta, dei profili delineati dall'art. 39 del c.p.a. (per casi di ritenuta compatibilità, cfr. Ad. plen., n. 15 del 2024; decreto n. 13 del 2024; n. 8 del 2018; n. 18 del 2016; n. 5 del 2015; n. 4 del 2015).
11. L'assenza di una lacuna nella disciplina del c.p.a. consentirebbe di terminare qui l'analisi: l'Adunanza plenaria, cionondimeno, ritiene opportuno esaminare anche gli altri profili prospettati dall'appellante.
12. Le disposizioni dell'art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non sono compatibili con il codice del processo amministrativo, anche per ragioni testuali e logico-sistematiche.
13. Da un punto di vista testuale, rilevano l'art. 40, comma 1, lett. g), e l'art. 44, comma 1, lett. a), del c.p.a.
13.1. Come già visto supra, l'art. 40, comma 1, lett. g), ha definito il contenuto giuridico della parola "sottoscrizione" del ricorso e l'art. 44, comma 1, lett. a), ha stabilito che è nullo il ricorso privo di sottoscrizione.
13.2. La carenza della sottoscrizione va, dunque, intesa non in senso materiale, ma in senso giuridico, ossia come mancanza o della sottoscrizione del ricorrente capace di stare in giudizio personalmente o della sottoscrizione "del difensore, con indicazione ... della procura speciale".
13.3. Se ne trae che nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito): è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale.
13.4. Invece, nel processo civile, nell'ambito del quale rileva l'art. 182, secondo comma, del c.p.c., l'atto di citazione (costituente l'ordinaria forma di instaurazione del giudizio) "deve contenere ... 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata" (art. 163, terzo comma, del c.p.c.).
13.4.1. Il sistema processuale civile, dunque, consente espressamente il rilascio della procura in un momento successivo alla redazione dell'atto di citazione.
13.4.2. Anzi, l'art. 125, secondo comma, del c.p.c. dispone che "La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata": la procura, quindi, non deve né preesistere alla redazione dell'atto, né alla conseguente notificazione, bastando (per restare nella fisiologia del sistema) che sia rilasciata prima della costituzione in giudizio, ossia del deposito - nella cancelleria del giudice adito - dell'originale dell'atto di citazione, con la contestuale iscrizione a ruolo.
13.5. Si tratta, con evidenza, di sistemi ontologicamente diversi, uno dei quali (il c.p.a.) delinea un rigido schema diacronico di adempimenti, l'altro (il c.p.c.) si muove entro un orizzonte "più elastico" in tema di compimento degli adempimenti processuali.
13.5.1. Proprio in questa cornice strutturalmente elastica si inserisce l'art. 182, secondo comma, del c.p.c., che amplia ulteriormente le maglie temporali per il valido rilascio della procura nell'ambito di un sistema che, a differenza del c.p.a., già prevede a monte ed in via fisiologica una certa indipendenza temporale fra procura e atto defensionale.
14. Un ulteriore argomento testuale si ricava dall'art. 125, terzo comma, del c.p.c., secondo cui "la disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale" e dal connesso art. 366 del c.p.c., per il quale "Il ricorso [per cassazione] deve contenere, a pena di inammissibilità ... 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato".
14.1. L'art. 125, terzo comma, del c.p.c. esclude la possibilità di rilascio della procura in un momento successivo alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, allorché la legge richieda che la citazione (o, comunque, l'atto introduttivo del giudizio) sia sottoscritta da difensore munito di procura speciale; a sua volta, l'art. 366 c.p.c., in applicazione di tale principio generale, stabilisce che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione della procura (necessariamente speciale, ex art. 365 c.p.c.), se conferita con atto separato.
14.2. Dunque, anche il c.p.c. delinea un rigido ordine diacronico (rilascio della procura prima della spedizione per la notifica dell'atto) allorché, per legge, sia necessaria la procura speciale (e non anche la semplice procura generale, di regola sufficiente - cfr. art. 83, secondo comma, del c.p.c.), escludendo conseguentemente, in tali casi, la sanabilità della procura nulla.
14.3. Ora, il processo amministrativo richiede sempre [cfr. il richiamato art. 40, comma 1, lett. g), del c.p.a.] che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura speciale: l'art. 182, secondo comma, del c.p.c. è, dunque, ontologicamente incompatibile con il c.p.a., la cui regola generale è quella per cui la procura - proprio come nel giudizio di cassazione - deve sempre precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
15. In una prospettiva logico-sistematica, l'Adunanza osserva che siffatta conclusione risulta in armonia con la natura stessa delle giurisdizioni civile ed amministrativa.
15.1. Invero, il processo amministrativo di legittimità (archetipo del processo amministrativo, su cui è costruita tutta la relativa disciplina), nelle sue varie forme, ivi inclusa quella speciale di cui all'art. 117 del c.p.a., si basa, fra l'altro, su termini decadenziali, il cui superamento è rilevabile d'ufficio e determina la chiusura del giudizio con una pronuncia di rito (arg. ex art. 35 del c.p.a.).
15.2. Consentire la sanatoria di una procura inizialmente nulla (o tout court inesistente) potrebbe comportare, potenzialmente, l'aggiramento di tali termini, con danno (oltre che all'Amministrazione intimata ed all'eventuale controinteressato) alla stabilità delle situazioni giuridiche di diritto pubblico, valore primario che è sempre stato tenuto presente dal legislatore per i giudizi amministrativi.
15.3. Si avrebbe, quindi, un capovolgimento per via esegetica della logica istituzionale sottesa alla disciplina legislativa sul processo amministrativo.
15.4. Di contro, il processo civile, ove di regola si confrontano due parti private portatrici di interessi individuali, conosce, salvo limitate eccezioni, solo il ben più ampio termine di prescrizione, per lo più pluriennale e, oltretutto, non rilevabile d'ufficio.
16. L'incompatibilità fra l'art. 182, secondo comma, del c.p.c. ed il processo amministrativo emerge anche da un'ulteriore considerazione.
16.1. L'art. 44, comma 1, del c.p.a. stabilisce che è nullo il ricorso privo di sottoscrizione e, al successivo comma 4-bis, dispone che tale nullità è rilevabile d'ufficio: il ricorso non sottoscritto nelle forme di legge è nullo e ciò è rilevabile d'ufficio (in ogni stato e grado del processo).
16.2. L'art. 44, comma 2, precisa che, "Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato".
16.3. La minore gravità della difformità rispetto al paradigma legale, propria del fenomeno della (mera) irregolarità, consente al giudice di ordinare la rinnovazione del ricorso e, dunque, ne ammette la sanatoria.
16.4. Il sistema risultante dall'art. 44 del c.p.a. è perfettamente logico: nel caso di una irregolarità, il giudice - tenuto conto della tipologia di irregolarità, del contesto della controversia e delle posizioni delle parti - può consentire la rinnovazione del ricorso; in presenza, invece, di una nullità, il giudice deve rilevarla d'ufficio e chiudere in rito il giudizio.
16.5. Tale razionale assetto sarebbe alterato se si dovesse ritenere applicabile l'art. 182, secondo comma, del c.p.c.: infatti, l'irregolarità rimarrebbe sanabile solo a discrezione del giudice, mentre la nullità diverrebbe oggetto di un dovere di sanatoria sempre e comunque gravante sul giudice, con una soluzione illogica (e, perciò, inaccettabile).
16.6. Del resto, se il c.p.a. consente, a discrezione del giudice, la rinnovazione del ricorso irregolare, mentre nulla dispone a proposito del ricorso nullo, ciò, evidentemente, significa che nessuna possibilità di rinnovazione è stata prevista e voluta dal legislatore per tale caso.
17. L'art. 182, secondo comma, del c.p.c. non prevede un principio generale del diritto processuale (recte, di teoria generale del processo).
17.1. Esso, infatti, riguarda il solo processo di merito (il primo ed il secondo grado di giudizio), non quello di cassazione, che, come visto, segue logiche e dinamiche completamente diverse e che pure è parte integrante del processo civile (tanto che è disciplinato nel c.p.c.).
17.2. Ora, il giudizio amministrativo, tanto di primo quanto di secondo grado, è oggettivamente più simile, almeno in subiecta materia, a quello di cassazione (cfr., in un'ottica ordinamentale, l'art. 135 della Costituzione nel suo richiamo alle "giurisdizioni superiori"), sì che difetta la eadem ratio che possa giustificare l'estensione di una norma dettata per il processo di merito civile ad un processo, come quello amministrativo, che presenta notevoli differenze rispetto ad esso e che, in parte qua, si avvicina decisamente più (per formalità, concentrazione e carattere impugnatorio in senso stretto) a quello di cassazione, non soggetto al principio in esame.
18. In un'ottica più generale, l'Adunanza plenaria aggiunge che il processo amministrativo è strutturalmente separato dal processo civile, tanto che ha un proprio codice, che si pone sullo stesso piano del c.p.c., in un rapporto di parallelismo orizzontale e non di integrazione verticale, sì che non si può affermare che il codice di procedura civile costituisca la "cornice normativa" alla quale andrebbe sempre e comunque uniformata l'interpretazione del codice del processo amministrativo (cfr. la richiamata sentenza Ad. plen., n. 16 del 2024).
18.1. Sotto tale aspetto, va rimarcato come proprio il legislatore abbia inteso disciplinare separatamente il giudizio civile e quello amministrativo in ragione delle loro oggettive diversità, rivenienti da ragioni storiche e sistematiche di cui, del resto, a suo tempo ha tenuto conto anche l'Assemblea costituente.
18.2. Invero, il c.p.a. è stato approvato con il d.lgs. n. 104 del 2010, costituente attuazione della delega conferita dal Parlamento con l'art. 44 della l. n. 69 del 2009.
18.3. La disposizione di delega prevedeva "uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele".
18.4. L'esercizio della delega, costituito dal codice, è già in sé, dunque, il frutto del "coordinamento con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali", sì che non solo non abbisogna, a tale fine, di integrazioni esegetiche, ma anzi le rifiuta, proprio perché il "coordinamento" è già stato effettuato nella sede propria del decreto legislativo.
18.5. Non vi è, in definitiva, bisogno di (né, prima ancora, spazio per) operazioni esegetiche di importazione sistemica di disposizioni dal c.p.c. ogniqualvolta il c.p.a. non rechi proprie previsioni.
18.6. Come ha correttamente rilevato l'ordinanza di rimessione, «non esiste un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle altre giurisdizioni speciali, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (Corte cost., n. 191/1985), oltre che in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento ...
Il legislatore può pertanto regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale, purché non ne siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività (Corte cost., n. 49/1979; n. 38/1988; n. 251/1989) ...
Anche da ultimo la Corte ha ribadito che il legislatore può discrezionalmente conformare gli istituti processuali (v., ex multis, sentt. nn. 172, 160, 139 e 45/2019, nn. 225 e 77/2018, nn. 94 e 241/2017) nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l'azione (tra le tante, sentt. n. 45/2019, n. 6/2018, n. 94/2017 e n. 155/2014), "con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (v., ex plurimis, sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015 e n. 157 del 2014), che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004)" (Corte cost. n. 121/2016)».
19. In conclusione, l'Adunanza plenaria ritiene che - in considerazione dell'autonomia strutturale, funzionale ed applicativa del codice del processo amministrativo - l'etero-integrazione delle sue disposizioni con quelle previste dal codice di procedura civile può aversi, quale elemento di chiusura del sistema, solo nei limiti stabiliti dall'art. 39 del c.p.a.
20. Per le esposte ragioni, l'Adunanza plenaria risponde come segue ai quesiti sollevati dalla Sezione rimettente:
"i) la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l'applicazione del codice di procedura civile";
"ii) la previsione di cui all'art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo".
21. L'Adunanza plenaria, pertanto, restituisce l'affare alla Sezione per la definizione del giudizio, rappresentando altresì che compete alla stessa valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'operatività, quanto alla questione del rilascio della procura, dell'istituto dell'errore scusabile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, enuncia i principi di diritto di cui in motivazione e dispone la restituzione della causa alla Sezione rimettente per la definizione del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5, 6 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento esclusivamente delle generalità della parte appellante.