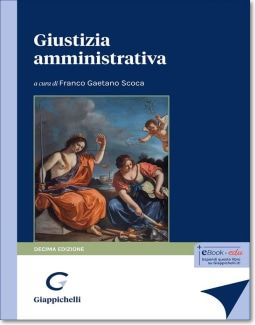Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 29 maggio 2025, n. 22663
Presidente: De Marzo - Estensore: Lanna
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea in composizione monocratica del 16 giugno 2023, che aveva riconosciuto Giuseppe D.G. colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché - dopo che gli era stata revocata la patente di guida con decreto prefettizio del 10 dicembre 2018, notificatogli il 15 dicembre 2018, conseguente ad avviso orale del 18 luglio 2016 del Questore di Torino - veniva sorpreso alla guida di un autoveicolo e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto.
2. Ricorre per cassazione Giuseppe D.G., a mezzo dell'avv. Davide Gatti, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Con il primo motivo, viene chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in punto di sussistenza della penale responsabilità, denunciandosi vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ragione della manifesta illogicità della motivazione, nonché della inosservanza ed erronea applicazione della norma penale di cui all'art. 49, secondo comma, c.p.
L'imputato, in data 16 gennaio 2020, è stato sorpreso alla guida di un autoveicolo, nonostante la intervenuta revoca della patente di guida della quale era titolare; il giorno 17 novembre 2020, però, è sopravvenuto un provvedimento del Vice Prefetto di Torino, il quale ha revocato il precedente decreto prefettizio di revoca della patente di guida, venendosi consequenzialmente a determinare la riacquisizione ex tunc della piena legittimazione alla guida. Hanno errato i Giudici del merito, quindi, laddove hanno ritenuto che a tale revoca si dovesse riconnettere una efficacia non retroattiva. In realtà, ad onta dell'utilizzo del termine revoca, si è più propriamente verificato un annullamento d'ufficio, in quanto intervenuto in vista della elisione della illegittimità di un precedente provvedimento amministrativo. La fattispecie di cui all'art. 120, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - aggiunge la difesa nella presente impugnazione - è stata oggetto di plurimi pronunciamenti ad opera della Corte costituzionale, che è intervenuta con le sentenze nn. 22 e 99 del 2020.
2.2. Con il secondo motivo, viene chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in punto di penale responsabilità, a causa dell'esistenza di vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ragione della manifesta illogicità della motivazione e della inosservanza e/o erronea applicazione della norma di cui all'art. 131-bis c.p. Si è puntata l'attenzione esclusivamente sui pregiudizi penali dell'imputato e, in tal modo, si è trascurato l'esame della tenuità del fatto, nonché della natura minimale della lesione prodottasi agli interessi protetti dalla norma incriminatrice.
2.3. Con il terzo motivo, viene chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, in punto di rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 58 della l. 24 novembre 1981, n. 689, per vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ragione della manifesta illogicità della motivazione e della inosservanza e/o erronea applicazione della norma penale di cui all'art. 58 della l. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con la norma di cui all'art. 545-bis c.p.p. Il richiamo a pregiudizi risalenti a oltre un ventennio addietro - quale dato ritenuto ostativo, rispetto alla formulazione di una prognosi positiva in ordine all'effetto risocializzante della invocata pena sostitutiva - si appalesa illogico, atteso che trascura la ratio delle riformate pene sostitutive.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Quando venne posta in essere la condotta oggetto di imputazione, la revoca della patente - conseguente all'emissione della misura dell'avviso orale - era ancora efficace. La fattispecie di reato contestata non è venuta meno, atteso che essa continua ad avere - quale presupposto - la revoca della patente di guida. Neppure il secondo e il terzo motivo possono essere accolti, dato che la Corte ha ampiamente motivato in merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come già sintetizzato in parte narrativa, Giuseppe D.G. è stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 159 del 2011, in ragione del fatto che, dopo aver ricevuto l'avviso orale da parte del Questore ed aver subito la revoca della patente di guida, è stato ugualmente sorpreso alla guida; in epoca successiva, però, la suddetta revoca prefettizia, inerente al titolo abilitativo alla guida, è stata a sua volta revocata. Per maggior chiarezza ricostruttiva: l'avviso orale a carico del ricorrente risale all'anno 2016; la revoca della patente di guida è intervenuta nel 2018 e l'imputato è stato sorpreso alla guida il 16 gennaio 2020; il 17 novembre 2020 è intervenuta la revoca della precedente revoca dell'abilitazione alla guida.
In ipotesi difensiva, allora, dovrebbe a tale ultima revoca riconnettersi una efficacia ex tunc, così facendone retroagire gli effetti ad un momento antecedente, rispetto a quello in cui l'imputato è stato trovato alla guida di una autovettura.
3. Il primo motivo è fondato; tale fondatezza esplica un effetto assorbente sulle residue doglianze.
Ai fini del corretto inquadramento sistematico del thema decidendum, giova premettere come la Corte costituzionale si sia occupata della dedotta questione, inerente all'art. 120 del codice della strada, in quattro distinte pronunce, ossia mediante la sentenza n. 22 del 2018, oltre che tramite le sentenze n. 24 e n. 99 del 2020 e, infine, in occasione della pronuncia n. 21 del 2022.
A fini puramente ricostruttivi giova ricordare come la sentenza Corte cost. n. 22 del 2018 - sebbene approfondendo aspetti problematici di diverso genere - abbia in via generale espresso quanto segue: «Come più volte ribadito dalla Corte di legittimità (per tutte, sezioni unite civili, sentenza 14 maggio 2014, n. 10406; sezione seconda civile, ordinanza 4 novembre 2010, n. 22491), la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. Vale a dire che, diversamente dal "ritiro" della patente disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, la "revoca" del titolo in via amministrativa, di cui alla disposizione censurata, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti e trova, viceversa, la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilasciata la patente di guida e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno».
3.1. Nella concreta vicenda, la revoca del decreto prefettizio - a sua volta, contenente la revoca della patente di guida - è stata disposta dal Vice Prefetto di Torino, a seguito della constatazione del fatto che la precedente revoca della patente fosse stata adottata in via automatica e consequenziale, ossia proprio seguendo la disciplina che, in seguito, sarebbe stata dichiarata incostituzionale da Corte cost. 99 del 2020 (in questa pronuncia, la Consulta ha censurato proprio il carattere automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, il quale, nella nuova veste "... è destinato a dispiegarsi, pertanto, sul piano di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo").
Il Vice Prefetto di Torino ha revocato in autotutela la precedente revoca, infatti, appunto dopo averne notato la derivazione automatica e necessitata, quale conseguenza indefettibile dell'imposizione di un provvedimento di prevenzione personale; ha poi conservato intatta la possibilità di avvio di un nuovo provvedimento di revoca della patente di guida, questa volta, però, all'esito della verifica della sussistenza degli effettivi presupposti di pericolosità.
3.2. Deriva da tale iter concettuale il fatto che - allorquando si pose alla guida dell'autovettura dopo che gli era stata revocata la patente - l'imputato fosse ben conscio di non essere a ciò abilitato; il presupposto storico e fattuale (ossia, l'inesistenza della specifica abilitazione alla guida) traeva origine, però, dall'applicazione di una normativa successivamente caducata dalla Corte costituzionale. E la dichiarazione di illegittimità costituzionale, come noto, postula la sussistenza di un vizio atto a inficiare ab origine una determinata norma, che si ponga in contrasto con il precetto costituzionale; tale dichiarazione, quindi, ha una efficacia che è di natura invalidante - e non abrogativa semplicemente - atteso che, in sostanza, essa produce effetti di natura equipollente all'annullamento.
La tesi secondo cui una norma di legge, pur dichiarata costituzionalmente illegittima, cessi di avere efficacia solo il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della relativa sentenza della Consulta, peraltro, va letta, infatti, alla luce della giurisprudenza Costituzionale e di quella di legittimità. Occorre risalire - in tema di efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale - alla generale distinzione esistente fra le macrocategorie concettuali dei rapporti giuridici sostanziali e dei rapporti di natura processuale, precisandosi come questi ultimi debbano ritenersi esauriti con il compimento dell'atto sulla cui normativa la Corte costituzionale ha inciso.
È ormai abbandonata, pertanto, ogni possibile forma di sovrapposizione e confusione, fra due istituti che sono radicalmente diversi tra loro - sotto il profilo strutturale e funzionale - e che sono costituiti, rispettivamente, dall'abrogazione di una norma di legge e dalla sua declaratoria di illegittimità costituzionale; trattasi di istituti che rampollano, infatti, da piani logici non sovrapponibili, che sono produttivi di effetti tra loro notevolmente difformi e che sono connotati anche da competenze diverse, tanto che si è addirittura ritenuto ammissibile il controllo di costituzionalità nei confronti di una norma già abrogata, ove ne permangano gli effetti.
Occorre richiamare, sul punto, il dictum di Sez. un., n. 17179 del 27 febbraio 2002, Conti, Rv. 221401-01, la quale, in parte motiva, ha così argomentato: «L'abrogazione, riservata al legislatore, delimita la sfera materiale di efficacia delle norme ai fatti verificatisi sino ad un certo momento, che - di solito e salva diversa disposizione della nuova legge - coincide con l'entrata in vigore di questa. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, invece, ha per presupposto l'esistenza di un vizio che inficia sin dall'origine la norma, ha efficacia invalidante e non abrogativa, produce conseguenze assimilabili a quelle dell'annullamento, nel senso che incide, in coerenza con gli effetti propri di tale istituto, anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio nel quale è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, e spiega, pertanto, effetti non soltanto per il futuro ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, con esclusione, ovviamente, di quelle situazioni giuridiche ormai esaurite, non suscettibili cioè di essere rimosse o modificate o di quelle situazioni consolidate per effetto di norme penali di favore, alle quali deve darsi comunque prevalenza ex art. 25/2° Cost., con la conseguente "irretroattività", in questo specifico caso, delle pronunce di incostituzionalità relative a dette norme di favore (cfr., a quest'ultimo proposito, Cass., Sez. un., 6 marzo 1992, Piccillo, in tema di rito abbreviato richiesto prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 442/2° c.p.p., nella parte relativa alla praticabilità di tale rito per i reati puniti con l'ergastolo). Poiché la sentenza di accoglimento del giudice delle leggi ha efficacia erga omnes ed acquista il valore di sentenza di accertamento costitutivo, con l'effetto, appunto, di annullare la norma dichiarata illegittima, il giudice ha l'obbligo di non applicare questa e tale obbligo incombe non soltanto al giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione, ma anche al giudice di un qualsiasi altro giudizio in cui la norma medesima debba o possa essere assunta a canone di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, venuto ad esistenza prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte, purché ancora in via di svolgimento e non produttivo di effetti giuridici definitivi. Conclusivamente, la disapplicazione di una norma dichiarata incostituzionale o, se si vuole, l'applicazione di una norma come innovata ed integrata dalla pronuncia d'incostituzionalità può e deve avvenire in tutti quei casi in cui, se la questione non fosse stata già decisa, il giudice potrebbe sollevarla, perché andrebbe ad incidere su un fatto o su un rapporto che, ancorché verificatosi anteriormente, è ancora controverso (nel senso che non è ancora intervenuto il giudicato, non è superato da un atto amministrativo non più impugnabile, non è maturata la prescrizione, non si è incorsi nella sanzione della decadenza o in una preclusione processuale). Eccezionalmente è la stessa Corte costituzionale che limita nel tempo l'efficacia retroattiva di alcune sue decisioni di accoglimento: ciò accade quando "un'applicazione radicale e generalizzata" dell'efficacia ex tunc di tale tipo di pronunce potrebbe "determinare gravi inconvenienti ... effetti profondamente sconvolgenti sul piano sociale, ovvero oneri economici insopportabili, rispetto a situazioni da molto tempo cristallizzate" (si confrontino, esemplificativamente, le sentenze n. 266 e 501 del 1988, n. 1 del 1991 relative rispettivamente alle declaratorie d'incostituzionalità dell'art. 15/1° l. 180/81, degli artt. 1, 3/1° e 6 l. 141/85 e dell'art. 3/1° d.l. n. 379/87). In tali casi eccezionali, inquadrabili nella c.d. illegittimità costituzionale sopravvenuta, la Corte, nel perimetrare l'efficacia temporale della propria decisione di accoglimento e nel renderla operativa dal momento in cui la legge è divenuta costituzionalmente illegittima, finisce col dare concreta attuazione alla regola, normalmente applicabile, della retroattività delle decisioni di accoglimento. Va ancora aggiunto, ribadendo quanto già sostenuto dalle Sezioni unite nelle sentenze "Galante" e "Cunsolo" del 7 luglio 1984, che non è consentito distinguere, con riguardo agli effetti retroattivi della declaratoria d'incostituzionalità, "fra norme di diritto sostanziale e norme processuali e, relativamente a queste ultime, fra applicazione diretta (con riferimento cioè alla formazione dell'atto secondo le norme poi dichiarate illegittime) e applicazione indiretta (consistente nel mero controllo dell'atto precedentemente compiuto), posto che, anche in questo secondo caso, il giudice è tenuto a rilevare l'inidoneità della normativa dichiarata incostituzionale a qualificare l'attività processuale svolta". L'immediata operatività della dichiarazione d'incostituzionalità nei giudizi non ancora definiti non può essere posta in discussione neppure "nell'ipotesi di sentenza additiva della Corte Costituzionale, e cioè quando la suddetta dichiarazione importi la sostituzione positiva di una regola del decidere con altra regola, anziché la pura e semplice caducazione di un testo normativo: con la conseguenza che, in tal caso, il giudice deve assumere come canone di valutazione esclusivamente la disciplina risultante dall'innovazione apportata dalla decisione della Corte costituzionale"».
Tale principio di diritto è stato successivamente sviluppato e approfondito dalle Sezioni unite di questa Corte; è infatti illuminante - seppur enunciata con riferimento a un diverso tema - la regola ermeneutica dettata da Sez. un., n. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, Rv. 236535-01, la quale ha precisato quanto segue: «La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia erga omnes - con l'effetto che il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in cui la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - e forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, spiegando, così, effetti non soltanto per il futuro, ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche "esaurite", e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione processuale».
3.3. Ciò posto, non vi è chi non rilevi la fondatezza del primo motivo, dovendosi considerare l'illegittimità che - in forza dei principi delle Sezioni unite Lista - si riflette sull'emanazione dell'atto, consentendo la disapplicazione ad opera del giudice della norma dichiarata in contrasto con il dettato costituzionale, secondo le coordinate teoriche ripetutamente tracciate dalla giurisprudenza di legittimità [si veda anche la parte motiva di Sez. 1, n. 34556 del 18 aprile 2023, Mihai, Rv. 285058-01 - enunciata in relazione all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ma il cui percorso deduttivo è mutuabile nel caso ora in esame - la quale ha così statuito: «In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159»; importante è anche - per le ulteriori puntualizzazioni in punto di possibilità per il giudice penale di procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo - Sez. 3, n. 8072 del 18 dicembre 2024, dep. 2025, Agliano, Rv. 287626-01, nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: «Si deve allora premettere che il dovere del giudice penale di verificare il legittimo esercizio del potere amministrativo deve essere commisurato alla peculiarità della fattispecie concreta che viene in rilievo e quindi assume effettiva possibile operatività solo per quei vizi dell'atto o più in generale della funzione, la cui esistenza possa incidere di per sé su posizioni giuridiche soggettive dell'interessato. In proposito, occorre rammentare che a fronte del combinato disposto degli artt. 4 e 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) la giurisprudenza ha intrapreso un lungo percorso di approfondimento. Si è in proposito inizialmente evidenziato che le norme in questione non introducono affatto un principio generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario (sia esso civile o penale) per esigenze di diritto oggettivo, ma che, al contrario, il controllo sulla legittimità dell'atto amministrativo è stato rigorosamente limitato dal legislatore ai soli atti incidenti negativamente sui diritti soggettivi ed alla specifica condizione che si tratti di accertamento incidentale che lasci persistere gli effetti che l'atto medesimo è capace di produrre all'esterno del giudizio. Con la conseguenza per cui la normativa in questione non potrebbe trovare applicazione per quegli atti amministrativi che, lungi dal comportare lesione di un diritto soggettivo, rimuovono invece un ostacolo al loro libero esercizio (nulla osta, autorizzazioni) o addirittura li costituiscono (concessioni). Laddove una diversa ricostruzione avrebbe segnato, secondo tale iniziale impostazione, non solo l'estensione al diritto oggettivo di una regola dettata unicamente a tutela dei diritti soggettivi, ma altresì - con violazione del principio della divisione dei poteri - l'attribuzione al giudice penale di un potere di controllo e di ingerenza esterna sull'attività amministrativa e, quindi, l'esercizio di un'attività gestionale demandata dalla legge ad altro potere dello Stato. Senza che tuttavia fosse escluso che in determinati casi il giudice penale potesse egualmente conoscere dell'illegittimità dell'atto amministrativo, ma non sul fondamento del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo riconosciutogli dagli artt. 4 e 5 della legge del 1865, bensì in base o ad una esplicita previsione legislativa (come, ad esempio, avviene con il disposto dell'art. 650 c.p.), ovvero, nell'ambito dell'interpretazione ermeneutica della norma penale, allorquando l'illegittimità dell'atto amministrativo si presenti come elemento essenziale della fattispecie criminosa (Sez. un., n. 3 del 31 gennaio 1987, Rv. 176304-01). Lungo tale solco, la giurisprudenza di legittimità ha poi ampliato - pur non generalizzandolo - il potere di disapplicazione in esame, osservando che dalla congiunta lettura degli artt. 4 e 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. e), abolitiva del contenzioso amministrativo, si evince che il potere dovere del giudice penale di disapplicare gli atti amministrativi non conformi a legge si esercita con riguardo non solo a quelli, fra tali atti, che diano luogo all'estinzione o alla modifica di diritti soggettivi, ma anche a quelli, come le concessioni o le autorizzazioni, che costituiscono diritti soggettivi o rimuovono ostacoli al loro esercizio; e ciò anche quando tali atti non siano frutto di collusione criminosa fra l'organo amministrativo ed il destinatario (Sez. 3, n. 2304 del 18 giugno 1999, Rv. 214976-01). Entro tale quadro, rimasto sostanzialmente immutato, l'attenzione si è spostata talvolta sulla natura del vizio dedotto e sulla sua capacità di incidere su una posizione soggettiva, così da poter rientrare nell'operatività del potere di disapplicazione. Si è così osservato che il giudice penale non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione dei diritti soggettivi, a meno che tale potere non trovi fondamento in una esplicita previsione legislativa, ovvero qualora la legalità dell'atto amministrativo si presenti, essa stessa, come elemento essenziale della fattispecie criminosa. Con la conseguenza per cui è ammesso il sindacato sull'atto amministrativo quando questo sia del tutto mancante dei requisiti di forma e di sostanza o inesistente, perché emesso da un organo assolutamente privo di potere, oppure frutto di attività criminosa da parte del soggetto pubblico che lo ha adottato o di quello privato che lo ha conseguito, mentre è escluso nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, pure sussistente, di emettere il provvedimento (Sez. 4, n. 38824 del 17 settembre 2008, Rv. 241064-01, Raso). Conformemente si è anche osservato, più di recente, che il sindacato da parte del giudice penale sull'atto amministrativo è ammissibile nell'ipotesi di carenza di potere, che si configura allorché l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge, mentre non è consentito nell'ipotesi di violazione delle norme che regolano l'esercizio del potere, poiché in tal caso l'atto è soltanto espressione dell'esercizio abusivo, distorto o genericamente illegittimo di un potere tuttavia esistente, onde soltanto se sia frutto di attività criminosa può essere disapplicato da parte del giudice ordinario (Sez. 3, n. 18530 del 16 marzo 2018 Cc., dep. 2 maggio 2018, Rv. 273214-01, Bianchi)»].
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'adozione di formula di rito riflettente l'insussistenza del fatto ascritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Depositata il 17 giugno 2025.