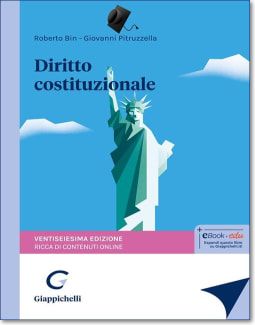Corte di cassazione
Sezione IV penale
Sentenza 26 novembre 2024, n. 13539
Presidente: Dovere - Estensore: Cenci
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma con ordinanza del 6-19 giugno 2024 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di V.C., il quale è stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro (applicata quale aggravamento della libertà vigilata già disposta contestualmente al proscioglimento per vizio totale di mente dalla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. pronunziato dal Tribunale di Roma il 12 novembre 2012), dal 24 ottobre 2016 al 20 giugno 2021, e poi alla misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, per la durata minima di anni uno, a partire dal 20 giugno 2021, infine revocata il 30 maggio 2023.
Ha ritenuto, in sintesi, la Corte di merito: che la misura di sicurezza non poteva essere applicata per un illecito contravvenzionale (art. 660 c.p.); che la misura di sicurezza della casa di lavoro, nel periodo tra il 24 ottobre 2016 ed il 20 giugno 2021, cioè per 1700 giorni, è stata eseguita in condizioni di fatto detentive; che non vi è nel caso di specie colpa concausativa della restrizione della libertà da parte del destinatario della misura; che occorre liquidare la somma di euro 235,82 al giorno (in base al noto parametro aritmetico del rapporto tra tetto massimo dell'indennizzo ex art. 315, comma 2, c.p.p. e termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 304 c.p.p., espresso in giorni, da moltiplicare per il numero di giorni di ingiusta restrizione subita: Sez. un., n. 24287 del 9 maggio 2001, Min. Tesoro e Caridi, Rv. 218975); che invece non vi è prova nel caso di specie di altri danni; e così giungendo alla somma finale di 400.894,00 euro.
2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Avvocatura dello Stato, che, ripercorsi gli antefatti, la richiesta di equa riparazione ed il provvedimento impugnato, si affida a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (il secondo ed il terzo motivo).
2.1. Con il primo motivo si duole della violazione dell'art. 314 c.p.p.
Ad avviso del ricorrente, occorrerebbe verificare se le condotte poste in essere dal ricorrente siano o meno riconducibili ad una tra le fattispecie ostative al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione e, in particolare, se V.C. abbia con la propria condotta concorso o meno a dare causa alla misura restrittiva. Al riguardo, si osserva che l'aggravamento della libertà vigilata era dipeso dal fatto che, al momento della notifica del provvedimento di scarcerazione, nel settembre 2015, il soggetto si era reso irreperibile, per poi essere denunciato, nell'ottobre 2016, per il reato di ricettazione, in quanto sorpreso a bordo di un'autovettura risultata provento di furto; nell'occasione manifestava peculiare fragilità riconducibili alle problematiche di ordine psichico da cui è affetto, connesse essenzialmente alla tossicodipendenza. Da ciò discenderebbe, ad avviso dell'Avvocatura erariale, l'esistenza di un nesso di causalità tra le condotte del ricorrente e la misura della libertà vigilata, essendo evidente che, ove non si fosse verificata la richiamata condotta illecita, non sarebbe stato ordinato l'aggravamento. La condotta del ricorrente, in altre parole, costituisce condicio sine qua non della misura restrittiva della libertà.
2.2. Con il secondo motivo censura promiscuamente ulteriore violazione dell'art. 314 c.p.p. e difetto di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica.
La decisione impugnata sarebbe affetta da un chiaro errore di diritto nella interpretazione della normativa in materia di libertà vigilata, in quanto era in un primo momento controverso in giurisprudenza se, in tema di applicazione delle misure di sicurezza, le modifiche di cui al d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito nella l. 17 febbraio 2012, n. 9, e di cui al d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito nella l. 30 maggio 2014, n. 81, avessero determinato il superamento della tradizionale distinzione tra delitti e contravvenzioni e tale situazione di incertezza è stata risolta dall'intervento della S.C. con la sentenza di Sez. 4, n. 12399 del 17 gennaio 2019, P.M. in proc. Huseynova Leyla, Rv. 275358. In conseguenza, ad avviso dell'Avvocatura erariale, al momento dell'adozione della misura della libertà vigilata nel 2016 l'applicabilità della misura [della] libertà vigilata alle contravvenzioni non costituiva un evidente errore [di] diritto ma una possibile opzione interpretativa.
2.3. Con il terzo motivo, svolto in subordine rispetto ai precedenti, parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 315 c.p.p. e, nel contempo, manifesta illogicità della motivazione. La misura della libertà vigilata, infatti, seppure gravosa, non sarebbe una misura detentiva vera e propria, sicché risulterebbe erronea ed illegittima la equiparazione tout court alla detenzione e, quindi, la conseguente determinazione dell'indennizzo nella misura di 235,82 al giorno, peraltro senza fornire motivazione.
Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 c.p.p. del 9 ottobre 2024 ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla entità della somma a titolo di indennizzo, ritenendo che il meccanismo del parametro aritmetico offra solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle peculiarità del caso concreto, e che, in ogni caso, il riferimento al criterio aritmetico, che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme nei diversi contesti territoriali, non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio innalzando o riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile. Nel caso in esame, ad avviso del P.g., sebbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la determinazione dell'indennizzo non sia stata parametrata in relazione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, inizialmente applicata illegittimamente, bensì con riferimento alla misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro, la Corte d'appello ha applicato, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il criterio matematico, determinando nella misura massima di euro 235,82 al giorno il quantum liquidabile, senza tuttavia addurre motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell'Avvocatura dello Stato è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
2. Il primo motivo è con ogni evidenza destituito di fondamento. Infatti, secondo le informazioni fornite dai giudici di merito, qualunque sia stato il comportamento posto in essere da V.C. (avere guidato un'auto rubata, essersi reso irreperibile etc.), sta di fatto che l'aggravamento, con applicazione della casa di lavoro, non poteva comunque essere disposto perché, a monte, non poteva essere adottata misura di sicurezza personale per una contravvenzione, essendo tale possibilità prevista soltanto per delitti non colposi puniti con pena superiore ad una certa soglia (art. 222 c.p.). Onde risulta privo di significato andare alla ricerca di una possibile causa sinergica addebitabile al destinatario di una misura vistosamente illegittima.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta, infatti, risolutivo e tranciante il principio di diritto fissato da Sez. 4, n. 12399 del 17 gennaio 2019, PMT in proc. Huseynova Leyla, Rv. 275358, secondo cui «In caso di proscioglimento da una contravvenzione per infermità psichica è illegittima l'applicazione, ai sensi dell'art. 222 c.p., della misura di sicurezza personale del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o di altra misura idonea individuata dal giudice, dovendosi escludere che le modifiche apportate alla disciplina in materia dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in l. 17 febbraio 2012, n. 9, e dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito in l. 30 maggio 2014, n. 81, abbiano determinato il superamento della distinzione tra delitti e contravvenzioni ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza».
Nella relativa motivazione, sub nn. 2-3 del "considerato in diritto" alle pp. 2-4, si legge, assai significativamente, quanto segue:
«È certamente vero che la materia delle misure di sicurezza ha subito una notevole trasformazione a seguito delle disposizioni normative che si sono succedute con i decreti legge n. 211/2011 e n. 52/2014, ed anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale che, con la fondamentale sentenza n. 253/2003, rifuggendo dai precedenti automatismi previsti dalla legge, ha introdotto la possibilità per il giudice di applicare la misura di sicurezza più idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.
Tali novità, tuttavia, non hanno inciso sui presupposti applicativi delle misure di sicurezza, nei termini pretesi dal ricorrente [Pubblico Ministero].
Il caso che qui rileva è specificamente disciplinato dall'art. 222 c.p., che prevede l'applicabilità del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (o di altra misura di sicurezza idonea individuata dal giudice, giusta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dianzi accennata) nei confronti dell'imputato prosciolto per infermità mentale, salvo che si tratti di contravvenzioni (come nel caso di specie), delitti colposi o delitti la cui pena non sia superiore ad un determinato limite, casi per i quali è prevista la sola comunicazione della sentenza all'autorità di pubblica sicurezza.
Si tratta di una chiara disposizione di legge che non può ritenersi superata, come preteso dal ricorrente, sulla base di un'attività interpretativa delle più recenti riforme del sistema normativo che presiede alla regolamentazione delle misure di sicurezza.
In particolare, il richiamo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52/2014, secondo cui "Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima", che secondo il ricorrente facendo la norma riferimento alla "pena detentiva" (e non alla pena della reclusione) attesterebbe il superamento della distinzione fra delitti e contravvenzioni ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, non assume particolare significato ai fini che qui rilevano, trattandosi di una generica dizione normativa che va necessariamente letta in combinazione con le norme del codice penale che regolamentano i presupposti oggettivi delle singole misure di sicurezza applicabili; sicché per "pena detentiva" non può che intendersi, con riguardo al caso di specie, quella specificamente prevista dall'art. 222 c.p., vale a dire la pena della reclusione irrogata per il delitto commesso.
La disciplina delle singole misure di sicurezza che si trae dagli artt. 222 e segg. c.p. non risulta, dunque, modificata, quanto ai presupposti applicativi, dai citati interventi legislativi e costituzionali. L'opzione legislativa di escludere le contravvenzioni (ed altri tipi di reati) dall'ipotesi di cui all'art. 222 c.p. trova evidente giustificazione nella scelta ragionevole del legislatore di non applicare una misura di sicurezza personale, sempre gravosa per la persona che la subisce, nei confronti di imputati prosciolti per reati non particolarmente gravi.
Del resto, le norme citate dal ricorrente hanno sicuramente ampliato i criteri da adottare per la scelta della misura di sicurezza più idonea al caso concreto ed introdotto un limite massimo di durata per le misure di sicurezza detentive, proprio a tutela del soggetto sottoposto a misure che, in precedenza, potevano avere una durata indefinita, persistendo i requisiti di pericolosità sociale. Un intervento legislativo, quindi, maggiormente garantista e attento ad un'applicazione misurata e di stretta necessità delle misure di sicurezza personali. Sarebbe, perciò, paradossale trarre dallo spirito di tale nuova normativa un principio di indiscriminata applicazione delle misure di sicurezza nei confronti di tutti gli imputati prosciolti per vizio totale di mente, indipendentemente dal tipo di reato commesso, delineando un sistema che, per certi versi, sarebbe ancora più gravoso e penalizzante di quello precedente [...].
Conseguentemente, bene ha fatto il giudice di merito a non applicare, nel caso concreto, alcuna misura di sicurezza, procedendosi per una contravvenzione, tipologia di reato esclusa dalla previsione di cui all'art. 222 c.p.».
Si tratta di chiara motivazione, che non offre margine per dubbi di sorta, circa la non applicabilità di gravosa misura di sicurezza personale nei confronti di imputati prosciolti per reato contravvenzionale, illecito che è il legislatore ad avere ritenuto, al momento della scelta della incriminazione, non grave.
In ogni caso, nella materia in questione non può acquisire rilevanza il livello di gravità dell'errore di diritto del giudice, che errore in materia di libertà personale è ed errore resta.
4. Quanto all'ultimo motivo, appare opportuno prendere le mosse da un passaggio della requisitoria del P.g., che, in sostanza, afferma che la Corte di appello ha dato per scontato che la restrizione nella casa di lavoro sia da equiparare tout court alla detenzione in carcere, senza offrire specifica motivazione.
L'assunto non persuade, per due ragioni.
In primo luogo, alla p. 6 la Corte territoriale informa, per quanto in un passaggio stringato, che la permanenza di V.C. dal «24.10.2016 [...] presso la casa di lavoro di Vasto dove restava fino al 20.06.2021 [... è stata] in condizioni di fatto detentive»: ebbene, con tale passaggio il ricorso non si confronta.
Inoltre, oggetto della censura svolta con il terzo motivo di impugnazione è, espressamente ed univocamente (v. ultima pagina dell'impugnazione, righe 3, 8, 16-17), solo la misura della libertà vigilata (misura antecedente al 24 ottobre 2016 e successiva al 20 giugno 2021), in relazione alla quale, però, non è stato disposto nessun indennizzo, indennizzo che, invece, ha riguardato la misura di sicurezza della casa di lavoro, che è stata (illegittimamente, come si è visto) applicata a V.C. nel lungo periodo compreso tra il 24 ottobre 2016 ed il 20 giugno 2021.
Il terzo motivo, pertanto, risulta aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato.
5. Appare a questo punto necessaria una puntualizzazione.
La Corte di merito presuppone - implicitamente - risolta in senso affermativo la questione della indennizzabilità ex artt. 314 e ss. c.p.p. della restrizione patita per effetto della illegittima applicazione della misura di sicurezza personale detentiva della casa di lavoro prevista dall'art. 215, comma 1, n. 1, c.p.
La soluzione è in effetti corretta in diritto ma va spiegata.
5.1. La S.C. ha già in altra occasione affermato, in riferimento alla misura di sicurezza detentiva di cui al n. 2 del comma 1 dell'art. 215 c.p., che «È ammissibile la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione in relazione alla restrizione della libertà indebitamente sofferta per l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura» (Sez. 4, n. 11086 del 6 febbraio 2013, Di Riso, Rv. 254938). Nella motivazione della richiamata sentenza si legge quanto segue (sub n. 2, pp. 2-4, del "considerato in diritto"):
«[...] Secondo l'insegnamento impartito da questa corte di legittimità, la restrizione della libertà personale dovuta all'adozione della misura di sicurezza del ricovero presso una casa di cura, là dove imposta al di fuori dei presupposti legislativamente previsti, deve ritenersi tale da legittimare la richiesta della riparazione per l'ingiusta detenzione subita (v. Cass., Sez. 4, n. 5001/2009, Rv. 242864).
Sul punto, varrà evidenziare come l'ultimo comma dell'art. 313 c.p.p., dettato in tema di misure di sicurezza, preveda espressamente l'equiparazione della misura prevista dall'art. 312 c.p.p. alla custodia cautelare e l'applicazione, nel caso di specie, delle norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.
Al riguardo, se è ben vero che l'art. 314 c.p.p. non opera alcun espresso riferimento all'adozione di misure cautelari diverse dalla detenzione, occorre in ogni caso che la concreta applicazione dell'art. 313, ultimo comma, c.p.p. avvenga in modo ragionevole, poiché, se il legislatore ha espressamente riconosciuto, con riguardo alle misure di sicurezza, la previsione della riparazione con l'applicazione delle stesse regole riguardanti l'ingiusta detenzione, non è lecito negare la considerazione del periodo sofferto in esecuzione di dette misure ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo.
In thema, conviene rilevare come, benché l'art. 273 c.p.p. non richiami le nozioni della "non imputabilità" e l'art. 280 c.p.p. quella della "pericolosità sociale", non di meno le esigenze cautelari devono pur sempre ritenersi collegate al pericolo della reiterazione di reati, a sua volta posto a fondamento dello stesso concetto di "pericolosità sociale" di cui all'art. 203 c.p., da ciò derivando il carattere conseguente del collegamento tra l'art. 313 c.p.p. e l'art. 314 c.p.p., trattandosi in ogni caso di procedere alla valutazione della legittimità dell'applicazione di misure sulla base di presupposti d'indole sostanzialmente comune, pena l'irragionevolezza della previsione legislativa riferita alle misure di sicurezza di cui all'art. 313 c.p.p. che, in caso contrario, rimarrebbe priva di alcuna concreta applicabilità.
Anche a non considerare l'art. 314, secondo comma, c.p.p., in base al primo comma della stessa disposizione la riparazione può essere consentita indipendentemente dall'assoluzione nel merito, secondo la modifica intervenuta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 219/2008: da ciò conseguendo il necessario riconoscimento del diritto alla riparazione per il caso del ritenuto ricorso dei riferiti presupposti».
5.2. La richiamata sentenza è in parte tributaria del ragionamento già svolto in precedenza dalla Corte di legittimità nel caso di applicazione di altra misura di sicurezza personale detentiva, cioè il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 215, comma 1, n. 3, c.p.), avendo riconosciuto che «È ammissibile la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione in relazione alla restrizione della libertà indebitamente sofferta per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario» (Sez. 4, n. 5001 del 14 gennaio 2009, Palandri e altro, Rv. 242864). Nell'occasione la S.C. ha affermato (pp. 2-3) quanto segue:
«Risulta in modo chiaro che [...] venne sottoposto alla misura provvisoria dell'internamento in OPG in modo illegittimo, perché la detta misura venne annullata in sede di appello per omessa valutazione dell'attualità della sua pericolosità.
L'art. 313 c.p.p. prevede espressamente che sia per le impugnazioni che per la riparazione si applicano le norme riguardanti la custodia cautelare ingiusta.
È ben vero che non sussiste un espresso riferimento nell'art. 314 c.p.p. a misure cautelari diverse dalla detenzione, ma occorre dare concreta applicazione all'art. 313 c.p.p., u.c. in modo ragionevole.
Il legislatore ha espressamente riconosciuto la riparazione e l'applicazione delle stesse regole che riguardano l'ingiusta detenzione per cui non si può negare che si debba considerare agli effetti dell'indennizzo il periodo sofferto in OPG.
Anche se l'art. 273 c.p.p. non richiama la non imputabilità e l'art. 280 c.p.p. non richiama il concetto di pericolosità sociale, l'esigenza cautelare è collegata al pericolo di reiterazione di reati, che è posto alla base anche del concetto di pericolosità sociale di cui all'art. 203 c.p., per cui il collegamento dell'art. 313 c.p.p. con l'art. 314 c.p.p. non può essere escluso, trattandosi in ogni caso di valutare la legittimità della misura sulla base di presupposti simili.
In caso contrario, la previsione della riparazione sarebbe priva di applicazioni concrete, il che la renderebbe irragionevole.
Anche a non considerare l'art. 314 c.p.p., comma 2, in base al comma 1 della stessa disposizione la riparazione può essere consentita indipendentemente dall'assoluzione nel merito, secondo la modifica intervenuta con la pronuncia della Corte Costituzionale 11 giugno 2008, n. 219. Ne consegue che certamente sotto tale profilo il diritto va riconosciuto.
[...] Diversamente va detto quanto al periodo di affidamento in prova al servizio sociale perché trattandosi di una modalità alternativa di espiazione della pena, che non corrisponde in alcun modo alla sofferenza della detenzione, carceraria o meno, il legislatore non ha previsto per essa alcuna riparazione».
5.3. Entrambi i precedenti di legittimità, resi in caso di applicazione di altre misure di sicurezza personali detentive, valorizzano la previsione di cui al comma 3, seconda parte, dell'art. 313 c.p.p., in tema di applicazione provvisoria di misure di sicurezza, secondo cui «Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione» e richiamano la nota pronunzia della Corte costituzionale n. 219 dell'11-20 giugno 2006, che ha dichiarato «la illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione».
Particolarmente interessante risulta, nella diffusa motivazione che sorregge la pronunzia n. 219 del 2008, il passaggio motivazionale (sub n. 6 del "considerato in diritto") ove la Consulta ha sottolineato che, con l'introduzione dell'art. 314 c.p.p. nel «nuovo codice di procedura penale [...], il legislatore ha mostrato la volontà di attrarre nell'area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una "oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post" (sentenze n. 413, n. 231 e n. 230 del 2004; n. 446 del 1997). Nel contempo, è stato analiticamente configurato un istituto, che si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta».
Infatti, proprio nei casi, di cui si è detto (rispettivamente: Sez. 4, n. 11086 del 6 febbraio 2013, Di Riso, cit.; Sez. 4, n. 5001 del 14 gennaio 2009, Palandri e altro, cit.), del ricovero in casa di cura e in ospedale psichiatrico giudiziario la Corte di cassazione, sul presupposto della richiamata declaratoria di incostituzionalità e mediante una interpretazione non a torto definita "ragionevole" del combinato disposto degli artt. 313 e 314 c.p.p., ha già ritenuto utilmente esperibile la procedura indennitaria dell'equa riparazione, procedura che, dunque, non vi è ragione di escludere - identica essendo la ratio - nel caso di applicazione della casa di lavoro, non meno restrittiva delle altre due misure di sicurezza detentive, ove la stessa risulti essere stata ingiustamente applicata in relazione ad un titolo che mai lo avrebbe consentito: ciò che è accaduto nel caso di specie.
6. Non può accogliersi la richiesta del Procuratore generale in quanto la motivazione che si rinviene a proposito del quantum indennitario alle p. 7-8 del provvedimento impugnato risulta sufficiente, non incongrua e non manifestamente illogica, oltre che in linea con i principi fissati dalla S.C. in materia (tra i quali si rammentano i seguenti: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il quantum dell'indennizzo dovuto, non è tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo, determinazione sindacabile sotto l'aspetto della motivazione solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta» e «In tema di ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta»: Sez. 4, n. 27474 del 2 luglio 2021, Spedo, rispettivamente, Rv. 281513-03 e 281513-02).
7. Essendo, in definitiva, il ricorso del Ministero manifestamente infondato e non ravvisandosi ex art. 616 c.p.p. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
8. Nel caso di diffusione del presente provvedimento deve essere omessa l'indicazione delle generalità della parte privata (art. 52, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità della parte privata ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003.
Depositata l'8 aprile 2025.