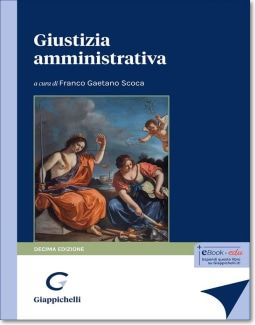Corte di cassazione
Sezione IV penale
Sentenza 15 settembre 2020, n. 28293
Presidente: Fumu - Estensore: Ranaldi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 novembre 2019 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato Carlo Ladislao R. responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. (commesso il 12 aprile 2018). È stata disposta, altresì, la revoca della patente di guida dell'imputato, stante la ritenuta sussistenza della recidiva nel biennio.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.
I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla comminata sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Deduce che nel caso non ricorre il presupposto della recidiva nel biennio, atteso che il precedente specifico concerne la violazione di reato diverso [lett. b) dell'art. 186 c.d.s.] da quello in contestazione [lett. c) dell'art. 186 c.d.s.].
Rileva, inoltre, che la recidiva non ha formato oggetto di contestazione e che comunque il precedente specifico risulta estinto.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della concessione dei doppi benefici di legge ed in particolare della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure formulate sub I) sono prive di pregio.
2. Occorre muovere dal costante indirizzo della Corte regolatrice, che va qui ribadito, secondo cui la c.d. "recidiva nel biennio" di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. (ai fini della revoca della patente di guida), costituisce una disciplina non sovrapponibile all'istituto espressamente regolato dall'art. 99 c.p. Quest'ultimo, proprio perché suscettibile di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale dell'imputato, è necessariamente destinato alla preventiva contestazione a carico dell'accusato. Non altrettanto può dirsi per la particolare disciplina della "recidiva nel biennio" di che trattasi, da cui scaturisce un mero effetto legale, rilevante sul piano amministrativo, connesso al rilievo storico della ripetizione, entro un arco di tempo predeterminato, di un illecito penale riconducibile alla fattispecie della "guida in stato di ebbrezza" previsto dall'art. 186, comma 2, c.d.s. (cfr. Sez. 4, n. 3467 del 19 dicembre 2014, dep. 2015, Borin, Rv. 26224801).
3. Il termine "recidiva" non deve, dunque, confondere l'interprete, conducendolo verso strade che non si attagliano al rigoroso statuto della (omonima) circostanza aggravante regolamentata dagli artt. 99 e segg. c.p.
Ciò non toglie che il termine evoca una parziale analogia sotto il profilo del significato terminologico e giuridico del fenomeno, nel senso di ripetizione di una condotta illecita sussumibile nella medesima fattispecie presa in considerazione dalla norma che la richiama.
In questa prospettiva, la circostanza - sottolineata dal ricorrente - che la previsione della "recidiva" in questione sia inserita nella lett. c) del secondo comma dell'art. 186 c.d.s. assume rilievo soltanto per affermare che la revoca della patente ha effetto nei soli casi in cui la (seconda) condotta illecita reiterata (nel biennio) sia riconducibile alla specifica fattispecie di cui alla lett. c).
Non vale, invece, a sostenere la tesi, propugnata dall'imputato, secondo cui per aversi tale effetto debbano essere consumati due reati sussumibili nella medesima ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 186.
È vero, infatti, che le fattispecie criminose di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 186 - l'ipotesi sub a) è stata depenalizzata con l'art. 33, comma 4, della l. 29 luglio 2010, n. 120 - costituiscono, per giurisprudenza pacifica, autonome figure di reato, disposte in ordine crescente di gravità e modellate sul tasso alcolemico accertato, caratterizzate, tra loro, da un rapporto di reciproca alternatività e, quindi, di incompatibilità (cfr., in motivazione, Sez. un., n. 46625 del 29 ottobre 2015, Zucconi).
Tuttavia, ciò non autorizza a ritenere che la "recidiva nel biennio" di cui si discute sia integrata nella sola ipotesi di reiterazione della (sola) fattispecie più grave [quella, appunto, della lett. c)]. La collocazione topografica di tale previsione normativa non costituisce argomento dirimente, poiché la lett. c) è comunque collocata nel secondo comma dell'art. 186 c.d.s., all'interno del quale è inserita anche l'ipotesi di reato di cui alla lett. b).
4. In realtà, pur trattandosi di autonome figure di reato, è indubbio che le due ipotesi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186 c.d.s. sono ricomprese nella stessa disposizione normativa che prevede la generale figura criminosa del reato di guida in stato di ebbrezza. Ed in effetti le due ipotesi hanno struttura e finalità identiche, differenziandosi fra loro solo, come già detto, per la differente graduazione dei valori-soglia del tasso alcolemico accertato.
Da questo punto di vista, mette conto osservare come la Suprema Corte (cfr. sempre Sez. un., n. 46625/2015) abbia evidenziato la diversa struttura ontologica fra la condotta di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, c.d.s.) e quella di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti alcolemici (art. 186, comma 7, c.d.s.), implicitamente riconoscendo la sostanziale omogeneità delle due ipotesi criminose di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 186.
Anche sul piano funzionale, il Supremo consesso ha rimarcato la sostanziale unitarietà di tali figure criminose, attesa la loro eadem ratio, stabilendo che lo sfondo di tutela del "reato di guida in stato di ebbrezza" di cui al comma 2 dell'art. 186 (nelle due ipotesi graduate che qui rilevano) non è quello della regolarità della circolazione, bensì quello correlato con i beni della vita e dell'integrità personale (così Sez. un., n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj).
5. Ne discende che con il termine "recidiva" (non in senso tecnico, ma col generale significato riconducibile all'aggettivo "recidivo", nel senso di chi ricade in una situazione di colpa o comunque negativa) il legislatore del codice della strada intende riferirsi semplicemente alla situazione di chi, già condannato per la commissione di una condotta illecita, penalmente rilevante, sussumibile nella generale figura criminosa del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 dell'art. 186 c.d.s., venga nuovamente condannato (nel biennio) per lo stesso reato, ma nella sua forma più grave [quella della lett. c)]. Ciò che comporta, rispetto al "non recidivo", un trattamento più severo esclusivamente sul piano amministrativo, derivandone (non la sospensione ma) la revoca della patente del soggetto condannato.
Si tratta di una disciplina che ha inteso inasprire le conseguenze di carattere amministrativo in relazione a condotte di guida accomunate da particolare gravità, in quanto poste a tutela dei beni primari della vita e della integrità fisica: la recidiva di tali condotte, nei termini dianzi accennati, è stata ritenuta espressione di una allarmante "progressione criminosa", avuto riguardo al (relativamente) breve lasso di tempo (due anni) intercorso fra reati omogenei ed alla specifica gravità della fattispecie criminosa ripetuta nel biennio [quella, appunto, della lett. c) del comma 2 dell'art. 186, caratterizzata dal più elevato valore-soglia del tasso alcolemico accertato].
6. Gli effetti eminentemente amministrativi di tale disposizione consentono di ribadire, inoltre, che è inutile, oltre che giuridicamente scorretto, paragonare - per trarne eventuali analogie normative - la "recidiva nel biennio" di cui all'art. 186 c.d.s. con il differente istituto penalistico della recidiva di cui all'art. 99 c.p.
Ciò si afferma, in relazione alla pretesa inapplicabilità, nel caso di specie, della "recidiva nel biennio", a seguito della dichiarata estinzione del precedente reato di guida in stato di ebbrezza a carico dell'imputato (per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità).
Sul punto il ricorrente, benché non esplicitamente, sembra evocare il principio affermato dalle Sezioni unite Marcianò, secondo cui l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva penalistica (Sez. un., n. 5859 del 27 ottobre 2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 25168801).
È però inutile addentrarsi nelle ragioni che hanno indotto le Sezioni unite ad un simile pronunciamento, atteso che la censura del ricorrente non coglie nel segno, proprio perché - come già accennato - essa presuppone una analogia della "recidiva nel biennio" del codice stradale con l'istituto della recidiva penale che, in realtà, non esiste sul piano della disciplina giuridica, per i motivi già ampiamente indicati nei paragrafi che precedono.
Del resto, come è stato condivisibilmente affermato, per verificare l'infondatezza della censura, è sufficiente leggere il testo dell'art. 224, comma 3, c.d.s. [applicabile in virtù del richiamo operato nello stesso art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. alle norme dettate nel Titolo VI, Capo II, Sez. II, del codice], che esclude l'incidenza dell'estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato sul procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria di revoca della patente, in combinato disposto con l'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s., che individua quale presupposto dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria l'accertamento del reato (così, in motivazione, Sez. 4, n. 1864 del 7 gennaio 2016, Oberoffer, Rv. 26558301).
Pertanto, va qui ribadito il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. (cfr. Sez. 4, n. 11719 del 15 febbraio 2019, Lisai, Rv. 27528001).
7. È, invece, fondata la censura sub II), in relazione al punto concernente la sospensione condizionale della pena.
Premesso che dalla lettura del certificato penale non sono riscontrabili a carico dell'imputato precedenti ostativi alla concessione del beneficio, si deve convenire con il ricorrente che nella sentenza impugnata difetta una valutazione adeguata in ordine alla prognosi che il giudice è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 164 c.p.; vale a dire in ordine alla probabilità/presunzione («... il giudice presume»), fondata sull'analisi delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., «che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati». Al riguardo, la concessione dei benefici è orientata a prevenire, in funzione condizionale e quindi disincentivante, la commissione di ulteriori attività criminose, nell'ambito di un giudizio probabilistico in cui non può essere indifferente la propensione a delinquere del reo (cfr. Sez. 3, n. 12828 del 18 ottobre 1999, Dal Pont, Rv. 21563601).
La Corte territoriale, nel caso, ha negato il beneficio della sospensione condizionale, esprimendosi in maniera carente e apodittica («... la motivazione del primo giudice si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui è stata rigettata la richiesta del beneficio in parola...»), mentre avrebbe dovuto improntare la giustificazione della prognosi in termini positivi ed espliciti, essendo precipuo onere del giudicante specificare sulla base di quali concreti elementi sia (o non sia) presumibile che l'imputato si asterrà, in futuro, dal delinquere, secondo una valutazione complessiva che deve necessariamente tenere conto di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.
8. In definitiva, l'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuova valutazione sul punto.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto, sicché può essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato in contestazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
Depositata il 12 ottobre 2020.