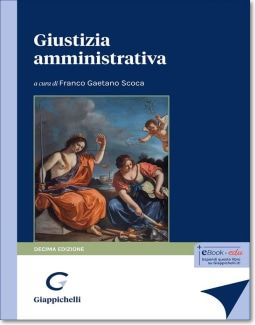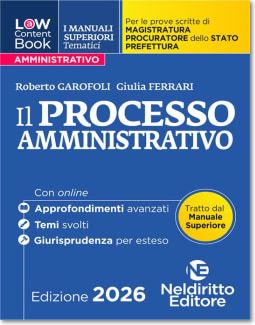Corte di cassazione
Sezione II civile
Ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25826
Presidente: Petitti - Relatore: Cosentino
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato:
che il signor Pietro M. ha impugnato per cassazione il decreto con cui la corte d'appello di Bari ha rigettato il suo ricorso per equa riparazione - limitatamente al periodo dal 6 ottobre 2011 al 22 settembre 2015 - dell'irragionevole durata di un giudizio pensionistico definito con sentenza del 22 settembre 2015, altresì condannandolo al pagamento alla Cassa delle ammende della sanzione processuale di euro 4.000 di cui all'art. 5-quater della l. n. 89/2001;
che la corte barese ha fatto applicazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89/2001 (che recita: «Non è riconosciuto alcun indennizzo ... in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile»), rigettando il ricorso del signor M. sul rilievo che la domanda da costui rassegnata al giudice contabile doveva ritenersi proposta nella piena consapevolezza della relativa inammissibilità, in quanto formulata senza indicazione dei dati anagrafici e nell'assoluta incertezza della causa petendi;
che il ricorso per cassazione si articola in sei motivi;
che l'intimato Ministero dell'Economia ha depositato controricorso;
che la causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio dell'8 marzo 2019, per la quale si sono costituiti con memoria gli eredi del ricorrente, frattanto deceduto, mentre il Ministero dell'Economia non ha depositato memorie;
considerato:
che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, giacché il primo denuncia la violazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. d), della l. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016), nonché la violazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo applicabile nella specie il menzionato art. 2, comma 2-quinquies, della l. n. 89/2001, nonostante che il giudizio presupposto si fosse esaurito prima della relativa entrata in vigore; il secondo denuncia la violazione del previgente testo dell'art. 2, comma 2-quinquies, della l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 55 del d.l. n. 83/2102, convertito con la l. n. 134/2012, che negava l'indennizzo per la non ragionevole durata del processo solo nel caso in cui la parte istante fosse stata condannata, nel processo presupposto, a norma dell'art. 96 c.p.c.;
che in sostanza il ricorrente sostiene che il principio di (tendenziale) irretroattività della legge, consacrato nell'art. 11 disp. prel. c.c., non consentirebbe di applicare il disposto del vigente testo dell'art. 2, comma 2-quinquies, l. 89/2001 nelle cause relative alla non ragionevole durata di processi definiti prima della sua entrata in vigore (1° gennaio 2016); con conseguente applicabilità del previgente testo dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. 89/2001, limitativo dell'esclusione dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del giudizio ai soli casi di condanna ex art. 96 c.p.c. nel processo presupposto;
che i suddetti motivi sono da rigettare, anche se la motivazione della sentenza gravata deve formare oggetto di correzione ai sensi dell'art. 384, u.c., c.p.c.;
che, infatti, l'assunto della corte d'appello secondo cui il testo dell'art. 2, comma 2-quinquies, l. 89/2001 novellato dalla l. n. 208/2015 sarebbe applicabile a tutte le domande di equa riparazione proposte dopo l'entrata in vigore di tale legge, anche se aventi ad oggetto la durata non ragionevole di giudizi definiti prima della relativa entrata in vigore, non può essere condiviso;
che la conclusione che precede discende dal rilievo che, là dove manchi una specifica disciplina transitoria, soccorre il costante insegnamento di questa Corte alla cui stregua il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati (in termini Cass. 16039/2016, ma si veda già la risalente Sez. un. 2926/1967);
che, alla stregua di detto insegnamento, occorre distinguere, nell'ambito delle disposizioni che sono state introdotte nel tessuto della l. n. 89/2002 dalla l. n. 208/2015, tra quelle che non incidono e quelle che incidono sulla disciplina giuridica del fatto generatore del diritto all'equa riparazione;
che tra le prime possono annoverarsi, ad esempio, le disposizioni di cui all'art. 2-bis, della l. 24 marzo 2001, n. 89 (che, disciplinando la misura dell'indennizzo, devono essere prese in considerazione in se stesse, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno), o le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2-sexies (che, dettando presunzioni iuris tantum, operano sul piano della formazione e valutazione della prova nel processo); cosicché tali disposizioni trovano applicazione anche nei giudizi di equa riparazione del danno cagionato dalla durata non ragionevole di processi definiti prima dell'entrata in vigore di detta l. n. 208/2015 (purché la domanda di equa riparazione sia stata introdotta dopo tale entrata in vigore);
che tra le seconde, per contro, rientra la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. 89/2001, come modificato dalla l. n. 208/2015, giacché la regola per la quale «non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese», impedisce, in presenza della situazione ivi indicata, l'insorgenza stessa del diritto all'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo; cosicché l'applicazione di tale regola nelle controversie in cui si discuta di indennizzo per l'irragionevole durata di giudizi svoltisi prima dell'entrata in vigore della stessa si risolverebbe nel non consentito disconoscimento degli effetti già verificatisi di un fatto passato;
che pertanto, in definitiva, la corte barese ha errato nel fondare la propria decisione sul disposto dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. 89/2001;
che, tuttavia, la decisione della corte territoriale va egualmente considerata conforme a diritto, perché - anche prima dell'entrata in vigore della l. 208/2015 e del d.l. n. 83/2012 - l'infondatezza della domanda nel giudizio presupposto ostava al riconoscimento dell'indennizzo, quando risultasse che di tale infondatezza la parte aveva «consapevolezza, originaria - allorché proponga una lite temeraria - o sopravvenuta - ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole - come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento della pretesa o di intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo, della portata della norma invocata» (così Cass. 665/2017; conf. Cass. n. 22150/2016 e Cass. 9552/2018, nonché Cass. 11939/2017, ove si specifica che «Il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001 può valutare - e poteva farlo anche nella previgente disciplina applicabile ratione temporis - anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.»; per il principio che nemmeno sotto la vigenza del testo introdotto dalla novella del 2012 la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. era indispensabile ai fini del diniego dell'equa riparazione per temerarietà delle domande o difese nel giudizio presupposto, si veda altresì Cass. 21131/2015 (seguita da Cass. 9100/2016, Cass. 24190/2017 e altre): «In tema d'irragionevole durata del processo, l'elenco di cui all'art. 2, comma 2-quinquies, della l. n. 89 del 2001 non è tassativo, sicché l'indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla l. n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali»;
che quindi, in sostanza, la modifica dell'art. 2, comma 2-quinquies, della l. n. 89 del 2001 recata dalla l. n. 208 del 2015 rappresenta la recezione legislativa di un orientamento giurisprudenziale che già precedentemente costituiva "diritto vivente", alla cui stregua l'equa riparazione da non ragionevole durata del processo non compete a chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese e, ciò, anche prescindere dalla pronuncia, nel giudizio presupposto, di una condanna ex art. 96 c.p.c.;
che i primi due motivi di ricorso vanno dunque, conclusivamente, entrambi disattesi;
che con il terzo motivo di ricorso - riferito alla violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697 e 2727 c.c., dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. 89/2001, nonché al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo controverso, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver rilevato di ufficio la temerarietà del giudizio presupposto, ancorché la convenuta Amministrazione fosse rimasta contumace e non avesse, quindi, né dedotto né provato la consapevolezza del ricorrente in ordine alla infondatezza della pretesa da lui azionata davanti al giudice contabile;
che il motivo va disatteso, avendo questa Corte già chiarito, con la sentenza n. 24190/2017, che la valutazione di temerarietà del giudizio presupposto compiuta dal giudice della domanda di equa riparazione «da un lato si sottrae al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per come interpretato da Cass., Sez. un., n. 8053/2014; dall'altro è doverosamente operata d'ufficio dal giudice di merito, essendo requisito negativo per l'esistenza del diritto, sicché non v'è luogo a discutere della pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c.»;
che con il quarto motivo di ricorso, riferito alla violazione dell'art. 324 c.p.c., il ricorrente censura la valutazione di temerarietà del giudizio presupposto operata dalla corte barese, deducendo che tale valutazione sarebbe stata preclusa al giudice della domanda di equa riparazione dal giudicato negativo implicitamente formatosi, al riguardo, con la sentenza della Corte dei conti che non aveva dichiarata temeraria la pretesa del ricorrente;
che al riguardo il ricorrente - pur dichiarando di conoscere la giurisprudenza di legittimità, sopra menzionata, alla cui stregua il giudice della domanda di equa riparazione può fare una valutazione della temerarietà del giudizio presupposto autonoma e prescindente dalla eventuale adozione, in quest'ultimo giudizio, di una condanna ex art. 96 c.p.c. - invoca, tuttavia, il principio per cui la preclusione del giudicato opera anche in relazione a giudizi che, pur avendo oggetti diversi, presentino tuttavia un elemento fondamentale in comune (Cass. 13916/2006, Cass. 9331/2016);
che infatti, secondo la prospettazione del mezzo di gravame, l'elemento della non temerarietà della domanda svolta nel giudizio presupposto sarebbe comune a quest'ultimo giudizio ed al giudizio per l'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del medesimo;
che il motivo non può trovare accoglimento, giacché i principi enunciati nei precedenti invocati dal ricorrente riguardano l'efficacia di giudicato intra partes, mentre nel mezzo di impugnazione in esame non si deduce che il Ministero dell'Economia, convenuto nel presente giudizio, fosse parte anche del giudizio presupposto;
che il quinto motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., censura l'applicazione della sanzione di euro 4.000, disposta dalla corte barese ai sensi dell'art. 5-quater l. 208/2015, lamentando l'omessa motivazione sulla quantificazione della sanzione;
che il motivo va giudicato inammissibile, perché formulato in termini non riconducibili al paradigma di cui al vigente testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il ricorrente, infatti, non enuncia alcun fatto storico decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti ed il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito;
che con il sesto motivo di ricorso il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 Cost., dell'art. 5-quater della l. n. 89/2001, introdotto dalla l. n. 208/2015, là dove esso prevede una sanzione processuale da euro 1.000 a 10.000 svincolata da criteri di proporzionalità;
che il motivo va disatteso, perché il dubbio di legittimità costituzionale ivi sollevato è stato già dichiarato manifestamente infondato da questa Corte, con la sentenza n. 5433/2016, sul rilievo che la previsione della suddetta sanzione processuale, pur costituendo un deterrente rispetto alla proposizione dell'azione, è compatibile con i parametri costituzionali ed in particolare con il principio di effettività della tutela giurisdizionale; quest'ultimo, infatti, per realizzarsi concretamente, presuppone misure volte a ridurre i rischi di abuso del processo;
che quindi, in definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento in relazione a nessuno dei motivi in cui esso si articola;
che le spese di lite si compensano in considerazione della fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata con i primi due mezzi di ricorso;
che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, risultando dagli atti che il processo è esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.