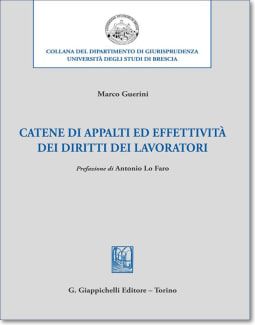Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 6 giugno 2017, n. 36769
Presidente: Rotundo - Estensore: Corbo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 27 gennaio 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha deciso il non luogo a procedere nei confronti di Luca Giuseppe Volonté in ordine al reato di corruzione per l'esercizio della funzione, per essere le condotte a lui ascritte insindacabili, in virtù della clausola d'immunità prevista dal combinato disposto degli artt. 68, primo comma, Cost., 3, comma 1, l. n. 140 del 2003, 40 Statuto del Consiglio d'Europa, 14 e 15 Accordo generale sulle immunità del Consiglio d'Europa e 3 e 5 Protocollo addizionale.
La contestazione elevata dal Pubblico ministero addebita all'imputato di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse fino al 31 dicembre 2014, indebitamente ricevuto per sé e per terzi somme di denaro per un totale complessivo di Euro 2.390.000,00 dall'esponente politico dell'Azerbaijan Elkhan Auleymanov, componente del Parlamento di quello Stato e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, e di altri esponenti politici azeri, «per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, asservendo la propria funzione pubblica ad interessi privati e del Governo dell'Azerbaijan». Secondo l'accusa, il Volonté avrebbe agito «rivestendo funzioni di pubblico ufficiale, quale membro eletto della Camera dei Deputati e sedendo, in tale qualità, all'Assemblea del Consiglio d'Europa - P.A.C.E. quale rappresentante del Parlamento italiano (incarico rivestito dal 2008 al 27 giugno 2013)». Sempre secondo l'addebito, il Volonté, in cambio della remunerazione indebita, avrebbe posto in essere diverse condotte, tra le quali quelle consistite nell'assicurare il proprio sostegno alle posizioni politiche dell'Azerbaijan, e nel compiere attività politica volta ad orientare le votazioni del proprio gruppo parlamentare in senso contrario all'approvazione del cd. rapporto Straesser avente ad oggetto le condizioni dei prigionieri politici in Azerbaijan, posto in votazione il 23 gennaio 2013; in questo modo, l'imputato avrebbe violato i doveri di fedeltà, correttezza ed onestà derivanti anche dalla Risoluzione n. 1903 adottata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa, che, in particolare, ai punti 5.5, 11 e 12, impone di non utilizzare il proprio ufficio per il proprio o altrui guadagno privato e di non accettare o richiedere compensi destinati ad incidere sulla propria condotta di membro dell'Assemblea Parlamentare.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, articolando due motivi, preceduti da una premessa sui fatti oggetto dell'imputazione, sulla ricostruzione giuridica operata nella sentenza impugnata e sulla fattispecie di cui all'art. 318 c.p. anche in relazione alla sua riferibilità a condotte poste in essere da membri del Parlamento.
2.1. Il ricorso illustra, innanzitutto, l'esito delle indagini. Premette che il Volonté, parlamentare italiano appartenente alla Camera dei Deputati fino al 14 marzo 2013, è stato, tra il 29 settembre 2008 ed il 27 giugno 2013, prima "membro supplente" e poi "membro effettivo" dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (P.A.C.E.), rivestendo anche, fino al 27 giugno 2013, la carica di Presidente del gruppo europeo del Partito Popolare. Rappresenta, inoltre, che le indagini hanno accertato l'esistenza di due accrediti tra il 27 dicembre 2012 ed il 19 marzo 2013, per una somma complessivamente pari ad Euro 400.000,00, in favore della società L.G.V. s.r.l. della quale l'imputato era amministratore unico e la moglie socia nella misura del 100% del capitale, nonché ulteriori bonifici versati sui conti della «Fondazione Novae Terrae», della quale il medesimo imputato era rappresentante legale, per complessivi 1.255.000,00, erogati tra il 17 dicembre 2012 ed il 10 giugno 2014. Aggiunge, ancora, che, all'esito dell'analisi delle mail rinvenute sui personal computer dell'indagato e del suo commercialista, è emersa la riferibilità dei bonifici all'attività svolta dal Volonté nel periodo dal 2011 al 2013 presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa per agevolare gli interessi del governo azero; inoltre, le erogazioni economiche sono risultate provenire da conti intestati a società riconducibili a cittadini azeri alimentati in buona parte da denaro proveniente da società pubbliche dell'Azerbaijan operanti nel settore della telefonia.
Il ricorso, poi, espone il contenuto della sentenza impugnata. Questa, in particolare, osserva che: a) il nucleo centrale della fattispecie di cui all'art. 318 c.p. è costituto dall'asservimento della funzione pubblica; b) per effetto della disciplina dettata dallo Statuto del Consiglio d'Europa, dall'Accordo generale sulle immunità del Consiglio d'Europa e dal Protocollo addizionale del Consiglio d'Europa, il parlamentare nazionale designato come rappresentante dello Stato italiano presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa gode di immunità di contenuto sostanziale identico a quello posto a garanzia dell'attività di ogni appartenente alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica; c) le attività addebitate in contestazione al Volonté rappresentano tutte un'esplicazione diretta della funzione parlamentare e sono come tali insindacabili; d) in conseguenza di tale insindacabilità, «pare impossibile attribuire a qualsiasi condotta di cui sopra il significato di una manifestazione dell'asservimento della funzione pubblica all'interesse privatistico», e, quindi, «l'impedimento, in ragione dell'immunità, alla verifica processuale della pubblica funzione rende inutile la celebrazione del dibattimento».
Il ricorso, a questo punto, esamina la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. e la sua riferibilità a condotte poste in essere da membri del Parlamento. Rileva che, secondo la giurisprudenza, oggetto del reato di corruzione non sono i singoli atti, ma la condotta considerata nel suo complesso, quando realizza un costante asservimento all'interesse privato; in particolare, la riforma del 2012, ha eliminato ogni riferimento agli «atti», spostando l'accento sull'esercizio delle «funzioni o dei poteri» e sottolineato il rilievo di tutti i comportamenti che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà. Osserva, inoltre, che l'art. 357 c.p. individua come pubblici ufficiali coloro i quali «esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa», che l'art. 67 Cost. impone un fondamentale dovere di autonomia del parlamentare nello svolgimento delle sue funzioni e che l'art. 54, secondo comma, Cost., prescrive ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore. Segnala, poi, che l'ipotesi della corruzione del membro del Parlamento è stata espressamente considerata dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 379 del 1996, e dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso con riferimento all'attività legislativa svolta da un consigliere regionale (Sez. 6, n. 21117 del 30 novembre 2005, dep. 2006, Castiglione, Rv. 234495).
2.2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché erronea ricostruzione dell'imputazione.
Si deduce che la sentenza impugnata esamina in modo parziale ed incompiuto i fatti indicatori dell'asservimento enucleati nel capo di imputazione. Si osserva che, «in realtà, l'imputazione descrive una prima forma di condotta di corruzione più generale ed ampia, vale a dire "l'asservimento della propria funzione pubblica ad interessi privati e del Governo dell'Azerbaijan", [...] del quale le condotte elencate rappresentano una forma (parziale) di specificazione». Si aggiunge che il delitto di cui all'art. 318 c.p. è reato di mera condotta, il quale si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa o con la ricezione dell'utilità indebita, ed in relazione al quale, dopo la riforma del 2012, è scomparso ogni riferimento alla «retribuzione». Si rileva che, pertanto, il giudice «avrebbe dovuto prendere in considerazione non solo le condotte elencate nell'imputazione, ma anche il fatto stesso dell'avvenuto accordo intercorso tra corrotto e (governo) corruttore e la promessa, da parte del parlamentare italiano di porre in essere una serie indeterminata di azioni a vantaggio dello stato azero, oggetto di mercimonio della pubblica funzione». In altri termini, «la dizione asservimento della propria funzione pubblica ad interessi privati e del Governo dell'Azerbaijan esprime anche la fase del patto corruttivo e delle singole elargizioni illecite [...]».
2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. e della normativa richiamata sulla immunità del componente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (3, comma 1, l. n. 140 del 2003, 40 Statuto del Consiglio d'Europa, 14 e 15 Accordo generale sulle immunità del Consiglio d'Europa e 3 e 5 Protocollo addizionale).
Si deduce che l'immunità prevista dall'art. 68 Cost. copre esclusivamente l'estrinsecazione della funzione parlamentare, la quale deve essere definita anche alla luce dell'evoluzione storica dell'istituto di guarentigia. Si premette che l'art. 68 Cost., nella sua formulazione originaria, aveva un ambito esteso che vietava persino la sottoposizione a procedimento penale dei parlamentari e l'esecuzione di pena detentiva per effetto di condanna penale irrevocabile, senza autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza, salvo il caso che il membro del Parlamento fosse stato colto nell'atto di commettere un delitto per il quale era obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Si rileva, poi, che la riforma costituzionale del 1993 ha mutato l'assetto delle garanzia «nella consapevolezza che il fondamento della immunità è l'esigenza di garantire l'indipendenza delle Camere e dei singoli deputati, nel rispetto del più generale principio di libertà di espressione proclamato dall'art. 21 Cost., e non anche quello di consentire al Parlamentare di usufruire dell'immunità concessa dalla Carta Costituzionale per obiettivi che non siano connessi al suo status».
Si osserva, a questo punto, che precise indicazioni in tal senso provengono dalle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2004 e n. 219 del 2003. La sentenza n. 120 del 2004 ha precisato che, nella sua elaborazione giurisprudenziale, «è enucleabile un principio, che è possibile oggi individuare come limite estremo della prerogativa dell'insindacabilità, e con ciò stesso delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili all'art. 68: questa non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera "qualità" di "parlamentare"». La sentenza n. 219 del 2003 ha precisato che «ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, è il collegamento necessario con le funzioni del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive», e che «alla stregua dell'equilibrato sistema di valori tracciato dalla Costituzione, garanzia e funzione sono inscindibilmente legate tra loro da un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica: soltanto l'effettivo e concreto esercizio delle attribuzioni parlamentari ammette un'area di insindacabilità, a salvaguardia delle prerogative del Parlamento; così come, all'inverso, è solo e nei limiti di tale fondamentale esigenza che opera l'ambito della guarentigia costituzionale».
Si rappresenta, quindi, che, nella vicenda in esame, l'aspetto rilevante è «la indebita compromissione della funzione pubblica realizzata dall'imputato in occasione dell'illecito accordo negoziale concluso con il Governo Azero per orientare l'esercizio del voto proprio e del gruppo parlamentare che presiedeva all'interno dell'Assemblea PACE». Si precisa, invero, che oggetto di contestazione «non è il voto né le valutazioni politiche a fondamento dello stesso, bensì l'accordo illecito che si cela dietro il voto e, in particolare, la compravendita della funzione parlamentare [...]». Si tratta, in altri termini, di una condotta che si pone al di fuori di una prerogativa irrinunciabile da parte del singolo proprio perché prevista, secondo quanto rilevato dalla sent. n. 9 del 1970 della Corte costituzionale, in favore dello svolgimento libero e regolare della funzione della Camera di appartenenza, «anche contro atteggiamenti del suo componente che vulnererebbero l'essenza stessa della garanzia». In questa prospettiva, è possibile richiamare proprio la sentenza n. 379 della Corte costituzionale, secondo la quale si collocano al di fuori del perimetro delle immunità parlamentari «ad esempio [...] episodi di lesioni, minacce, furti ai danni di parlamentari, corruzione, ecc.»; detta decisione, tra l'altro, sottolinea che «sono coperti da immunità non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, mentre ricadono sotto le regole del diritto comune i comportamenti estranei alla ratio giustificativa dell'autonomia costituzionale delle Camere», e che il criterio discretivo tra atti funzionali ed atti extrafunzionali è fornito dalla «qualificazione degli atti come interna corporis offerta dai Regolamenti parlamentari». Allo stesso modo, nella giurisprudenza di legittimità, si è evidenziato che «nell'esercizio di un'attività amministrativa discrezionale, ed in particolare della pubblica funzione legislativa, non può ipotizzarsi il mercanteggiamento della funzione, nemmeno qualora venga concretamente in rilievo che la scelta discrezionale non sia stata consigliata dal raggiungimento di finalità istituzionali e dalla corretta valutazione degli interessi collettività, ma da quello prevalente di un privato corruttore» (sez. 2, n. 21117 del 30 novembre 2005, dep. 2006, Castiglione, Rv. 234495). Analogamente, in dottrina, si rileva che la garanzia di cui all'art. 68 Cost. attiene prevalentemente, se non esclusivamente, all'area delle opinioni politiche in senso stretto, e che, in tale ambito, l'abuso della funzione parlamentare sarebbe integrato ogniqualvolta l'atto politico sia solo apparentemente riconducibile alla funzione pubblica.
3. Hanno presentato memoria, nell'interesse dell'imputato, gli avvocati Alessandro Pistochini e Domenico Pulitanò, quali difensori di fiducia del medesimo, articolando le loro osservazioni in quattro punti, concernenti, nell'ordine, le motivazioni della sentenza impugnata, l'infondatezza delle censure del ricorso relative alla violazione delle norme sulle immunità parlamentari, l'infondatezza delle censure del ricorso relative al vizio di motivazione e l'irrilevanza delle funzioni menzionate nel capo di imputazione.
3.1. Quanto alle motivazioni della sentenza impugnata, si osserva, innanzitutto, che, come ha condivisibilmente rilevato il giudice milanese, la prova dell'asservimento della funzione pubblica, su cui si incentra il reato di cui all'art. 318 c.p., richiede la prova non solo della prestazione data o promessa, ma anche di ulteriori «fatti indicatori dell'asservimento». Si rileva, poi, che non è specificazione dell'addebito, ma mera ripetizione dell'accusa di asservimento della funzione, il richiamo all'assicurazione di prestare il proprio sostegno alle posizioni dello Stato dell'Azerbaijan dietro versamento di somme di denaro; non sono inoltre specificazioni dell'addebito, ma mere qualifiche giuridiche le parti del capo di imputazione che riferiscono della violazione dei doveri previsti dalla P.A.C.E. (Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa). Si deduce, inoltre, che, correttamente, il giudice ha ritenuto di dover escludere la rilevanza di condotte non descritte nel capo di imputazione quali «fatti indicatori dell'asservimento», stante l'assenza di qualunque contraddittorio in proposito.
3.2. Quanto alla infondatezza delle censure esposte in riferimento alla violazione delle norme sulle immunità parlamentari, si evidenzia che il ricorso muta completamente il discorso rispetto all'imputazione. Precisamente, il ricorso del Pubblico ministero, nell'ammettere l'irrilevanza del voto espresso dall'imputato in occasione del rapporto Straesser o in altri momenti di interesse del Governo dell'Azerbaijan, ovvero ancora la sua attività politica volta ad orientare le votazioni del gruppo parlamentare di appartenenza, ha riconosciuto che dette condotte sono insindacabili perché coperte da immunità parlamentare. In questo modo, però, l'accusa assume un oggetto assolutamente generico, limitandosi a parlare di un «asservimento della funzione, negoziato col governo azero».
3.3. Quanto alla infondatezza delle censure esposte in riferimento al vizio di motivazione, si deduce che il mutamento d'impostazione effettuato nel ricorso del Pubblico ministero incide anche sul piano probatorio: le condotte coperte da immunità parlamentare, proprio per effetto della guarentigia, sono «non valutabili come prove». Si aggiunge, incidentalmente, che il Volonté, nell'esercizio delle sue funzioni, ha votato contro la richiesta di negare la competenza della P.A.C.E. ad adottare una definizione di prigioniero politico e che questa decisione, assunta proprio con il voto decisivo dell'imputato, ha evitato di bloccare la deliberazione sul rapporto Straesser; inoltre, il Volonté, anche dopo l'uscita dalla P.A.C.E., ha proseguito nell'attività politica e culturale in relazione al mondo dell'Azerbaijan. In ogni caso, comunque, «precluso il riferimento alle imputazioni specifiche relative ai modi di esercizio della funzione, l'ipotesi generica di asservimento della funzione resta priva, ad un tempo, di contenuti e di base probatoria».
3.4. Quanto alla irrilevanza delle funzioni menzionate nel capo di imputazione, si deduce che «la qualifica di membro della P.A.C.E. non vale a reggere un'accusa di corruzione passiva».
Si rappresenta, innanzitutto, che, a norma dell'art. 322-bis c.p., la corruzione passiva di pubblici ufficiali di organizzazioni internazionali è configurabile limitatamente ai funzionari dell'Unione Europea, della quale, però, non fa parte il Consiglio d'Europa.
Si rileva, poi, che non è sufficiente nemmeno richiamare la funzione di parlamentare nazionale rivestita dall'imputato: a differenza di quanto tenta di sostenere il Pubblico ministero, «in seno alla P.A.C.E., Luca Volonté non svolgeva la funzione di Parlamentare Italiano, bensì quella di membro di un organismo pubblico internazionale». Si osserva che l'imputato sedeva nella P.A.C.E. come membro della P.A.C.E., e che, a norma dell'art. 25, lett. a), dello Statuto del Consiglio d'Europa, «L'Assemblea Consultiva si compone di Rappresentanti di ciascun membro eletti dal suo Parlamento o designati secondo una procedura da questo stabilita, riservata la facoltà del governo di ciascun Membro di fare nomine completive quando il Parlamento non segga o non abbia stabilito la procedura per tale caso. Ogni rappresentante dev'essere cittadino del Membro che rappresenta. Egli non può essere nello stesso tempo membro del Comitato dei Ministri». Si desume, in conseguenza di tale dato normativo, che «la qualità di parlamentare dello Stato membro è un titolo di legittimazione, condizione di legittimità dell'elezione a membro della P.A.C.E.». Si aggiunge che i membri italiani nella P.A.C.E. non hanno vincoli di rappresentanza dello Stato italiano e sono portatori di indirizzi politici liberamente scelti, come conferma la Risoluzione n. 1490 del 2006 della P.A.C.E., laddove chiarisce che i membri dell'Assemblea godono «di uno specifico sistema di immunità europeo che è indipendente da ogni immunità nazionale di cui ciascun membro può godere» e «hanno, indipendentemente dai Parlamenti degli Stati membri, un mandato ad eseguire specifiche funzioni parlamentari derivanti dall'applicazione del Trattato di Londra del 5 maggio 1949». Si segnala, infine, che una riprova di questi rilievi è fornita dal fatto che «la qualifica e l'attività di Luca Volonté nel Parlamento italiano non sono mai state considerate, in nessuno degli atti contenuti nel fascicolo processuale», e, come tali, non hanno avuto alcun rilievo per la costruzione dell'ipotesi d'accusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
2. Le questioni da esaminare, alla luce del ricorso e delle argomentazioni della difesa, sono, in sintesi, le seguenti.
In primo luogo, deve valutarsi se l'imputazione, per come formulata dal Pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, possa riferirsi anche solo «al fatto stesso dell'avvenuto accordo intercorso tra corrotto e (governo) corruttore e la promessa, da parte del parlamentare italiano di porre in essere una serie indeterminata di azioni a vantaggio dello stato azero, oggetto di mercimonio della pubblica funzione».
In secondo luogo, occorre esaminare se il reato in contestazione, quello di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., sia configurabile anche per il solo fatto dell'accordo intercorso tra pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e corruttore, il quale abbia ad oggetto lo svolgimento della pubblica funzione o del pubblico servizio in cambio della promessa o della dazione di indebite utilità, indipendentemente dall'effettivo compimento degli atti costituenti estrinsecazione della pubblica funzione.
In terzo luogo, è necessario verificare se la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, siccome presupposto soggettivo per la configurabilità del reato di cui all'art. 318 c.p., sia riferibile, e in quale misura, all'attività del Membro del Parlamento e del Membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.
In quarto luogo, qualora siano state risolte affermativamente le questioni precedentemente indicate, ricorre l'esigenza di accertare se l'accordo intercorso tra Membro del Parlamento e corruttore, avente ad oggetto lo svolgimento della pubblica funzione o del pubblico servizio in cambio della promessa o della dazione di indebite utilità, sia o meno coperto da immunità, e possa configurare il reato di corruzione per l'esercizio della funzione.
Non deve essere, invece, scrutinata alcuna questione circa la correttezza di valutazioni prognostiche in fatto, in relazione alla sostenibilità dell'accusa in giudizio con riferimento alla sussistenza di un accordo tra il Volonté e gli esponenti politici dell'Azerbaijan, avente ad oggetto l'esercizio della funzione svolta dall'imputato in cambio di dazioni o promesse di dazioni non dovute: la sentenza impugnata, infatti, ha escluso di poter procedere ad una qualsivoglia disamina concernente le concrete condotte in contestazione in via preliminare, in conseguenza del ravvisato divieto di sindacato giurisdizionale in ordine alle stesse.
3. La prima questione attiene al contenuto dell'imputazione.
Come si è detto, occorre valutare se l'imputazione, per come formulata dal Pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, possa riferirsi anche solo «al fatto stesso dell'avvenuto accordo intercorso tra corrotto e (governo) corruttore e la promessa, da parte del parlamentare italiano di porre in essere una serie indeterminata di azioni a vantaggio dello stato azero, oggetto di mercimonio della pubblica funzione».
La risposta deve essere affermativa.
La contestazione si riferisce testualmente al «delitto di cui agli artt. 81 cpv., 318 c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, rivestendo funzioni di pubblico ufficiale, quale membro eletto dalla Camera dei Deputati e sedendo, in tale qualità, all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa - P.A.C.E. quale rappresentante del Parlamento italiano (incarico rivestito dal 2008 al 27 giugno 2013), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, asservendo la propria funzione pubblica ad interessi privati e del Governo dell'Azerbaijan, indebitamente riceveva, per sé e per terzi soggetti, somme di denaro per un totale complessivo di Euro 2.390.000,00 dall'esponente politico azero Suleymanov Elkhan, componente del Parlamento della Repubblica dell'Azerbaijan e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, dal suo collaboratore (non meglio identificato) Mammadov Muslum e da altri esponenti politici azeri non meglio identificati; in particolare ponendo in essere, tra le altre, le seguenti condotte: [...]».
Così strutturata, l'imputazione, pure sotto il profilo letterale, indica, come fatto costituente l'addebito, la ricezione di somme di denaro da parte del Volonté, nelle vesti di pubblico ufficiale, già solo in funzione del successivo esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, quindi in via programmatica rispetto ad esso; l'addebito, pertanto, non implica, necessariamente, l'effettivo compimento di attività dell'ufficio, quali quelle poi specificate ed esemplificate, «tra le altre», nel prosieguo della descrizione delle condotte, e, pertanto, a maggior ragione, prescinde anche dal contenuto di queste ultime e da una valutazione delle stesse.
4. Chiarito, nei termini appena indicati, il contenuto della contestazione, deve valutarsi se il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p. sia configurabile anche per il solo fatto dell'accordo tra pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) e corruttore in relazione allo svolgimento della pubblica funzione o del pubblico servizio in cambio della promessa o della dazione di indebite utilità, indipendentemente dall'effettivo compimento degli atti costituenti estrinsecazione della pubblica funzione.
In realtà, è ampiamente consolidata, nella giurisprudenza di legittimità, la risposta affermativa a tale quesito.
In effetti, già Sez. 6, n. 19189 dell'11 gennaio 2013, Abbruzzese, Rv. 255073, pronunciata subito dopo la riformulazione dell'art. 318 c.p. per effetto dell'art. 1, comma 75, lett. f), della l. 6 novembre 2012, n. 190, ha chiarito che la nuova fattispecie «ha sostituito alla precedente causale del compiendo o compiuto atto dell'ufficio, oggetto di "retribuzione", il più generico collegamento, della "dazione o promessa di utilità" ricevuta o accettata, all'esercizio (non temporalmente collocato, e, quindi, suscettibile di coprire entrambe le situazioni già previste nei due commi del precedente testo dell'articolo) delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio [...], così configurando, per i fenomeni corruttivi non riconducibili all'area dell'art. 319 c.p., una fattispecie di onnicomprensiva "monetizzazione" del munus pubblico, sganciata in sé da una logica di formale sinallagma [...]». Successivamente, Sez. 6, n. 49226 del 25 settembre 2014, Chisso, Rv. 261353, ha sottolineato che, per effetto della riforma, «dalla rubrica nonché dal testo dell'art. 318 c.p. è scomparso ogni riferimento all'atto dell'ufficio e alla sua retribuzione e, a seguire, ogni connotazione circa la conformità o meno dell'atto ai doveri d'ufficio e, ancora, alla relazione temporale tra l'atto e l'indebito pagamento», con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione per l'esercizio della funzione, è possibile «prescindere dal fatto che tale esercizio assuma carattere legittimo o illegittimo», né è «necessario accertare l'esistenza di un nesso tra la dazione indebita ed uno specifico atto dell'ufficio». Nel medesimo senso, in seguito, si è espressa, in particolare, Sez. 6, n. 40237 del 7 luglio 2016, Giangreco, Rv. 267634, secondo la quale, nel "nuovo" art. 318 c.p. «viene meno ogni riferimento all'atto d'ufficio ed alla sua compravendita e, per l'effetto, anche al rapporto temporale tra lo stesso e la sua retribuzione. Il nucleo centrale della disposizione diviene l'esercizio della funzione pubblica, svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato».
Tali considerazioni, peraltro, trovano piena rispondenza nelle elaborazioni dottrinali, le quali, anch'esse già subito dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, hanno evidenziato come la riformulata fattispecie di cui all'art. 318 c.p. si riferisce specificamente al «pubblico ufficiale (di livello importante) pagato in vista di una sua generica disponibilità», e, quindi, a prescindere dal concreto compimento di specifici atti o attività.
Le conclusioni di cui si è appena detto, in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 318 c.p. anche solo in presenza di un accordo avente ad oggetto l'indebita negoziazione della funzione pubblica, ed a prescindere dall'esecuzione di specifici atti o attività, sono ritenute pienamente condivisibili dal Collegio proprio in ragione della formulazione testuale della disposizione e del collegamento tra questa e quella di cui all'art. 319 c.p., che, invece, polarizza espressamente l'attenzione sul compimento di un atto dell'ufficio.
5. Va peraltro precisato che la contestazione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione, quando indica come termine di riferimento l'esecuzione di specifici atti o di specifiche attività, non implica alcuna valutazione di questi in termini di contrarietà ai doveri di ufficio, e, quindi, non presuppone alcun sindacato sul contenuto degli stessi.
Ed infatti, la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. si distingue da quella di cui all'art. 319 c.p., perché è quest'ultima che sanziona la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: solo la figura delittuosa di cui all'art. 319 c.p. richiede un sindacato riguardante il contenuto dell'atto; l'ipotesi prevista dall'art. 318 c.p., invece, si limita a postulare che la dazione o promessa di dazione indebita rivolta al pubblico ufficiale abbia ad oggetto «l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri», senza null'altro aggiungere. In questo senso, precise sono le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'art. 318 c.p. attiene a «quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del [...] mercimonio [della funzione] o in cui l'oggetto di questo sia sicuramente rappresentato da un atto dell'ufficio», essendo invece applicabile l'art. 319 c.p., «quando la vendita della funzione sia connotata da uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio» (cfr., specificamente, Sez. 6, n. 3043 del 27 novembre 2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265619, in motivazione, ma anche, tra le altre, Sez. 6, n. 8211 dell'11 febbraio 2016, Ferrante, Rv. 266510).
È utile aggiungere, ancora, che, come osservano concordemente la dottrina e la giurisprudenza (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 40237 del 7 luglio 2016, Giangreco, Rv. 267634, in motivazione), la "nuova" fattispecie di cui all'art. 318 c.p. unifica corruzione antecedente e corruzione susseguente e sanziona allo stesso modo qualsiasi caso di dazione o promessa per l'esercizio delle funzioni, anche se la dazione o la promessa siano successive al compimento dell'atto dell'ufficio.
6. Premesso che il reato di cui all'art. 318 c.p. è configurabile anche in presenza di un mero accordo tra pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) e privato avente ad oggetto l'indebita negoziazione dell'esercizio di pubbliche funzioni, indipendentemente dal concreto svolgimento di queste ultime, e che, in ogni caso, quando ha come termine di riferimento specifici atti, non implica alcuna valutazione, e, quindi, alcun sindacato in ordine al contenuto degli stessi, occorre esaminare la questione se l'attività svolta dal Membro del Parlamento e del Membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sia qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio rilevante a norma dell'art. 318 c.p.
6.1. L'attività svolta dal Membro del Parlamento, e quindi dal Deputato, è sicuramente sussumibile nell'ambito dell'esercizio delle pubbliche funzioni o, quanto meno, del pubblico servizio.
In questo senso si esprime chiaramente la dottrina, la quale ha osservato che l'inserimento della «funzione legislativa» nel testo della disposizione di cui all'art. 357 c.p., che fissa la nozione di pubblico ufficiale, elimina ogni dubbio, tanto più che detta locuzione è stata puntualmente riproposta dal legislatore all'art. 17 della l. 26 aprile 1990, n. 86, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
In questo senso, inoltre, incidentalmente, ma chiaramente, si è espressa anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 379 del 1996, allorché ha espressamente ipotizzato la configurabilità del reato di corruzione in relazione all'attività dei Membri del Parlamento italiano (cfr. la precisazione contenuta nel § 8, ultimo periodo, di tale pronuncia).
Peraltro, in dottrina, vi è stato chi ha precisato che la funzione legislativa attiene in modo specifico alla produzione legislativa e non qualifica pertanto tutte le attività svolte all'interno delle Camere. In questa prospettiva, vi è chi ha esemplificato che le attività esercitate dai Parlamentari nella Commissione di vigilanza Rai sono da ritenere appartenenti alla funzione amministrativa; altri, poi, ha specificamente preso in esame le attività di controllo e di indirizzo politico, per rappresentare che le stesse non sarebbero riconducibili né alla funzione legislativa, per l'assoluta diversità di contenuto, né alla funzione amministrativa, in quanto connaturate allo specifico ruolo di rappresentanza politica.
Tenendo conto di questi rilievi, può osservarsi, innanzitutto, in linea generale, che l'attività non strettamente connessa ad un procedimento legislativo svolta dal Parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, quand'anche fosse da ritenere non qualificabile come attività esercitata da un pubblico ufficiale, sarebbe comunque sussumibile nell'ambito del «pubblico servizio». Invero, a norma dell'art. 358, secondo comma, c.p., «per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione di mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale». Questo essendo il dato normativo, deve ritenersi che l'attività di controllo e di indirizzo politico svolta dai Membri del Parlamento, in quanto disciplinata, almeno in parte, direttamente dalla Costituzione, e sicuramente rispondente alla suprema gestione della "cosa pubblica", è, quanto meno, «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione», a maggior ragione, anzi, se si considera che quest'ultima, a norma del precedente art. 357, primo comma, c.p. non è solo quella amministrativa, ma quella «legislativa, giudiziaria o amministrativa».
Può inoltre aggiungersi che il riferimento dell'art. 358, secondo comma, c.p. al limite negativo delle mere «mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale» induce a ritenere che l'attività svolta da un Membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni non possa essere riduttivamente qualificata come svolta da persona incaricata di un pubblico servizio, ma debba essere ricompresa nell'ambito dell'esplicazione della pubblica funzione. In particolare, il riferimento alla «funzione legislativa» non sembra potersi reputare confinato al solo svolgimento dell'attività di produzione normativa in senso stretto, ma appare predicabile, come espressione di sintesi, a tutte le attività tipicamente e storicamente connesse all'attività dei Membri del Parlamento, in quanto l'art. 357, primo comma, c.p. risulta ripetere la classica tripartizione del Montesquieu dei poteri pubblici in potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario.
6.2. Tanto premesso, occorre valutare se l'attività svolta dal Membro del Parlamento italiano che agisce come Membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa vada qualificata come attività svolta da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
Anche in relazione a questo profilo, la conclusione deve essere affermativa.
6.2.1. È bene premettere che la soluzione appena indicata non discende dalla previsione di cui all'art. 10 della Convenzione penale sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, proprio su impulso del Consiglio d'Europa, e ratificata dalla Repubblica italiana in forza della l. 28 giugno 2012, n. 110. È vero che questa disposizione, rubricata «Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali», recita: «Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui all'articolo 4, quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un'assemblea parlamentare o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro», e che l'art. 4, attraverso il rinvio agli art. 2 e 3, ha riguardo alla corruzione attiva e alla corruzione passiva riferibile al «componente di un'assemblea pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi». Tuttavia, da un lato detta disposizione ha, già per come formulata, un contenuto programmatico; dall'altro, la natura programmatica e non immediatamente precettiva della previsione appena citata è ancor di più evidente se si considera che, in relazione ad essa, la Repubblica italiana ha dichiarato che si riserva il diritto di non criminalizzare gli atti di cui all'art. 4 della Convenzione che coinvolge i membri persone di un'assemblea parlamentare di un'organizzazione internazionale di cui l'Italia è membro.
Inoltre, la qualifica di pubblico ufficiale del Membro del Parlamento italiano che sia anche Membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa non discende nemmeno dalle previsioni di cui all'art. 322-bis c.p. Ed infatti, le ipotesi di cui al primo comma fanno riferimento a ben precise istituzioni internazionali o sovranazionali, sicuramente diverse dal Parlamento del Consiglio d'Europa. La ipotesi di cui al secondo comma, poi, a prescindere da ogni altra considerazione, non richiamano affatto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 318 c.p. (e nemmeno quella di cui all'art. 319 c.p.).
6.2.2. In realtà, l'attività del Rappresentante italiano nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile, a norma degli artt. 357 e 358 c.p., come attività svolta da un pubblico ufficiale, o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio (qualità comunque rilevante ai fini della configurabilità del reato di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 320 c.p.), proprio perché detto Rappresentante, pure in relazione a quello specifico contesto, svolge anche le funzioni di Membro del Parlamento italiano.
In questo senso depongono sia lo Statuto del Consiglio d'Europa, sia il Regolamento dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, sia i Regolamenti del Parlamento italiano.
Lo Statuto del Consiglio d'Europa, nel disciplinare l'Assemblea Consultiva, dal 1994 Assemblea Parlamentare, prevede, all'art. 25, in particolare, che: l'Assemblea «si compone di Rappresentanti di ciascun Membro, eletti dal suo Parlamento o designati secondo una procedura da questo stabilita [...]»; «Il mandato dei rappresentanti in tale modo designati incomincia all'apertura della sessione ordinaria successiva alla loro designazione e cessa soltanto all'apertura della sessione ordinaria seguente o d'una sessione ordinaria successiva, salvo il diritto dei Membri di fare nuove designazioni in seguito a elezioni parlamentari»; un Rappresentante può essere privato del mandato anche durante una sessione, purché l'Assemblea sia consenziente; «Ciascun rappresentante può avere un supplente autorizzato a sedere, parlare e votare in suo luogo». All'art. 26, poi, è prevista la ripartizione numerica dei seggi tra i diversi Stati Membri.
Il Regolamento interno dell'Assemblea, previsto dall'art. 28 dello Statuto, contiene numerose disposizioni su nomina e attività dei Rappresentanti degli Stati Membri, e sulle «Delegazioni nazionali».
Per quanto attiene alla nomina, il Regolamento prevede che i Rappresentanti ed i supplenti sono «eletti nel Parlamento nazionale o federale, ovvero designati tra i membri del Parlamento nazionale o federale» (art. 6.1), e che «le delegazioni nazionali devono essere composte in modo da assicurare un'equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici esistenti nei loro Parlamenti» e «comprendere membri del sesso sotto-rappresentato in percentuale almeno uguale a quella che conta il loro Parlamento» (art. 6.2). Il rispetto di questi criteri è inoltre assicurato dal potere riservato ad almeno dieci membri dell'Assemblea, appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali, di contestare le elezioni o designazioni, in particolare, anche allorché le delegazioni parlamentari nazionali non sono «composte in modo da assicurare una equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici esistenti nei loro Parlamenti» (art. 7.1, lett. b).
Per quanto attiene alla durata e allo svolgimento del mandato, il Regolamento prevede, in particolare, che i Rappresentanti ed i supplenti scadono all'apertura della sessione ordinaria successiva (art. 10.2), debbono essere rinnovati entro sei mesi dalle elezioni politiche nazionali (art. 10.3), e, in caso di decesso o dimissioni, possono essere provvisoriamente sostituiti «da un altro Rappresentante o Supplente della stessa nazionalità, in attesa di una nuova designazione da parte della delegazione nazionale interessata» (art. 10.4). Inoltre, i Rappresentanti possono anche essere sostituiti dai «Supplenti regolarmente designati dalla delegazione nazionale» (art. 11.1 e 11.2); in tal caso, «Nel firmare il registro in luogo di un Rappresentante, il Supplente impedisce al Rappresentante che sta sostituendo di votare e [...] di fungere da Supplente ad hoc per altri Rappresentanti assenti» (art. 11.3).
Per quanto attiene al ruolo ed alle funzioni delle Delegazioni nazionali, le quali sono formate dai «Rappresentanti e Supplenti designati dai Parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro» (art. 17), è importante segnalare, innanzitutto, che le stesse hanno una funzione decisiva per l'elezione dei venti Vice-Presidenti dell'Assemblea, posto che «Nessun Rappresentante o Supplente può essere eletto Vice-Presidente se la sua candidatura non è stata proposta per iscritto dal presidente della rispettiva delegazione nazionale» (art. 15.3), e per la formazione della Commissione Permanente, competente, tra l'altro, in tema di fissazione delle date delle sessioni ordinarie e di preparazione degli ordini del giorno, in quanto alla stessa partecipano anche tutti i Presidenti delle delegazioni nazionali o, in loro assenza, un Membro della delegazione regolarmente designato (art. 16.3); inoltre, il Comitato Misto tra Comitato dei Ministri ed Assemblea vede come Rappresentanti di quest'ultima, i membri dell'Ufficio di Presidenza ed un Rappresentante per ciascuna delegazione parlamentare di Stati membri non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza (art. 55.2). Numerosi poteri, poi, spettano ai Rappresentanti in quanto appartenenti alle Delegazioni nazionali: precisamente, con riferimento alle proposte di raccomandazione o di risoluzione (art. 24.2), alla richiesta di rinvio dei dibattiti in Assemblea (art. 32.2), alla richiesta di verifica del numero legale in Assemblea (art. 41.2), alla presentazione di dichiarazioni scritte (art. 53.1), non è sufficiente che l'iniziativa sia assunta da un numero minimo di Rappresentanti, ma occorre anche che questi appartengano ad un numero minimo di Delegazioni nazionali. Ancora, le composizioni delle Commissioni (art. 43.2, 43.3, 43.5, 43.8 e 43.9), e ad eventuali Sottocommissioni (art. 48.2), sono stabilite, in misura determinante, sulla base delle appartenenze alle singole Delegazioni nazionali; se, poi, «una delegazione nazionale ha, nel corso di un anno parlamentare, un livello medio di partecipazione alle riunioni di una Commissione inferiore al 33 Wo», non solo "scattano" segnalazioni interne agli organi dell'Assemblea, ma «Il Presidente dell'Assemblea lo segnala al presidente del Parlamento nazionale coinvolto e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea» (art. 43.10).
Ai fini della definizione del ruolo dei Rappresentanti eletti o designati dagli Stati membri, infine, può essere utile considerare anche che il Regolamento prevede la concessione dello «status» di «Invitato Speciale» (art. 59) di «Osservatore» (art. 60) e di «Partner per la Democrazia» (art. 61), ai «Parlamenti nazionali degli Stati non membri del Consiglio d'Europa», stabilendo inoltre che la relativa richiesta di status «è indirizzata al Presidente dell'Assemblea Parlamentare dal Presidente del Parlamento interessato».
I Regolamenti delle due Camere del Parlamento italiano, a loro volta, attribuiscono uno specifico ruolo alle «delegazioni parlamentari» presso organismi internazionali.
In particolare, il Regolamento della Camera dei Deputati, alla quale apparteneva il Volonté, all'art. 125, dopo la previsione di cui al comma 1, relativa al «deferimento» alle Commissioni competenti per materia delle «risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera», riconosce, al comma 2, primo periodo, una specifica funzione a ciascun «componente della delegazione della Camera», disponendo che «Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo».
Gli elementi normativi precedentemente indicati evidenziano una stretta compenetrazione tra le funzioni di Rappresentante italiano nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e di Membro del Parlamento italiano. A questo proposito, infatti, la qualità di Membro del Parlamento italiano quale presupposto di nomina, lungi dal costituire mera condizione di legittimazione soggettiva, come sostenuto dalla difesa, è circostanza che deve essere considerata in combinazione con: i tempi di durata del mandato di Rappresentante, collegati alla durata della vita della Camera di appartenenza; l'esigenza di assicurare, nella nomina dei Rappresentanti, la "fedele" rappresentatività dei partiti e dei gruppi politici esistenti in ciascun Parlamento nazionale; la possibilità di sostituzione del Rappresentante con un Supplente designato dalla delegazione nazionale anche per ragioni temporanee; la commisurazione dei poteri esercitabili dal singolo Rappresentante all'appartenenza alla delegazione nazionale; il ruolo riconosciuto all'interno dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa alle delegazioni nazionali in quanto tali e ai singoli Rappresentanti in quanto esponenti di queste ultime; lo stretto raccordo tra Presidente dell'Assemblea Parlamentare e Presidente del Parlamento nazionale interessato in caso di inadeguata partecipazione della delegazione nazionale alle riunioni delle Commissioni; gli specifici poteri che il Regolamento della Camera dei Deputati assegna nominativamente ai componenti della delegazione presso le assemblee internazionali. La convergenza di tutti questi elementi induce a concludere che il Membro del Parlamento italiano, quando svolge le funzioni di Rappresentante o di Supplente nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, in realtà esercita simultaneamente entrambe le funzioni.
Né tale conclusione può essere messa in dubbio in ragione della libertà di autodeterminazione del Rappresentante presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e dall'assenza di vincoli di mandato derivanti dal suo rapporto con la Camera di appartenenza: il Deputato o il Senatore, anche quando agisce nel Parlamento italiano, si autodetermina con la più ampia libertà possibile, posto che, a norma dell'art. 68 Cost., «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincoli di mandato».
7. Tenuto conto di tutto quanto precedentemente esposto, resta da esaminare la questione se debba ritenersi coperto da immunità l'accordo che, intercorso tra Membro del Parlamento, il quale esercita contestualmente anche le funzioni di Rappresentante presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, e corruttore, abbia ad oggetto lo svolgimento della funzione pubblica in cambio della promessa o della dazione di indebite utilità.
A questa domanda deve darsi risposta negativa.
7.1. La prima volta che la Corte di cassazione, in età repubblicana, ha affrontato, sia pur indirettamente, il tema in esame risale alla prima metà degli anni settanta.
In quella occasione si procedeva perché era stata promessa la dazione di un'ingente somma di denaro ad un Deputato al Parlamento, affinché presentasse e sostenesse una proposta di legge per consentire l'installazione e l'utilizzo in luoghi pubblici o aperti al pubblico di particolari apparecchi da gioco automatici e semiautomatici. Il reato ipotizzato a carico del Membro del Parlamento era quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati restituì gli atti all'Autorità giudiziaria ritenendo che ricorre un'ipotesi coperta dall'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Il giudice competente, il Pretore di Roma, dispose l'archiviazione nei confronti del Deputato in conformità, osservando che l'attività svolta dal Parlamentare, anche nella fase preliminare alla presentazione di una proposta di legge è comunque sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., sicché non sarebbe legittimata nemmeno una richiesta di autorizzazione a procedere. Il procedimento, però, continuò nei confronti dei ritenuti corruttori, ed il giudice istruttore definì il relativo procedimento dichiarando estinto per amnistia il reato di corruzione impropria antecedente, di cui agli artt. 110 e 321 c.p., quest'ultimo in relazione all'art. 318, prima parte, c.p.
La Corte di cassazione, adita su impugnazione dei ritenuti corruttori, respinse il ricorso osservando: «Il fatto che l'azione del pubblico ufficiale, nella sua sostanza non fosse illegale, perché era nei compiti dello stesso quello di proporre un disegno di legge, non rende impossibile la configurabilità di un reato, punibile a titolo di corruzione impropria, a carico di coloro che abbiano dato un qualsiasi contributo causale al fatto, e ciò indipendentemente dalla perseguibilità in sede penale del pubblico ufficiale» (così Sez. 6, n. 158 del 29 gennaio 1974, Borgognoni, Rv. 127139).
Può essere utile aggiungere che il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati che restituì gli atti all'Autorità giudiziaria, l'onorevole Giuliano Vassalli, in un saggio pubblicato successivamente alla conclusione della legislatura interessata (1968-1972), e successivamente più volte ripubblicato, precisò che la conclusione dell'Organo da lui presieduto di affermare l'insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., non solo fu controversa, ma fu molto probabilmente condizionata dal fatto che l'Autorità giudiziaria procedente aveva contestato il reato di corruzione propria invece che quello di corruzione per atto conforme ai doveri di ufficio, e per i rischi di un sindacato eccessivamente «penetrante sui motivi dell'attività legislativa». Nello stesso scritto, inoltre, dopo un'accurata analisi storico-giuridica di vicende simili nell'esperienza della Terza Repubblica francese (in relazione allo scandalo della Compagnia e del Canale di Panama) e dell'Italia liberale di fine ottocento (in relazione allo scandalo della Banca romana), concluse con pronunce giudiziarie e decisioni di autorizzazione a procedere tutte favorevoli alla configurabilità del reato di corruzione pur in presenza di disposizioni di guarentigia pressoché identiche all'art. 68, primo comma, Cost., si evidenziò che, se l'estensione dell'insindacabilità «significa, costi quel che costi, impossibilità di permettere ad altri, che non sia lo stesso Parlamento, una indagine sui motivi di un atto parlamentare tipico ed una loro condanna», non meno rilevanti e significative sono le ragioni a sostegno della soluzione contraria. Si rappresentò, in particolare, che, in riferimento alla corruzione, «si può forse dimenticare che tale delitto potrebbe benissimo consumarsi - e il più delle volte così avviene - prima del compimento, e sinanco prima dell'inizio, di qualsiasi attività parlamentare? E allora è lecito domandarsi come potrebbe un legame soltanto ipotetico od eventuale con un atto parlamentare bastare a mandare esente un fatto commesso fuori del Parlamento e inquadrabile tra quelli contrari alla legge penale». Si rilevò, poi, che la forma di corruzione ipotizzabile sembrasse essere sempre quella cd. "impropria", salvo che «in relazione a quelle attività nelle quali anche il Parlamentare è tenuto ad un dovere di fedeltà e di imparzialità: p. es. come segretario, come scrutatore, ecc.».
7.2. L'impostazione della questione e le prospettive di risoluzione hanno subito una ulteriore evoluzione in conseguenza dell'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei Membri del Parlamento per effetto della l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3, e, soprattutto, della sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996.
In particolare, nell'occasione appena indicata, il Giudice delle Leggi era stato chiamato ad esaminare il conflitto di attribuzioni promosso dalla Camera dei Deputati in relazione alla dichiarazione di non applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., da parte del giudice ordinario, con riguardo al procedimento nei confronti di due Parlamentari, accusati dei reati di falso ideologico in atto pubblico e di sostituzione di persona per essersi attribuiti falsamente la qualifica e l'identità di altri due Membri del Parlamento in una seduta della Camera e di aver partecipato alle operazioni di voto attestando falsamente la presenza e l'espressione di voto da parte di questi ultimi.
La Corte costituzionale, dopo aver evidenziato che possono prospettarsi, in linea di principio, opposte soluzioni in ordine all'estensione dell'immunità spettante ai Membri del Parlamento, rappresenta che «Né l'una né l'altra visione trova rispondenza nei principii costituzionali che definiscono la posizione delle Camere nei confronti del potere giurisdizionale. Da tali principii risulta un equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione (universalità della legge, legalità, rimozione di ogni privilegio, obbligatorietà dell'azione penale, diritto di difesa in giudizio, ecc.) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare, sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà. Sono infatti coperti da immunità non tutti i comportamenti dei Membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, mentre ricadono sotto il dominio delle regole del diritto comune i comportamenti estranei alla ratio giustificativa dell'autonomia costituzionale delle Camere, nel senso di cui ora si dirà».
Si precisa, poi, che il limite di applicabilità del diritto penale deve individuarsi nel «principio della autonomia delle Camere» definito dagli artt. 64, 72 e 68 Cost.: «È, in ultima analisi, l'autonomia delle funzioni delle Camere il bene protetto, come dimostra del resto il regime dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, Cost.). Nella giurisprudenza della Corte questa sfera di libertà non si atteggia come privilegio di un ceto politico, né solo come garanzia individuale dei Membri delle Camere, ma anche come tutela della autonomia delle istituzioni parlamentari, orientata a sua volta alla protezione di un'area di libertà della rappresentanza politica. Non a caso la difesa di questa prerogativa parlamentare non è rimessa al solo interessato, ma appartiene alle Camere come attribuzione propria (sentenza n. 1150 del 1988)».
Nell'individuare «la linea di confine tra i comportamenti dei Membri delle Camere posti sotto il presidio di tale garanzia e quelli che non possono sfuggire al diritto comune», si osserva che «la non interferenza dell'autorità giudiziaria civile o penale si afferma con la massima cogenza, in quanto essa è finalizzata al soddisfacimento del bene protetto dagli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione», in relazione a quei diritti la cui titolarità ed il cui esercizio esprimono «la garanzia del libero agire del Parlamento nell'ambito suo proprio e l'esclusiva competenza di ciascuna Camera a prevedere ed attuare i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidano negativamente sulle funzioni dei singoli Parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori. Tra questi comportamenti, aventi una natura squisitamente funzionale, è certamente da includersi l'esercizio del voto in Parlamento, alla pari - del resto - con l'esercizio di ogni altra funzione derivante dalla disciplina dei procedimenti parlamentari o dalle norme di organizzazione che ciascuna Camera si sia data autonomamente».
Si precisa poi: «Quando i comportamenti dei Membri delle Camere trovino nel diritto parlamentare la loro esaustiva qualificazione, nel senso che non esista alcun elemento del fatto che si sottragga alla capacità qualificatoria del regolamento, non possono venire in considerazione qualificazioni legislative diverse, interferenti o concorrenti, anche se da queste possa risultare il rafforzamento di un giudizio di disvalore già desumibile dalla stessa disciplina regolamentare: non può pertanto essere ammesso, in simili casi, un sindacato esterno da parte dell'autorità giudiziaria».
La conclusione, pertanto, in termini generali, è la seguente: «Allorché il comportamento di un componente di una Camera sia sussumibile, interamente e senza residui, sotto le norme del diritto parlamentare e si risolva in una violazione di queste, il principio di legalità ed i molteplici valori ad esso connessi [...] sono destinati a cedere di fronte al principio di autonomia delle Camere e al preminente valore di libertà del Parlamento che quel principio sottende e che rivendica la piena autodeterminazione in ordine all'organizzazione interna e allo svolgimento dei lavori. Se viceversa un qualche aspetto di tale comportamento esuli dalla capacità classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la disciplina di questo (perché coinvolga beni personali di altri Membri delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi) deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della Costituzione)».
Applicando il principio al caso da essa esaminato, la Corte costituzionale ha così illustrato la sua decisione di risolvere il conflitto di attribuzioni in senso favorevole alla Camera dei Deputati: «Non è, in conclusione, rinvenibile, nei fatti per i quali l'autorità giudiziaria sta procedendo, alcun elemento o frammento della concreta fattispecie che coinvolga beni o diritti che si sottraggano all'esaustiva capacità classificatoria del regolamento parlamentare (come invece accadrebbe, ad esempio, in presenza di episodi di lesioni, minacce, furti ai danni di Parlamentari, corruzione, ecc.), sicché l'attività posta in essere dai Membri delle Camere in questione non può formare oggetto di attività inquisitiva del pubblico ministero, né di accertamento da parte del giudice».
7.3. La successiva giurisprudenza della Corte costituzionale non ha affrontato casi simili, pur pronunciandosi più volte in relazione a conflitti di attribuzione tra l'una o l'altra delle due Camere e l'Autorità giudiziaria, generalmente collegati alla manifestazione di opinioni da parte di un Membro del Parlamento.
L'orientamento emergente dalla elaborazione del Giudice delle Leggi risulta essere quello di collegare la tutela assicurata dall'art. 68, primo comma, Cost. all'esercizio degli atti di funzione tipici, nonché a quelli, non tipici, ma comunque specificamente connessi alla funzione parlamentare.
In questo senso, ad esempio, si esprime la sentenza n. 120 del 2004, la quale, dopo aver richiamato anche la sentenza n. 379 del 1996, osserva come l'insindacabilità delle opinioni espresse dal Parlamentare non è totale, ma presuppone un nesso funzionale tra queste e l'attività istituzionale, perché «garanzia e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica». Analogamente, e forse in termini ancor più netti, la sentenza n. 313 del 2013 sottolinea come «le condotte "esterne" rispetto all'attività parlamentare tipica, in tanto possono godere della garanzia della insindacabilità, prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., in quanto risultino rigorosamente riconducibili alle specifiche e "qualificate" attribuzioni parlamentari», perché «qualsiasi diversa lettura dilaterebbe il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un'immunità non più soltanto funzionale, ma, di fatto, sostanzialmente "personale", a vantaggio di chi sia stato eletto Membro del Parlamento»; detta sentenza, per di più, cita anche la giurisprudenza della Corte E.D.U. che, pronunciandosi con riferimento alla insindacabilità delle opinioni dei Parlamentari, ha più volte rilevato come debba considerarsi estranea alla garanzia della insindacabilità un comportamento che non sia connesso «all'esercizio di funzioni parlamentari stricto sensu». Ancora, la sentenza n. 221 del 2014 precisa che lo scrutinio relativo alla sussistenza del nesso funzionale tra opinione divulgativa ed atti parlamentari tipici, ai fini dell'applicazione della garanzia dell'insindacabilità, deve essere condotto secondo un criterio di adeguatezza e di proporzionalità, in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte E.D.U.
7.4. Indicazioni contrarie ad una latissima estensione dell'immunità in favore del Parlamentare possono rinvenirsi anche nella giurisprudenza di legittimità e, ancor più decisamente, in dottrina.
La Corte di cassazione, pur non occupandosi del tema della configurabilità di un reato di corruzione commesso da un Membro del Parlamento, ha esaminato la questione relativa ai comportamenti tenuti da un Consigliere regionale nel corso di un procedimento legislativo, per alcuni aspetti simile, in considerazione dell'immunità riconosciuta dall'art. 122, quarto comma, Cost. (Sez. 6, n. 21117 del 30 novembre 2005, dep. 2006, Castiglione, Rv. 234495). La pronuncia, emessa con riferimento ad un ricorso in materia di sequestro probatorio, disposto con riguardo alla più grave ipotesi di reato di corruzione propria ex art. 319 c.p., ha escluso che la garanzia di cui all'art. 122 Cost. («I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni») sia applicabile «qualora il consigliere regionale non sia perseguito dal giudice penale per avere concorso alla formazione ed all'approvazione di una legge regionale ma, come appare nell'ipotesi in esame, per comportamenti che "si assume essere stati realizzati con soggetti non partecipi a tale procedimento" al fine di predisporre le condizioni per il conseguimento di un vantaggio illecito».
Gran parte della più recente dottrina, poi, esclude espressamente l'operatività della garanzia di cui all'art. 68, primo comma, Cost., nel caso di atti che integrano l'abuso di funzioni parlamentare.
In particolare, vi è stato chi ha osservato: «Nessun dubbio che un Parlamentare possa commettere peculato per appropriazione o peculato d'uso rispetto ai beni a sua disposizione per l'esercizio della funzione; allo stesso modo i delitti di corruzione e concussione si applicano in relazione a quelle condotte in cui l'attività del parlamentare viene strumentalizzata al conseguimento di una retribuzione illecita: la ricezione o la promessa di denaro ad un Parlamentare per indurre lo stesso a passare ad altro gruppo parlamentare o per condizionare l'esercizio di voto in assemblea costituiscono esempi di abuso della funzione legislativa ed il pactum sceleris ricade nell'ambito dei delitti di corruzione». Altri, ancora, icasticamente, hanno rilevato: «L'estendere la liceità a tutti i peculati, malversazioni, concussioni, fatti di corruzione, di abuso di ufficio, ecc. che il Parlamentare può commettere, ricorda il comportamento di chi "libito fé licito in sua legge"».
Può aggiungersi che la tesi contraria alla configurabilità del reato di corruzione per l'esercizio della funzione risulta essere stata sì recentemente sostenuta in dottrina, ma per ragioni diverse dal richiamo al principio di cui all'art. 68, primo comma, Cost., ritenuto specificamente ostativo alla sola fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. Secondo questa opinione, precisamente, la figura criminosa di cui all'art. 318 c.p. implica «un profilo di disvalore difficilmente riferibile all'attività politico-parlamentare ed insuscettibile di autonomo apprezzamento se non nell'ambito di una valutazione di merito del rapporto instauratosi fra sollecitazioni private e funzione di rappresentanza», posto che «l'inevitabile contaminazione tra interessi particolari ed interessi collettivi che caratterizza le scelte politiche non consente di individuare, nella fattispecie meno grave [quella di corruzione per l'esercizio della funzione], un substrato fattuale immediatamente percepibile».
7.5. Tirando le fila del discorso, deve ritenersi che l'immunità prevista dall'art. 68, primo comma, Cost. non preclude la perseguibilità del reato di corruzione per esercizio della funzione in relazione all'attività del Membro del Parlamento.
Innanzitutto, la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. non implica alcun sindacato sull'esercizio della funzione. Invero, quando la condotta del Parlamentare presa in esame è esclusivamente quella che si concreta nella stipulazione di un accordo per l'esercizio delle sue funzioni in cambio della promessa o della dazione di una indebita utilità, ai fini delle valutazioni del giudice penale è indifferente l'effettivo, successivo esercizio di tali funzioni, e, quindi, non si verifica alcun sindacato sullo svolgimento dell'attività del Membro delle Camere, per come si estrinseca negli atti tipici e negli atti non tipici specificamente connessi alla sua funzione. Allo stesso modo, allorché la condotta del Parlamentare che viene in rilievo è quella consistente nell'accettazione della promessa o della dazione di una indebita utilità per aver compiuto un atto o un'attività relativa all'esercizio delle proprie funzioni, al giudice penale è indifferente il contenuto intrinseco dell'atto o dell'attività, posto che assumono significato solo la ricezione della promessa o della dazione in quanto correlate al precedente compimento dei medesimi, i quali, per di più, integrano esclusivamente il presupposto della condotta illecita.
In secondo luogo, poi, deve aggiungersi che, così come richiesto da Corte cost., sent. n. 379 del 1996, le condotte appena descritte non possono dirsi sussumibili, interamente e senza residui, sotto le norme del diritto parlamentare, né può dirsi che non esista alcun elemento del fatto che si sottragga alla capacità qualificatoria del regolamento parlamentare: la negoziazione mercantile della funzione e l'accettazione di un'indebita remunerazione si pongono nettamente al di là e al di fuori di ogni disciplina e qualificazione contenuta nei regolamenti delle Camere.
Del resto, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 379 del 1996, mai contraddetta successivamente, ha espressamente indicato tra i fatti di reato non coperti da immunità ex art. 68, primo comma, Cost., a titolo esemplificativo, proprio quelli di «corruzione».
7.6. Le conclusioni raggiunte non mutano, ma trovano ulteriore rafforzamento, in riferimento all'attività del Membro del Parlamento italiano che svolga anche le funzioni di Rappresentante di questo all'interno dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, in considerazione delle immunità riconosciutegli in questa qualità.
L'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949, aveva attribuito ai Rappresentanti e Supplenti degli Stati membri all'interno dell'Assemblea Consultiva (ora Assemblea Parlamentare) il godimento «sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai Membri del Parlamento del loro paese» (art. 15). Detto Accordo, peraltro, aveva previsto che i privilegi e le immunità, anche dalla giurisdizione, riconosciuti ai rappresentanti del Comitato dei Ministri, «sono concessi ai rappresentanti dei Membri non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all'esercizio del loro ufficio [...]. Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l'immunità del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, la stessa impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa» (art. 11).
Successivamente, il Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1949, ha espressamente precisato che il limite già indicato per i rappresentati del Comitato dei Ministri opera anche per i Rappresentanti e Supplenti degli Stati membri nell'Assemblea Consultiva (ora Assemblea Parlamentare). In particolare, l'art. 5 del Protocollo così dispone: «Questi privilegi, immunità e agevolezze sono concesse ai rappresentanti dei Membri, non per il loro utile, ma per assicurare piena indipendenza all'esercizio del loro ufficio rispetto al Consiglio d'Europa. Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l'immunità del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, la stessa impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa».
7.7. Deve escludersi, infine, che la configurabilità del reato di corruzione per l'esercizio della funzione sia in linea di principio preclusa dalla specificità della funzione parlamentare, in quanto caratterizzata da una «inevitabile contaminazione tra interessi particolari ed interessi collettivi».
Indubbiamente, l'osservazione pone in evidenza l'esigenza di valutare con estrema attenzione il profilo concernente la qualificazione dell'utilità data o promessa come "indebita". Tuttavia, se lo svolgimento dell'attività politica si caratterizza, anche istituzionalmente, per una costante, ed anche doverosa, attività di "compromesso" e di composizione di interessi di "parte", in tale ambito non può ritenersi rientrare la ricezione di utilità, anche estremamente rilevanti, come ad esempio cospicue somme di denaro, a titolo meramente personale: in questa ipotesi, infatti, si fuoriesce dalla attività di composizione e di rappresentanza di interessi, e si perviene ad uno "sfruttamento" a fini privati dell'esercizio dell'altissimo ufficio pubblico ricoperto.
Del resto, in linea generale, che il reato di corruzione sia configurabile anche in relazione all'esercizio di funzioni parlamentari è confermato non solo dall'esplicito riferimento della Corte costituzionale nella sentenza n. 379 del 1996, ma anche da significativi elementi normativi.
Da un lato, infatti, può richiamarsi l'art. 4 della già citata Convenzione penale sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e ratificata dalla Repubblica italiana in forza della l. 28 giugno 2012, n. 110. Secondo questa disposizione: «Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un'assemblea pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi»; gli artt. 2 e 3 della Convenzione, dal canto loro, hanno riguardo, rispettivamente, alla corruzione attiva e alla corruzione passiva di agenti pubblici nazionali e, precisamente, si riferiscono al fatto degli «agenti pubblici di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi indebito vantaggio per se stesso o per altra persona, o di accettarne l'offerta o la promessa per compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni». Ed infatti, dette previsioni, nemmeno coperte da riserva, a differenza di quella di cui all'art. 10, pur se non immediatamente precettive, hanno comunque una sicura rilevanza ai fini dell'interpretazione delle disposizioni normative vigenti sotto il profilo sistematico.
Dall'altro, poi, è doveroso far riferimento all'art. 322-bis c.p., laddove prevede: «Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri [...] del Parlamento europeo [...]». Con questa disposizione, introdotta dall'art. 3, comma 1, della l. 29 settembre 2000, n. 300, è testuale la previsione della configurabilità dei reati di corruzione a carico dei Membri del Parlamento europeo. Ciò posto, ed in difetto di precisi ostacoli normativi, sembra paradossale e privo di coerenza sistematica ritenere che le fattispecie di corruzione non siano ipotizzabili a carico dei Membri del Parlamento italiano e siano invece configurabili nei confronti dei Membri del Parlamento europeo, che pure svolgono un'attività di contenuto molto simile ai primi, sono tutelati da pressoché identiche guarentigie, e sono diretta espressione, e rappresentanza, del medesimo corpo elettorale che elegge la Camera dei Deputati.
8. L'inapplicabilità della garanzia di immunità - come prevista dal combinato disposto degli artt. 68, primo comma, Cost., 3, comma 1, l. n. 140 del 2003, 40 Statuto del Consiglio d'Europa, 14 e 15 Accordo generale sulle immunità del Consiglio d'Europa e 3 e 5 Protocollo addizionale - nell'ipotesi in cui si proceda per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, stante l'assenza di qualunque sindacato sul merito dell'attività funzionale svolta dal Membro del Parlamento italiano che agisca anche nell'esercizio delle funzioni di Membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, e l'astratta configurabilità, nei confronti del medesimo, del reato di corruzione a norma dell'art. 318 c.p., impongono al giudice, davanti al quale sia esercitata l'azione penale, di procedere alle valutazioni ed al giudizio secondo le regole comunemente stabilite.
Nella vicenda in esame, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano non ha compiuto alcuna valutazione prognostica sugli elementi sottoposti alla sua cognizione, al fine di verificare la sostenibilità in dibattimento dell'accusa concernente il reato di cui all'art. 318 c.p., ma, nel pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, si è fermato, in via preliminare, a rilevare, erroneamente, l'insindacabilità delle condotte ascritte all'imputato, e, quindi, l'operatività della clausola di immunità.
Di conseguenza, la sentenza di non luogo a procedere, impugnata in questa sede, deve essere annullata, e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Milano, ufficio del giudice per l'udienza preliminare, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano, ufficio del giudice per l'udienza preliminare, per l'ulteriore corso.
Depositata il 24 luglio 2017.