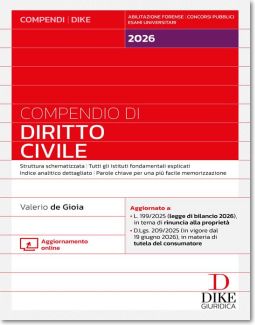Corte costituzionale
Sentenza 13 ottobre 2025, n. 146
Presidente: Amoroso - Redattrice: Navarretta
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile, nel procedimento vertente tra M. T. P. e A. C., con ordinanza del 4 settembre 2024, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 4 settembre 2024, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede, al primo comma, che l'attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova, produrre documenti e formulare le istanze di prova, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti.
1.1.- Il rimettente riferisce che, con ricorso depositato il 31 luglio 2023, M. T. P. ha chiesto al Tribunale di Genova di modificare le condizioni di separazione personale dal marito A. C., disponendo l'aumento del contributo al mantenimento di una delle figlie della coppia, studentessa maggiorenne non economicamente indipendente, a fronte delle sue mutate esigenze di vita, nonché delle migliorate condizioni economiche del convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 ottobre 2023, quest'ultimo si è costituito in giudizio, opponendosi alla domanda di modifica delle condizioni di separazione. In via riconvenzionale, ha inoltre chiesto il divorzio dalla moglie, unitamente alla conferma del contributo economico stabilito in sede di separazione per il mantenimento della figlia studentessa e alla revoca del contributo dovuto per il mantenimento dell'altra figlia maggiorenne, divenuta economicamente autosufficiente.
Con successiva memoria, ex art. 473-bis.17 cod. proc. civ., depositata l'8 novembre 2023, la ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di divorzio formulata dal convenuto, per mancanza di connessione oggettiva rispetto a quella di modifica delle condizioni di separazione.
1.2.- Il giudice a quo riporta che, all'udienza del 28 novembre 2023, le parti hanno raggiunto un accordo sul mantenimento della figlia in costanza di separazione, ma non sono pervenute a una soluzione condivisa in merito alla domanda di divorzio.
Inoltre, la parte ricorrente ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui assegna all'attore un termine di soli dieci giorni per prendere posizione sulle eventuali domande riconvenzionali svolte dal convenuto.
2.- Il Tribunale di Genova, trattenuta la causa in decisione, ha sollevato le odierne questioni di legittimità costituzionale.
In via preliminare, ha disatteso l'eccezione con cui l'attrice ha contestato l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di divorzio nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione. Ha, infatti, ravvisato una connessione oggettiva fra la domanda di modifica delle condizioni di separazione e quella di divorzio, tale da rendere ammissibile una loro trattazione unitaria.
A tal riguardo, ha evocato la sentenza della Corte di cassazione, prima sezione civile, 16 ottobre 2023, n. 28727, che ha ammesso la contestuale domanda di separazione e di divorzio anche nelle procedure di natura congiunta, ai sensi dell'art. 473-bis.51 cod. proc. civ. In particolare, la citata pronuncia ha individuato la ratio della novella legislativa nella realizzazione di un coordinamento fra procedimenti, aventi a oggetto pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni, e ha evidenziato gli inconvenienti derivanti in passato dalla trattazione di tali controversie nell'ambito di distinti giudizi.
3.- Svolta tale premessa, il rimettente è passato a illustrare i dubbi di legittimità costituzionale.
3.1.- Ad avviso del Tribunale di Genova, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) avrebbe introdotto, con l'art. 473-bis.17 cod. proc. civ., un termine troppo breve per consentire all'attore di proporre domande ed eccezioni che traggono origine dalle difese del convenuto.
Mentre, infatti, quest'ultimo «ha a disposizione almeno 30 giorni per impostare la difesa e formulare le sue eccezioni e domande riconvenzionali, l'attore deve prendere posizione sulle domande e difese avversarie, modificare le proprie domande, formulare le eventuali eccezioni e domande nuove che sono la conseguenza delle domande avversarie e i relativi mezzi di prova, entro l'esiguo termine di 10 giorni, che spesso si riduce a 9 o anche meno se la comparsa conclusionale viene depositata l'ultimo giorno disponibile e scaricata quindi dalla Cancelleria il giorno successivo».
Il giudice a quo osserva che, in questa materia, le domande riconvenzionali del convenuto introducono temi spesso complessi, sui quali l'attore è chiamato a predisporre le proprie difese «in un termine assolutamente incongruo».
In particolare, con riferimento al caso sottoposto al suo esame, il rimettente rileva come, a fronte della domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal convenuto, l'attrice abbia avuto un termine troppo limitato «per formulare domanda di assegno divorzile che, come noto, si fonda su presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento del coniuge in sede di separazione implicando una ricostruzione delle scelte compiute dalle parti nel corso della vita matrimoniale, spesso di lunga durata, con conseguente necessità di formulare le relative istanze di prova».
Ciò determinerebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., nonché una violazione della parità delle armi e, in generale, dei principi del giusto processo, recati dall'art. 111 Cost.
3.2.- Il rimettente ravvisa una violazione anche del principio di eguaglianza, ai sensi dell'art. 3 Cost., «dal momento che situazioni uguali ottengono un trattamento giuridico differente».
Nello specifico, pone a raffronto la disciplina dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie con altri giudizi previsti dal codice di procedura civile, alcuni dei quali parimenti riformati dal d.lgs. n. 149 del 2022. Dalla comparazione inferisce che in nessun caso sarebbe attribuito all'attore un termine così ridotto per reagire alle difese della controparte.
In particolare, richiama la disciplina del rito ordinario di cognizione, nella quale il convenuto dispone di almeno trenta giorni per adeguare le proprie difese rispetto all'eventuale domanda riconvenzionale avversaria (artt. 166, 167 e 171-ter cod. proc. civ.).
Di seguito, evoca il rito semplificato di cognizione, nel quale il convenuto deve costituirsi entro dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice e, ai sensi dell'art. 281-duodecies, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., «in caso di domanda riconvenzionale» - secondo quanto specifica il rimettente - «l'attore può chiedere un termine perentorio non superiore a 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, [...] disponendo così di 30 giorni per riorganizzare la propria difesa».
Ancora, il Tribunale di Genova fa riferimento al passaggio dal rito semplificato a quello ordinario, nel quale, ai sensi dell'art. 281-duodecies, primo comma, cod. proc. civ., il giudice «dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c.».
Infine, il rimettente si riporta anche alla disciplina del processo del lavoro, in base alla quale, se il convenuto propone domanda riconvenzionale, deve chiedere al giudice, a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza di discussione, che deve essere fissata a una distanza di non più di cinquanta giorni dalla proposizione della domanda riconvenzionale (art. 418, commi primo e secondo, cod. proc. civ.).
In tale quadro, l'art. 473-bis.17 cod. proc. civ. costituirebbe un caso isolato di irragionevole compressione dei termini per la difesa dell'attore.
4.- Il giudice a quo ritiene di non poter supplire a simili carenze con un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, data la perentorietà dei termini stabiliti dal codice di rito a pena di decadenza. Esclude, inoltre, di poter disporre la rimessione in termini della parte, ai sensi dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., poiché in tal modo finirebbe con l'introdurre «un meccanismo di slittamento automatico della prima udienza con conseguente concessione ex novo di tutti i termini ex art. 473-bis.17 c. p. c. non previsto dal legislatore».
5.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare inammissibili e comunque non fondate le questioni sollevate.
5.1.- In via preliminare, la difesa statale ha osservato che la censura deve ritenersi circoscritta all'art. 473-bis.17, primo comma, cod. proc. civ.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, il rimettente, pur riferendosi nel dispositivo all'intero art. 473-bis.17 cod. proc. civ., nella motivazione, si concentra esclusivamente sulla brevità del termine che il primo comma del richiamato articolo assegna alla parte attrice, onde spiegare la propria difesa in risposta al convenuto.
5.2.- In rito, il Presidente del Consiglio dei ministri solleva tre eccezioni.
5.2.1.- In primo luogo, ravvisa un difetto di rilevanza, reputando inammissibile che, nell'ambito di un giudizio instaurato per la modifica delle condizioni di separazione relative al mantenimento della prole, il convenuto faccia valere una domanda riconvenzionale di divorzio, che induce di riflesso l'attore a domandare in replica l'assegno divorzile.
Mancherebbe un qualsiasi rapporto di connessione oggettiva o di continenza tra la domanda relativa alla quantificazione del contributo economico per il mantenimento della prole nella separazione personale e quella concernente il divorzio, che si riverbera anche sulla conseguenziale richiesta dell'assegno divorzile.
5.2.2.- In secondo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene carente il requisito della rilevanza anche per un'ulteriore ragione, correlata alla circostanza che la parte attrice avrebbe in concreto avuto a disposizione sedici giorni per prendere posizione rispetto alla domanda riconvenzionale. L'udienza, infatti, si è svolta il 28 novembre 2023, a fronte di una costituzione del convenuto avvenuta il 23 ottobre 2023, sicché la ricorrente, che ha depositato la prima memoria successiva alla comparsa di costituzione del convenuto in data 8 novembre 2023, avrebbe potuto di fatto avvalersi di un termine più lungo dei dieci giorni sui quali si incentra la doglianza del giudice a quo.
Secondo la difesa statale, la motivazione in punto di rilevanza delle questioni sollevate non sarebbe, pertanto, adeguata, poiché farebbe riferimento al termine applicabile in astratto, omettendo «qualsiasi effettiva verifica di congruità del termine di cui parte attrice ha potuto in concreto disporre».
5.2.3.- Infine, l'Avvocatura osserva che il rimettente, nel porre a raffronto la disciplina del giudizio unificato della famiglia con tre diversi riti presenti nell'ordinamento, non avrebbe indicato il modello attraverso il quale ricondurre a legittimità costituzionale la norma censurata.
Questo - a giudizio della difesa statale - comporterebbe l'inammissibilità delle censure, stante il carattere manipolativo dell'intervento richiesto a questa Corte.
5.3.- Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene prive di fondamento le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, per costante orientamento di questa Corte, il legislatore godrebbe di un'ampia discrezionalità in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute.
Nel caso in esame, «[l]a previsione del termine di almeno dieci giorni per consentire all'attore di replicare alla domanda riconvenzionale del convenuto non [potrebbe] ritenersi il frutto di una scelta viziata da manifesta irragionevolezza, ma costitui[rebbe] l'espressione di un coerente bilanciamento dell'interesse dell'attore di disporre di un tempo adeguato per la predisposizione delle proprie difese, con l'obiettivo, di rilevante interesse pubblico, di pervenire in tempi brevi alla definizione del procedimento giurisdizionale in ambito familiare».
Quanto alla censura relativa alla violazione del principio di eguaglianza, l'Avvocatura osserva che le situazioni giuridiche soggettive poste a raffronto sarebbero «differenti siccome afferenti a diversi riti processuali: tutte [sarebbero] meritevoli di tutela, ma non necessariamente della stessa tutela».
Da tale disomogeneità dei tertia comparationis inferisce la non fondatezza anche della censura sollevata con riguardo all'art. 3 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il Tribunale di Genova, sezione quarta civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 224 del 2024), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede, al primo comma, che l'attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti.
Il rimettente ritiene che il termine assegnato all'attore per proporre domande ed eccezioni che traggono origine dalle difese del convenuto, nonché per presentare nuovi mezzi di prova, sia troppo breve.
A giudizio del Tribunale di Genova, il tempo che residua - tra la scadenza del termine previsto dalla legge per la costituzione del convenuto (almeno trenta giorni prima dell'udienza) e la scadenza del termine entro il quale l'attore deve depositare la sua memoria (almeno venti giorni prima dell'udienza) -, ovverosia dieci giorni, sarebbe insufficiente a garantire all'attore un'adeguata difesa rispetto alle domande riconvenzionali e alle eccezioni che può sollevare il convenuto. E questo andrebbe tanto più rilevato, considerando che talora le difese - come nel caso sottoposto al suo esame - potrebbero risultare di particolare complessità.
La norma censurata determinerebbe, pertanto, un'ingiustificata compressione del diritto di difesa, della parità delle armi e dei principi generali del giusto processo, recati dagli artt. 24 e 111 Cost.
Il giudice a quo ritiene, inoltre, violato il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista nel processo ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha sollevato tre eccezioni di inammissibilità.
2.1.- In primo luogo, la difesa statale ha sostenuto l'irrilevanza delle questioni, sul presupposto che non si possa proporre domanda riconvenzionale di divorzio nell'ambito di un giudizio instaurato per la modifica delle condizioni di separazione con riguardo al mantenimento della prole.
2.1.1.- L'eccezione non è fondata.
Il rimettente ha offerto argomenti testuali e teleologici, supportati anche da riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, a sostegno della possibile domanda riconvenzionale di divorzio, prospettata in risposta alla richiesta di modifica delle condizioni di separazione.
La motivazione addotta dal giudice a quo supera, dunque, il vaglio esterno di non implausibilità, sulla cui base questa Corte valuta la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 80, n. 50, n. 49 e n. 4 del 2024, n. 164 del 2023 e n. 193 del 2022).
2.2.- In secondo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'irrilevanza delle censure, in quanto, nel giudizio principale, la parte attrice avrebbe avuto a disposizione, in concreto, sedici giorni per apprestare le proprie difese in replica alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto, a fronte di censure del rimettente che si dolgono, viceversa, del termine di dieci giorni.
2.2.1.- Anche tale eccezione va disattesa.
La rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale presuppone che il giudice a quo debba semplicemente avvalersi della norma censurata, sicché ai fini dell'ammissibilità è sufficiente che egli abbia adeguatamente motivato a riguardo.
Nella vicenda odierna, il rimettente ha evidenziato come, proprio sulla base della disciplina censurata, si vedrebbe costretto a rigettare la pretesa dell'attore di assegnazione di un nuovo termine a difesa.
2.3.- Da ultimo, con la terza eccezione di rito, l'Avvocatura generale dello Stato ha contestato l'indeterminatezza e il carattere manipolativo dell'intervento richiesto a questa Corte, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.
Anche quest'ultima eccezione non è fondata.
Per quanto l'ordinanza di rimessione non esprima una preferenza tra i diversi modelli procedimentali che vengono posti a raffronto con quello delineato dalla norma censurata, va ricordato - come più volte rilevato dalla giurisprudenza costituzionale - che «"il petitum dell'ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente", ma non vincola questa Corte, che, "ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata"» (sentenze n. 53 del 2025 e n. 46 del 2024).
In altri termini, questa Corte, come può rinvenire d'ufficio la disciplina da adottare, ricercando nel «sistema nel suo complesso [...] "precisi punti di riferimento" e soluzioni "già esistenti" (sentenza n. 236 del 2016) [...] immuni da vizi di illegittimità, ancorché non "costituzionalmente obbligat[i]"» (sentenza n. 222 del 2018), tanto più può operare una cernita tra varie opzioni indicate dal rimettente, senza che la prospettazione di possibili modelli alternativi di regolazione della fattispecie sia sufficiente a frapporre ostacoli di rito all'esame delle questioni.
3.- Nel merito, le censure sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. non sono fondate.
4.- Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un'ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023).
Il legislatore può «differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (sentenza n. 39 del 2025) e non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. «sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti», purché rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità tali «da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (sentenza n. 76 del 2025).
4.1.- Nel solco tracciato dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, il legislatore ha previsto, per i rapporti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, stante la loro peculiarità, un rito speciale differenziato, che, in conformità al principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), è stato improntato a istanze di concentrazione e speditezza.
In tale prospettiva, il legislatore ha stabilito che il thema decidendum e il thema probandum debbano essere definiti prima dell'udienza di comparizione delle parti, così da consentire al giudice di adottare i provvedimenti indifferibili e dare avvio alla fase istruttoria, sulla base di una compiuta conoscenza dei fatti di causa e delle pretese delle parti.
4.2.- Nel quadro della richiamata disciplina, che prevede serrate scansioni temporali, si colloca l'ulteriore scelta, oggetto delle odierne questioni di legittimità costituzionale, di concedere all'attore un termine per replicare alle eccezioni del convenuto e alle sue eventuali domande riconvenzionali che, anche qualora il convenuto dovesse depositare la sua comparsa di costituzione l'ultimo giorno utile, non può risultare inferiore ai dieci giorni. Il presidente del tribunale, infatti, nel fissare l'udienza di prima comparizione delle parti, assegna il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza (art. 473-bis.14, secondo comma, cod. proc. civ.), mentre l'attore può depositare memoria, ai sensi della norma censurata, entro venti giorni prima della data dell'udienza (art. 473-bis.17, primo comma, cod. proc. civ.).
Il richiamato termine, pur se breve, in linea con gli obiettivi di politica del diritto perseguiti dal legislatore, improntati alla celere definizione dei giudizi, non eccede il margine della manifesta irragionevolezza, in quanto non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.
4.2.1.- Anzitutto, la parte attrice è ben in grado di prevedere il tipo di reazione che può scaturire dalla propria domanda e che può tradursi nella proposizione di una eccezione o di una domanda riconvenzionale.
Le difese del convenuto, infatti, devono presentare un collegamento oggettivo con la domanda principale e, nel contesto di un rito speciale, qual è quello in esame, sono per legge circoscritte ex ante dalla tipologia di rapporti cui esso si applica.
In particolare, nell'ambito dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, non è ipotizzabile una domanda riconvenzionale concernente una pretesa del tutto imprevedibile rispetto all'oggetto del processo.
Anche avendo riguardo al tipo di controversia trattata nel giudizio principale, deve rilevarsi che, a fronte di una domanda concernente la separazione fra coniugi, con la quale si chieda una modifica delle condizioni patrimoniali relative al mantenimento dei figli, non può ritenersi inaspettata una domanda riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto. Proprio la riforma introdotta con il d.lgs. n. 149 del 2022 ha espressamente disciplinato l'ipotesi del cumulo tra domanda di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha ravvisato un'ipotesi di connessione, sì da favorire la loro trattazione unitaria, previa riunione, anche ove siano proposte dinanzi a giudici diversi (art. 473-bis.49 cod. proc. civ.).
4.2.2.- A ciò si aggiunga che lo stesso legislatore del 2022 ha modulato l'ambito applicativo della norma censurata sulla base degli interessi coinvolti, prevedendo - all'art. 473-bis.19, primo comma, cod. proc. civ. - che le decadenze stabilite da varie disposizioni, compreso l'art. 473-bis.17, «operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili».
Inoltre, lo stesso art. 473-bis.19, al secondo comma, cod. proc. civ. prevede, espressamente, che le «parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori».
È stato, dunque, lo stesso legislatore ad aver avvertito l'esigenza, in questa peculiare materia, di una disciplina più elastica, che contribuisce a evidenziare il carattere non manifestamente irragionevole del punto di equilibrio individuato dalla norma censurata.
4.2.3.- In definitiva, la scelta adottata dal legislatore nel bilanciare le istanze di celerità con le esigenze di difesa, anche in relazione al tipo di interessi implicati, induce a escludere che il termine minimo di dieci giorni assegnato all'attore possa rendere l'esercizio del diritto di difesa impossibile o eccessivamente difficoltoso.
A ciò si aggiunga che, ove dovessero ricorrere situazioni eccezionali non imputabili alla parte, troverebbe applicazione la previsione generale, di cui all'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui «[l]a parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini». Quest'ultima norma chiude, dunque, il sistema e, nel raccordo con lo stesso art. 473-bis.17, primo comma, cod. proc. civ., allontana ulteriormente il timore di possibili violazioni del diritto di difesa.
4.3.- Venendo ora al profilo della censura che attiene alla parità delle armi, occorre precisare che, secondo questa Corte, il principio del contraddittorio consacrato dall'art. 111, secondo comma, Cost. «impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative» (sentenza n. 73 del 2022, nello stesso senso sentenza n. 39 del 2025).
Alla luce del richiamato principio, occorre rilevare, da un lato, che ambo le parti, nel rito in esame, possono far valere gli stessi strumenti di tutela e hanno i medesimi poteri istruttori e, da un altro lato, che il legislatore non ha ecceduto il limite della manifesta irragionevolezza, là dove ha differenziato il trattamento di attore e convenuto unicamente quanto alla durata del termine loro concesso per difendersi dalle domande ed eccezioni della rispettiva controparte.
In particolare, l'attore - come già sopra evidenziato - dispone di un termine minimo di dieci giorni per reagire alle difese del convenuto, mentre quest'ultimo ha un termine minimo di trenta giorni per approntare le proprie difese rispetto alla domanda dell'attore (come si evince dal coordinamento sistematico fra l'art. 473-bis.14, quinto comma, cod. proc. civ. e l'art. 473-bis.14, secondo comma, cod. proc. civ.).
Ebbene, il minor termine assegnato alla difesa dell'attore rispetto a quello concesso al convenuto non risulta manifestamente irragionevole, in quanto le due posizioni processuali sono significativamente diverse.
Mentre, infatti, il convenuto è tendenzialmente còlto di sorpresa dall'iniziativa di chi introduce il giudizio, l'attore, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, gode di ben altra capacità di previsione delle possibili reazioni della controparte, dalle quali sia chiamato a difendersi.
Dunque, i diversi termini concessi per reagire alle rispettive pretese dell'altra parte, nel contesto di un processo improntato a speditezza e concentrazione, non sono tali da porre l'attore in una situazione di asimmetria manifestamente squilibrata rispetto alle possibilità di difesa di cui dispone il convenuto.
4.4.- Per le ragioni esposte, la disciplina censurata non vìola il diritto di difesa, la parità delle armi e i principi del giusto processo, di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
5.- Parimenti non è fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento nel confronto con la disciplina concernente i termini di cui può avvalersi la difesa dell'attore nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro.
I presupposti di ciascuno dei riti messi a raffronto sono talmente peculiari da rendere disomogenei i tertia comparationis.
L'accostamento al processo ordinario di cognizione è privo di giustificazione, ove solo si consideri che fra le ragioni a sostegno di un autonomo rito unificato per lo stato delle persone, i minorenni e le famiglie si rinviene proprio l'esigenza di sottrarre tali delicate controversie, bisognose di una trattazione specializzata, al rito ordinario.
Parimenti debole è il confronto con il rito semplificato di cognizione. Questo, infatti, da un lato, è peculiare, quanto alle ragioni della trattazione concentrata, che si rinvengono nella semplicità delle questioni coinvolte e nella conseguente sommarietà dell'istruzione (art. 281-decies, cod. proc. civ.). E, da un altro lato, identifica un rito applicabile a qualsivoglia controversia civile, il che rende maggiormente imprevedibili - rispetto al giudizio in esame - le possibili difese del convenuto.
Infine, se una qualche similitudine è dato rinvenire, invece, con il rito del lavoro, si deve, tuttavia, rilevare che esso è strutturato in modo del tutto differente rispetto a quello in esame.
Il rito del lavoro, infatti, è ancora più contratto e spedito, in quanto tutto concentrato nell'udienza di discussione, nel corso della quale devono svolgersi le varie attività processuali. Per contro, il rito unificato della famiglia, pur esso celere e anticipato nella delimitazione del tema decisionale, nondimeno, è caratterizzato, nel prosieguo, da scansioni temporali più distese, nelle quali possono inserirsi momenti peculiari, quali l'ascolto del minore, la nomina di esperti specializzati, l'intervento dei servizi sociali, la partecipazione del pubblico ministero.
Nel complesso, dunque, difetta il presupposto stesso del vaglio attinente alla irragionevole disparità di trattamento, ovverosia l'omogeneità delle situazioni poste a confronto (ex multis, da ultimo, sentenze n. 53 e n. 34 del 2025, n. 212 e n. 171 del 2024), dovendosi, viceversa, constatare che la disciplina censurata riflette una precisa scelta del legislatore di «differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (così, da ultimo, sentenza n. 39 del 2025).
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.