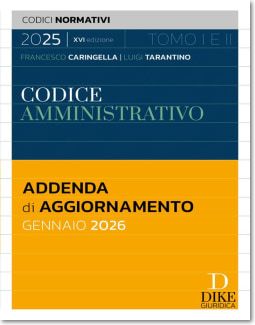Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 21 luglio 2025, n. 20387
Presidente: Giusti - Estensore: Iofrida
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 168/2024, pubblicata il 19 febbraio 2024, ha accolto il ricorso di RCS Mediagroup s.p.a. in opposizione avverso il provvedimento n. 54 del 23 febbraio 2023 adottato dal Garante nei suoi confronti.
Il procedimento era stato instaurato dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di un gestore di un motore di ricerca, relativamente ai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo di un soggetto, conclusosi con provvedimento n. 213 del 27 novembre 2019: si era rilevata la presenza, sul sito www.roma.corriere.it, edito dalla Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup s.p.a., di un articolo giornalistico del 16 febbraio 2015, al cui interno erano pubblicate fotografie ritraenti alcuni soggetti sottoposti a misura precautelare (arresto). All'esito di tale procedimento, il Garante aveva, prima, disposto, nei confronti del gestore del motore di ricerca, la limitazione provvisoria del trattamento, riferita all'ulteriore diffusione delle immagini, quale effetto della reperibilità in rete degli «URL» connessi agli articoli associati ai nominativi degli interessati, riservandosi, in ordine ai contenuti reperibili tramite detti «URL», di effettuare gli opportuni accertamenti al fine di verificare la legittimità dell'avvenuta diffusione, da parte dei titolari originari, delle immagini contestate e di valutare, sulla base del loro esito, la fondatezza della richiesta avanzata dall'interessato con il presente reclamo.
Quindi, era stato avviato un procedimento a carico di RCS Mediagroup per la diffusione delle immagini all'interno dell'articolo del Corriere del Sera del febbraio 2015, e, con provvedimento n. 54 del 23 febbraio 2023, era stato vietato a RCS l'ulteriore diffusione delle immagini di alcuni soggetti coinvolti in un procedimento penale, pubblicate a corredo di un articolo comparso sul Corriere della Sera del 16 febbraio 2015 dal titolo «Catturata a Roma la banda del buco. Nel gruppo una bancaria e un 80enne» Il provvedimento si fondava sull'assunto che la pubblicazione di tali immagini rappresentavano un trattamento illecito, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. a), del reg. U.E. 2016/679, del[l]'art. 137, comma 3, del codice della privacy, nonché degli artt. 6, 8 e 12 del codice deontologico dei giornalisti.
Il provvedimento era opposto da RCS che sosteneva l'illegittimità del provvedimento, sull'assunto che le immagini in questione, a differenza di quanto sostenuto dal Garante, non sarebbero state lesive della dignità degli effigiati, né sarebbero state assimilabili a quelle di natura segnaletica, essendo delle immagini di mero riconoscimento che, comunque, sarebbero state lecitamente pubblicate, nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, e quindi per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la diffusione delle immagini in oggetto non costituiva una violazione dell'art. 8 del citato codice deontologico sul trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (che, rubricato «Tutela della dignità delle persone», prescrive: «1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. 3. Le persone non possono essere presentate con ferri e manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi»), in quanto le fotografie degli indagati, riportate a corredo dell'articolo di cronaca giudiziaria pubblicato, «non sono assimilabili a quelle di natura segnaletica, ma rappresentano unicamente la parte frontale del volto degli indagati e sono prive di riferimenti identificativi numerici» e il logo della Polizia di Stato ne attestava solo la provenienza da fonti ufficiali; peraltro era presente anche il logo di Facebook e di Twitter con l'indicazione «Questura di Roma», il che mal si conciliava con l'ipotesi della foto segnaletica.
Non emergendo elementi da cui trarre che le fotografie fossero state scattate mentre gli indagati si trovavano in «stato di detenzione», non poteva ipotizzarsi la violazione dell'art. 8 del codice deontologico, né un conseguente illecito trattamento di dati personali. Le immagini in questione, che ritraevano il volto delle persone in maniera frontale e non li ritraevano in atteggiamenti umilianti o degradanti, non potevano ritenersi intrinsecamente lesive della dignità degli effigiati, poiché non vi sono elementi che portino a ritenere che la loro diffusione sia di per sé idonea a recare un pregiudizio alla loro immagine, al loro onore ovvero alla loro identità personale.
Neppure ricorreva una violazione dell'art. 5, lett. a), r.g.d.p., che enuncia il principio di liceità del trattamento e degli artt. 6, 12 del codice deontologico e dell'art. 137 del codice privacy, che rappresentano un complesso di disposizioni dedicate alla tutela dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto il trattamento effettuato dalla RCS, in termini di pubblicazione delle fotografie dei soggetti indagati a corredo dell'articolo di cronaca giudiziaria che vede loro protagonisti, era lecito perché, sebbene avvenuto in difetto del consenso degli effigiati, soddisfaceva la condizione di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche (art. 136, 137 del codice privacy). Invero, le immagini riportavano, a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria, l'effigie di due soggetti catturati per reati commessi dal 2012 al 2014 e appartenenti alla c.d. «banda del buco» (la quale, al fine di commettere i reati presso gli istituti di credito, realizzava delle aperture negli edifici residenziali limitrofi per consentire l'ingresso e aveva inoltre appiccato incendi dolosi, distrutto un ambulatorio veterinario, nonché commesso furti d'auto), nei confronti dei quali era stato aperto un procedimento penale per la realizzazione di gravi rapine, perpetrate a seguito di altri gravi delitti, cosicché sussisteva l'interesse alla identificazione degli indagati, considerata l'importanza dell'indagine in corso, che riguarda una serie di fatti gravi e radicati sul territorio, idonei a coinvolgere e interessare la società civile.
Si trattava quindi di trattamento per finalità di cronaca giudiziaria, avente ad oggetto la pubblicazione delle immagini in questione, strumentale all'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria ed essenziale per consentire l'identificazione dei soggetti indagati per gravi delitti e, pertanto, sorretto da idonea base giuridica e del tutto legittimo alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Avverso la suddetta pronuncia, il Garante per la protezione dei dati personali propone ricorso per cassazione, notificato il 19 settembre 2024, affidato a due motivi, nei confronti di RCS - Rizzoli Comunicazioni Corriere della Sera Media Group s.p.a. (che resiste con controricorso).
Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Garante ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del codice dei giornalisti, richiamato dall'art. 2-quater del codice della privacy, determinata dalla valutazione della legittimità della diffusione di immagini effigianti soggetti indagati, senza tener conto di quanto risultante dal contesto informativo in cui le immagini sono inserite, prescrittibilità del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 137 del codice della privacy, degli artt. 6 e 12 regole deontologiche, e dell'art. 5, par. 1, lett. a), del regolamento UE 2016/679, determinata dal riconoscimento della liceità della diffusione delle immagini in questione.
Si devono richiamare l'art. 137 del codice della privacy d.lgs. 196/2003 (norma che autorizza il trattamento dei dd.pp. nell'ambito dell'attività giornalistica anche senza il consenso dell'interessato) con specifico riferimento al d.m. attuativo d.d. 31.01.2019 «Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018» e segnatamente agli artt. 6, 8 e 12.
Art. 6. Essenzialità dell'informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 8. Tutela della dignità delle persone
1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 10 del Regolamento, nonché dall'art. 2-octies del Codice.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.
In effetti il capo I del titolo XIII del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy) attuativo del regolamento UE 2016/679 disciplina la particolare fattispecie del trattamento dei dati personali nel settore giornalistico, in considerazione dell'interferenza del diritto alla riservatezza con il parimenti fondamentale diritto alla manifestazione del pensiero e all'informazione che caratterizza l'esercizio della funzione giornalistica.
L'art. 137 del codice della privacy prescrive difatti che i dati contemplati agli artt. 9 e 10 del regolamento UE n. 679/16 possano essere trattati nell'ambito dell'attività giornalistica anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui al successivo art. 139, norma del testo unico che rinvia all'adozione di regole deontologiche utili all'esercizio dell'attività informativa di concerto tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG).
2. Le censure sono infondate.
L'intero tenore del regolamento 679/16 è improntato all'equo contemperamento fra diritti fondamentali di informazione e diritto alla privacy.
Nei considerando 4 e 153 del regolamento si legge:
«(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale»;
«(153) Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito nell'articolo 11 della Carta».
L'art. 85 recita:
«Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione».
Come osserva il P.G., già dalla lettura di tali disposizioni emerge «come il diritto all'informazione non venga configurato come recessivo rispetto alla tutela della privacy» e che «una società libera, pluralista fondata sui diritti fondamentali richiamati dal trattato di Lisbona tiene in assoluta considerazione la libertà di espressione e di informazione quali presidi fondamentali di un ordine democratico».
Ed è significativo che le regole deontologiche funzionali all'attuazione del diritto alla privacy siano adottate quindi non direttamente dal Garante (per mezzo di regolamento delegato) bensì dal Consiglio nazionale dei giornalisti di concerto con il GPDT, a riprova della circostanza per cui il perimetro della libertà di informazione è stabilito in primis dagli stessi organi di informazione.
Il potere sanzionatorio del Garante è quindi limitato (art. 139, comma 4, GDPR) alla stretta «violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche».
Trattandosi di regole potenzialmente limitative del diritto all'informazione, la loro interpretazione non è quindi suscettibile di estensione a fattispecie analoghe o in via analogica. Né il Garante, che ha dato l'assenso a tale regolamentazione, può invocare una interpretazione più ampia di quella strettamente riconducibile alla lettera del codice deontologico, il quale, essendo potenzialmente foriero anche di ipotesi di responsabilità disciplinare per i giornalisti o per i professionisti cui è indirizzato, non ammette che interpretazioni strettamente legate al tenore della disposizione.
Orbene, l'art. 8 del codice deontologico contiene il divieto di pubblicare fotografie di persone in stato di arresto oppure, nel contesto dell'informazione su fatti criminali, di foto con caratteristiche lesive della dignità della persona coinvolta.
La riproduzione dell'effigie di una persona oggetto di procedimento penale è quindi da considerarsi violativa di tali disposizioni se è manifesto lo stato di arresto (manette ai polsi dell'effigiato) ovvero se pone la persona dell'effigiato in una luce irrisoria o degradante (come nell'ipotesi di un soggetto parzialmente svestito, ferito all'esito della coazione da parte delle forze di polizia) e comunque in una luce che lo depriva della sua dignità individuale.
Non vi è dubbio che l'immagine effettuata in costanza di fotosegnalamento, poiché richiama immediatamente non solo l'arresto e quindi il momento dell'associazione in carcere ma anche i dati biometrici (si pensi alla foto di fronte, di profilo recante numero di matricola e i dati biometrici) sia quindi immediatamente riconducibile al divieto di cui al comma 8.2 del codice deontologico sopra riportato.
Ma, se non si tratta proprio della speciale foto del fotosegnalamento, di per sé, non può essere considerata denigratoria o lesiva della dignità la dicitura «Polizia», associata alla fotografia, poiché la valutazione sulla offensività della foto, contrariamente a quanto sostenuto dal GPDP, deve essere agganciata a dati sostanziali e valutata caso per caso.
Anche secondo la Corte CEDU, nel caso Toma vs Romania (app. CEDU n. 42716/02), la foto dell'arrestato non può essere divulgata se lo ritrae in vinculis, e quindi se lo stesso viene ritratto in condizione degradante (come nell'ipotesi in cui si percepiscano le ferite conseguenti all'arresto) e se la foto sia stata scattata contro l'espressa volontà dell'arrestato e non sulla semplice base della provenienza dagli organi di polizia. In tale fattispecie, la polizia aveva convocato i giornalisti e permesso loro di scattare fotografie, destinate alla pubblicazione, che mostravano il ricorrente in stato di fermo dopo che lui ed un'altra persona erano stati arrestati dagli agenti della squadra antidroga in possesso di 800 grammi di cannabis; il giorno dell'arresto, i giornalisti di un canale televisivo locale e di un quotidiano avevano filmato e fotografato il ricorrente alla stazione di polizia e, il giorno successivo, una fotografia del ricorrente che mostrava segni evidenti di violenza (lividi e graffi) era stata pubblicata sulla prima pagina del quotidiano, insieme a un articolo che lo definiva «trafficante di droga».
La Corte CEDU ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione, evidenziando come il comportamento della polizia, che aveva chiamato i giornalisti e permesso loro di filmare il ricorrente alla stazione di polizia, il giorno in cui era stato avviato il procedimento a suo carico, senza il suo consenso e con l'intenzione di pubblicare le immagini sui media, in condizioni degradanti, aveva costituito un'ingerenza indebita nel diritto del ricorrente al rispetto della vita privata.
Tanto premesso, l'interpretazione proposta dal ricorrente Garante, tesa alla proibizione della pubblicazione di ogni fotografia scattata dalla polizia o diffusa dagli organi di polizia, per una sorta di illegittimità «di contesto» per cui l'indicazione dell'organo di polizia suggerirebbe indirettamente (o direttamente) l'intervenuto arresto del soggetto e si porrebbe quindi in contrasto con il codice deontologico per relationem, risulta esulare dal perimetro del regolamento di cui all'art. 139 codice privacy per le ragioni sopra indicate, in quanto foriera di un'interpretazione analogica non consentita per quanto sopra ricordato.
Non si può ritenere sussistente un divieto assoluto e generale di pubblicazione delle immagini di persone con il logo «Polizia», occorrendo operare un bilanciamento, caso per caso, che contemperi il diritto alla riservatezza e a[l] rispetto della sfera privata della persona con il diritto generale di cronaca.
Una pubblicazione si deve ritenere illecita solo quando raffiguri il momento dell'arresto o raffiguri il soggetto «in ceppi» (ad es. con manette ai polsi) ovvero con i segni fisici dell'intervenuto arresto, incidendo negativamente sulla dignità della persona.
In assenza di tali elementi obiettivi, la dicitura che richiama gli organi di polizia giudiziaria e le circostanze dell'arresto non appare rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 8 e deve ritenersi lecita in quanto si limita a descrivere il contenuto della notizia descritta (l'avvenuto arresto di persone coinvolte nell'attività investigativa penale).
Essa rispecchia anzi proprio il requisito dell'essenzialità dell'informazione.
Si devono quindi affermare i seguenti principi di diritto:
a) «La ricerca della stabilità delle decisioni giurisprudenziali non si declina in regole generali e astratte, di applicazione automatica, in quanto la decisione del giudice è sempre statuizione nel caso concreto, agganciata a dati sostanziali in fatto e a valutazione da condursi caso per caso»;
b) «In materia di trattamento di dati personali, ai fini dell'art. 137 del codice della privacy d.lgs. 196/2003, norma che autorizza il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica anche senza il consenso dell'interessato, da vagliarsi con specifico riferimento al d.m. attuativo d.d. 31.01.2019, «Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018» e segnatamente agli artt. 6, 8 e 12, la pubblicazione, a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria di immagini di persone con il logo «Polizia» non può essere, di per sé, equiparata a un «fotosegnalamento», che si caratterizza invece per essere una foto di fronte, di profilo e recante numero di matricola e i dati biometrici»;
c) «Il trattamento di dati personali effettuato dall'editore, in termini di pubblicazione delle fotografie dei soggetti indagati a corredo dell'articolo di cronaca giudiziaria che vede loro protagonisti, è da ritenersi lecito, laddove, sebbene avvenuto in difetto del consenso degli effigiati, soddisfi la condizione di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche (art. 136, 137 del codice privacy) e non risulti lesiva della dignità personale».
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
In considerazione della novità e complessità delle questioni di diritto oggetto del ricorso, ricorrono giusti motivi per un'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
Malgrado il descritto esito della lite, non è possibile attestare, nei confronti del Garante per la protezione dei dati personali, la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte di detta Autorità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, atteso che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1778 del 2016, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti, tra le altre, Cass. n. 31629/2023, Cass. n. 11965/2022, Cass. n. 20682 del 2020, Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 14566 del 2021, Cass. n. 24971 del 2022, Cass. n. 29954 del 2023 e Cass. 1491/2025, quest'ultima resa proprio in giudizio che aveva visto soccombente il Garante p.d.p.), l'obbligo di versare l'ulteriore importo suddetto non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.