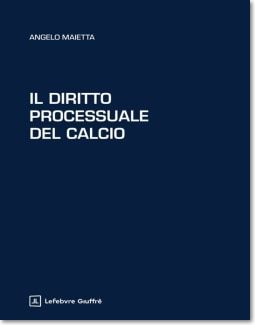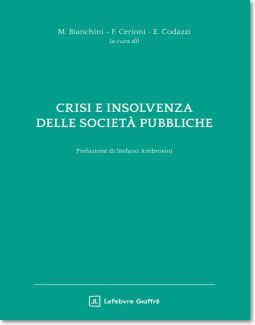Corte costituzionale
Sentenza 18 luglio 2025, n. 111
Presidente: Amoroso - Redattrice: San Giorgio
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra G. A. e R. spa con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2024, la cui trattazione è stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, 11 e 117 (recte: 117, primo comma) della Costituzione, questi ultimi due in relazione all'art. 27, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
1.1.- La Corte di cassazione riferisce di essere investita del ricorso promosso da G. A. avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva accertato la tardività della impugnazione proposta dalla stessa ricorrente avverso il licenziamento disciplinare intimatole dalla M. F. M. spa (ora: R. spa) per assenza ingiustificata dal lavoro dal 1° al 18 agosto 2015.
La Corte d'appello - espone il giudice a quo - aveva premesso che la società datrice di lavoro aveva contestato l'illecito disciplinare alla dipendente, invitandola a fornire giustificazioni, mediante raccomandata da lei ricevuta il 21 agosto 2015; che la stessa società, non avendo ottenuto risposta entro il termine concesso, aveva irrogato alla lavoratrice la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi degli artt. 46 e 48 del «CCNL di settore», con missiva dalla stessa ricevuta, previa sottoscrizione dell'avviso di ricevimento dell'atto, il 10 settembre 2015; che il licenziamento non era stato impugnato nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 e che solo con lettera del 19 maggio 2016 la lavoratrice aveva contattato la società datrice di lavoro al fine di giustificare la propria assenza dal servizio; che la stessa dipendente aveva poi impugnato il licenziamento con ricorso notificato il 9 dicembre 2016, sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacità naturale che le avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell'atto.
La Corte rimettente aggiunge che il giudice di secondo grado, condividendo la decisione di prime cure, aveva ritenuto che il termine di decadenza fosse spirato, non essendo lo stesso suscettibile di sospensione.
La Corte d'appello aveva fatto applicazione del principio espresso dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 9 marzo 2007, n. 5545, secondo la quale la validità o l'efficacia degli atti recettizi prescinde dall'eventuale stato di incapacità naturale del soggetto al quale sono indirizzati, posto che la disciplina di tali atti è espressione del principio dell'affidamento e il legislatore, da un lato, ha previsto l'annullabilità ex art. 428 del codice civile dei soli atti unilaterali posti in essere dall'incapace naturale e, dall'altro, all'art. 1335 cod. civ., ha dettato una regola volta a garantire la certezza giuridica della conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario, a prescindere dalla capacità di quest'ultimo di apprezzarne il valore e di determinarsi di conseguenza.
1.2.- Le Sezioni unite espongono, quindi, che, con il primo motivo di ricorso, è stata denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. in relazione alla decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966.
A sostegno di tale censura - prosegue l'ordinanza di rimessione - la ricorrente ha dedotto che, dall'estate del 2015 al mese di maggio 2016, era stata affetta da grave crisi depressiva con dissociazione dalla realtà e aveva riacquistato la pienezza delle facoltà cognitive e volitive soltanto dopo essere stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio, disposto su segnalazione del centro di salute mentale di un ospedale; che aveva dimostrato il suo stato di assoluta incapacità di intendere e di volere producendo gli atti del giudizio avente a oggetto l'affidamento del proprio figlio minore e, in particolare, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio ivi espletata; che l'esito di tale accertamento era stato confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio designato nella prima fase del giudizio di impugnazione del licenziamento, il quale aveva concluso che, nel periodo sopra indicato, il disturbo psicotico breve con stato paranoide aveva impedito alla ricorrente la formazione di una volontà cosciente.
La stessa ricorrente ha, quindi, argomentato che, poiché l'art. 1335 cod. civ. introduce una presunzione relativa, superabile dal destinatario che provi di non avere avuto notizia dell'atto senza sua colpa, non può essere ritenuta irrilevante, ai fini del suo superamento, l'incapacità naturale del destinatario determinata da problemi psichici.
Ha, inoltre, sostenuto che la tutela dell'affidamento che ispira la disposizione suddetta non può giungere sino a sacrificare integralmente altri diritti fondamentali come il diritto alla salute, il diritto di difesa e il diritto al lavoro.
1.2.1.- La Corte di cassazione aggiunge che, con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nella mancata valutazione della consulenza tecnica d'ufficio medico legale, lamentando, in particolare, che le conclusioni rassegnate dall'ausiliare del giudice avrebbero dovuto condurre a escludere l'applicabilità del principio enunciato dalla Corte di cassazione nella ricordata sentenza n. 5545 del 2007, giacché nel giudizio dalla stessa definito la lavoratrice non aveva dimostrato di essere stata senza sua colpa impossibilitata a conoscere il contenuto della lettera di licenziamento.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, i giudici del merito, ritenendo maturata la decadenza dalla impugnazione, non si sarebbero espressi sulla legittimità della sanzione espulsiva, la quale, però, avrebbe dovuto essere esclusa, posto che il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicabile nel caso di specie, pur prevedendo che l'assenza debba essere giustificata dal lavoratore «entro i due giorni successivi», fa salvi i casi di comprovato impedimento, tra i quali si inscrive anche l'incapacità naturale.
1.3.- Tanto premesso, il giudice a quo espone che, con ordinanza interlocutoria del 27 settembre 2023, n. 27483, la sezione lavoro della Corte di cassazione, originariamente investita del ricorso, ha chiesto l'intervento nomofilattico delle Sezioni unite per chiarire «se uno stato di incapacità naturale, processualmente dimostrato e non contestato, sussistente nel momento in cui l'atto sia giunto all'indirizzo, rilevi ai fini del superamento, da parte del destinatario, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cc in quanto incidente sulla possibilità di averne notizia, senza sua colpa».
1.4.- Ciò posto, le Sezioni unite rimettenti ritengono rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento ai richiamati parametri costituzionali, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, come riformulato dall'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui, nel prevedere che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero di quella dei relativi motivi, se non contestuale, «fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell'atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità».
1.5.- In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che la Corte territoriale, richiamando l'orientamento consolidato formatosi nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 25 ottobre 1982, n. 5563, ha escluso «in radice» che, ai fini del decorso del termine di decadenza, assuma rilevanza l'incapacità naturale dedotta dalla lavoratrice e, pertanto, non ha esaminato le prove dalla stessa dedotte per dimostrarne l'effettiva sussistenza.
Rileva, quindi, che, poiché la sentenza impugnata è fondata in via esclusiva sull'intervenuta maturazione del termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, che lo stesso giudice del merito ha fatto decorrere dalla data di ricezione della lettera di licenziamento, e il ricorso per cassazione censura l'esito al quale è pervenuta la Corte territoriale, sussiste «l'effettivo e concreto rapporto di strumentalità» fra la soluzione delle questioni di legittimità costituzionale proposte e la definizione del giudizio principale.
1.6.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione ricostruisce, anzitutto, il quadro normativo in cui si colloca la disposizione censurata, ricordando come l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità assuma che il termine per l'impugnazione del licenziamento abbia natura decadenziale e, in quanto tale, sia insuscettibile, a norma dell'art. 2964 cod. civ., sia di interruzione sia di sospensione, e interpreti l'art. 1335 cod. civ. in adesione alla teoria della ricezione, secondo cui rileva non la conoscenza in senso proprio, ma la conoscibilità dell'atto, ricavabile da una circostanza oggettivamente verificabile, quale è la consegna di esso al domicilio del destinatario.
La disposizione codicistica, osserva la Corte rimettente, stabilisce, infatti, una equivalenza giuridica tra la conoscenza e la conoscibilità e introduce una presunzione iuris tantum in base alla quale quest'ultima deriva dalla consegna dell'atto al domicilio del destinatario.
Ciò sarebbe confermato dall'oggetto della prova contraria, individuato dall'art. 1335 cod. civ. nella «impossibilità di averne notizia» e non nella conoscenza effettiva del contenuto dell'atto.
La prova idonea a vincere la presunzione deve, quindi, riguardare circostanze che attengano non alle condizioni soggettive del ricevente, ma a fattori esterni e oggettivi che, concernendo il collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei a escludere la conoscibilità dell'atto.
Il giudice a quo evidenzia come la ratio della suindicata previsione, da individuarsi nell'esigenza di protezione della certezza dei rapporti giuridici, esprima un bilanciamento di interessi riferibile «all'intero complesso delle relazioni obbligatorie e contrattuali», così che non sarebbe praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata che, forzandone la lettera, prenda in considerazione soltanto gli atti recettizi «dalla cui conoscenza decorre il termine per il compimento di un'attività» e gli interessi, pur costituzionalmente rilevanti, che vengono in rilievo nel rapporto di lavoro, ma non in altre relazioni giuridiche che sono disciplinate dall'art. 1335 cod. civ.
Esclude, quindi, che, in materia di impugnazione del licenziamento, all'incapacità naturale del destinatario possa attribuirsi rilevanza attraverso una rilettura dello stesso art. 1335 cod. civ., osservando, altresì, come la tutela dell'incapace non possa essere assicurata neppure applicando l'art. 428 cod. civ., in quanto l'azione di annullamento ivi prevista si riferisce all'atto unilaterale e al contratto e non anche ai comportamenti omissivi, ossia all'ipotesi in cui l'incapace non agisca a tutela dei propri diritti.
Neanche rispetto a quest'ultima disposizione sarebbe, pertanto, sperimentabile l'interpretazione costituzionalmente orientata.
1.7.- Le Sezioni unite ritengono, pertanto, che la valutazione debba essere circoscritta alla disciplina recata dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966.
Neppure tale disposizione si presterebbe, tuttavia, a una interpretazione conforme a Costituzione, attesa l'insuperabilità del suo tenore letterale, che univocamente fa decorrere il termine per l'impugnazione dalla ricezione della comunicazione del licenziamento e quindi dalla conoscenza legale di cui all'art. 1335 cod. civ.
Il Collegio rimettente ricorda che, nell'interpretare, ad altri fini, la previsione in scrutinio, le stesse Sezioni unite hanno evidenziato che la finalità di certezza giuridica non è estranea al rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'imposizione di un breve termine di decadenza entro cui l'impugnazione del licenziamento deve essere proposta esprime l'esigenza di contemperare il diritto del lavoratore all'eliminazione delle conseguenze dell'illegittimo recesso datoriale con l'interesse del datore di lavoro alla continuità e stabilità della gestione dell'impresa, esigenza cui il legislatore fa fronte condizionando la tutela del prestatore alla sua tempestiva attivazione, in mancanza della quale il suo diritto alla legittimità degli atti datoriali recede a fronte dell'interesse alla stabilizzazione degli effetti del licenziamento (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 14 aprile 2010, n. 8830).
Il giudice a quo rammenta, però, come la pronuncia ora richiamata abbia anche precisato che tale conseguenza non deriva dal consolidarsi degli effetti del licenziamento illegittimo a tutela dell'affidamento, ma dall'esito negativo del vaglio di concreta meritevolezza dell'interesse del lavoratore che non abbia tempestivamente dato impulso agli strumenti che l'ordinamento gli riconosce.
Rimarca, ancora, la particolare natura degli interessi coinvolti dall'impugnazione del licenziamento, i quali trascendono quelli di cui sono portatori i contraenti «nella normalità del diritto dei contratti», perché il recesso dal contratto di lavoro incide su diritti fondamentali della persona (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 194 del 2018) e, di conseguenza, l'esercizio arbitrario del potere di licenziamento lede l'interesse del lavoratore alla continuità del vincolo (viene citata la sentenza di questa Corte n. 59 del 2021).
Richiama, altresì, la giurisprudenza costituzionale secondo cui, sebbene il legislatore goda di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e il controllo di legittimità costituzionale debba limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, al Giudice delle leggi compete comunque la verifica «che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale» (sentenza n. 212 del 2020).
1.8.- Tutto ciò premesso, le Sezioni unite dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, «nella parte in cui, facendo decorrere in ogni caso il termine di decadenza dalla data di ricezione della comunicazione del licenziamento, preclude l'azione al lavoratore licenziato che, in ragione dell'incolpevole stato di incapacità di intendere e di volere derivato da patologia fisica o psichica, non si sia attivato nel termine di legge e l'abbia fatto, una volta recuperata la piena capacità, tempestivamente rispetto a detto successivo momento temporale».
1.8.1.- In tale ipotesi, osserva l'ordinanza di rimessione, «l'operatività del termine di decadenza finisce per valorizzare unicamente l'interesse della parte datoriale al consolidamento degli effetti dell'atto adottato e per comprimere oltre misura il diritto di azione del lavoratore, riferito al diritto al lavoro, che la Carta costituzionale espressamente tutela agli artt. 24, comma 1, 4, comma 1, e 35, comma 1».
1.8.2.- Secondo il giudice a quo, la scelta del legislatore di non considerare meritevole di tutela il lavoratore licenziato che non si attivi tempestivamente, anche nel caso in cui la mancata impugnazione del recesso dipenda dalla sua «assoluta incolpevole incapacità di comprendere e di autodeterminarsi», sarebbe affetta da irragionevolezza, in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto non opererebbe alcun bilanciamento tra gli interessi in conflitto.
1.8.3.- L'art. 3 Cost. risulterebbe leso anche in riferimento al principio di eguaglianza, non potendo la situazione della persona incapace essere equiparata a quella del soggetto «che tale non è».
1.8.4.- Ancora, l'omessa considerazione, ai fini della individuazione del dies a quo del termine di decadenza, dello «stato di incapacità naturale derivante da malattia», confliggerebbe con l'art. 32, primo comma, Cost.
1.8.5.- Sarebbero, infine, violati gli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in quanto, nei casi in cui la menomazione, pur non essendo permanente, sia duratura (nei termini precisati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione terza, sentenza 1° dicembre 2016, causa C-395/15, Mohamed Daouidi), la disciplina censurata si risolverebbe in una discriminazione in danno della persona disabile, in violazione degli obblighi, imposti dall'art. 27, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e dalla direttiva 2000/78/CE, di assicurare allo stesso disabile l'esercizio dei suoi diritti e di adottare misure adeguate per rimediare «agli svantaggi provocati dalla applicazione di una disposizione che, seppure apparentemente neutra, determina una disparità con gli altri lavoratori».
1.9.- Da ultimo, la Corte di cassazione osserva che l'auspicato intervento additivo non risulterebbe incoerente con la disciplina generale della decadenza sancita dall'art. 2964 cod. civ., in quanto tale disposizione, pur escludendo l'operatività delle cause di sospensione della prescrizione, «fa salve [le] disposizioni speciali, disposizioni che il legislatore, in effetti, ha dettato con riferimento a singole azioni (artt. 245, 489 cod. civ.), in considerazione della particolare natura del diritto al quale il termine di decadenza si riferisce». Si tratta, prosegue l'ordinanza di rimessione, di casi in cui il legislatore ha ritenuto di dovere attribuire rilevanza allo stato di incapacità legale del titolare del diritto ed è significativo che questa Corte, nella sentenza n. 3229 (recte: n. 322) del 2011, «abbia equiparato all'incapacità legale quella naturale derivante da grave infermità di mente, finché la stessa perduri». Tali ragioni «possono essere ritenute ricorrenti anche in relazione all'impugnazione del licenziamento, ossia ad un atto che coinvolge direttamente la persona del lavoratore e pone in discussione interessi che trascendono quelli meramente economici rilevanti nei rapporti contrattuali di durata».
Il giudice a quo esclude che la pronuncia additiva richiesta possa minare la certezza dei rapporti giuridici, in quanto la diversa decorrenza del termine di impugnazione «richiederà che nel processo la parte, oltre a dimostrare lo stato di assoluta incapacità di intendere e di volere sussistente al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento, fornisca anche la prova della data in cui lo stesso è cessato».
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi inammissibili o comunque non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.
2.1.- L'interveniente rileva anzitutto che dall'ordinanza di rimessione risulta che, con lettera del 19 maggio 2016, la ricorrente nel giudizio a quo ha contattato la società datrice di lavoro al fine di giustificare la protratta assenza dal servizio.
Secondo la difesa statale, ciò dimostrerebbe che, alla data suddetta, la lavoratrice avesse piena consapevolezza della sanzione espulsiva irrogatale e che, quindi, la missiva dalla stessa inviata al datore di lavoro valesse quale impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
Pertanto, assumendo tale data quale dies a quo della decorrenza del termine per l'impugnazione del licenziamento, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 18 luglio 2016.
Osserva al riguardo l'Avvocatura generale dello Stato che nell'ordinanza di rimessione non si indica il giorno del deposito del ricorso, ma soltanto quello della sua notificazione (ossia il 9 dicembre 2016).
Il giudice a quo, non dando conto di aver verificato se la ricorrente, una volta recuperata la piena capacità, si sia tempestivamente attivata, rispetto a detto successivo momento temporale, per consolidare l'impugnazione stragiudiziale ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, avrebbe fornito una inadeguata motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate.
2.1.1.- In subordine, l'interveniente osserva che se, invece, si ritenesse che il giudice a quo abbia fatto riferimento alla sola notifica del ricorso, non avendo inteso attribuire alla missiva del 19 maggio 2016 la valenza di una impugnazione stragiudiziale, la questione dovrebbe ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza. La ricorrente, infatti, avendo recuperato la piena capacità almeno dal 19 maggio 2016, avrebbe dovuto manifestare la volontà di impugnare l'atto espulsivo entro il 18 luglio 2016 e, tuttavia, ha notificato il ricorso soltanto il 9 dicembre 2016.
2.2.- Nel merito, la difesa statale, dopo aver ricordato la giurisprudenza costituzionale che riconosce al legislatore ampia discrezionalità nella configurazione degli istituti processuali, ha sottolineato come la disposizione censurata richiami il principio di conoscenza legale degli atti recettizi fissato in via generale dall'art. 1335 cod. civ.
Ad avviso dell'interveniente, tale disposizione, nel bilanciare i contrapposti principi della certezza dei rapporti giuridici e del diritto alla salute e al lavoro, ha utilizzato un criterio di proporzionalità che la rende immune da irragionevolezza manifesta.
3.- È, infine, pervenuta, in data 26 novembre 2024, l'opinione scritta, quale amicus curiae, ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dell'Associazione Comma2 - Lavoro è dignità - ammessa con decreto presidenziale del 7 aprile 2025 - contenente argomentazioni adesive alle censure del giudice a quo.
L'associazione ha rilevato come la Corte rimettente abbia correttamente limitato la questione di legittimità costituzionale all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 senza estenderla all'art. 1335 cod. civ., il quale, nella interpretazione fornitane dal diritto vivente, esclude ogni considerazione delle condizioni soggettive del destinatario, attribuendo rilevanza alla sola conoscenza legale dell'atto - e non all'evento psichico della sua effettiva conoscenza -, in quanto è posto a presidio della certezza dei rapporti giuridici.
L'amicus curiae ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle questioni sollevate, ove non si ritenga praticabile una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 428 cod. civ., in base alla quale la tutela ivi prevista sia estesa anche alla condotta omissiva del lavoratore coincidente con la mancata tempestiva impugnazione del licenziamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- La Corte di cassazione, sezioni unite civili, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui, nel prevedere che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta - ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale -, «fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell'atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità».
1.1.- Il giudice a quo ritiene, anzitutto, violati gli artt. 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., poiché la disposizione censurata, nella ipotesi prospettata, valorizzerebbe esclusivamente l'interesse del datore di lavoro al consolidamento degli effetti del licenziamento, comprimendo «oltre misura» il diritto di azione del lavoratore, correlato al diritto al lavoro, che la Costituzione espressamente tutela.
1.2.- Sarebbe, inoltre, leso l'art. 3 Cost., per un duplice profilo.
1.2.1.- Da un lato, il mancato riconoscimento di tutela a favore del lavoratore licenziato che non si attivi tempestivamente, neppure a fronte di un atto che coinvolge fortemente la qualità della vita propria e della propria famiglia, si rivelerebbe irragionevole, non operando alcun bilanciamento tra gli interessi in conflitto, quando riguardi il dipendente che abbia omesso di impugnare il licenziamento a causa di una totale, e incolpevole, incapacità di autodeterminarsi.
1.2.2.- Dall'altro lato, l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche in riferimento al principio di eguaglianza, in quanto la situazione della persona incapace di intendere e di volere verrebbe equiparata a quella del soggetto che tale non è.
1.3.- La Corte rimettente ritiene che la disposizione censurata leda, altresì, l'art. 32, primo comma, Cost., in quanto «[l]'omessa considerazione dello stato di incapacità naturale derivante da malattia ai fini della individuazione del dies a quo del termine di decadenza» per l'impugnazione del licenziamento si porrebbe «in contrasto con la tutela della salute [costituzionalmente] garantita».
1.4.- Sarebbero, infine, violati, nei casi in cui la menomazione, seppure non permanente, sia duratura, gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 27, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e alla direttiva 2000/78/CE, «che impongono, fra l'altro, di assicurare al disabile l'esercizio dei propri diritti (art. 27, lett. c, della Convenzione) e di adottare misure adeguate per ovviare agli svantaggi provocati dalla applicazione di una disposizione che, seppure apparentemente neutra, determina una disparità con gli altri lavoratori».
Nelle ipotesi considerate, la previsione censurata realizzerebbe, infatti, una discriminazione in danno della persona disabile, in contrasto con i richiamati obblighi imposti dalle suddette fonti sovranazionali.
2.- In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1.- La difesa statale denuncia, anzitutto, la carenza di motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate.
2.1.1.- L'eccezione non è fondata.
Dall'ordinanza di rimessione si ricava che nel giudizio principale la ricorrente ha censurato la pronuncia di merito che aveva dichiarato la tardività della sua impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in quanto comunicata oltre il termine previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966.
Rispetto a questo thema decidendum la Corte rimettente ha fornito tutti gli elementi descrittivi necessari al vaglio della rilevanza.
L'ulteriore decadenza prospettata dall'interveniente - derivante dalla asserita tardività dell'impugnazione giudiziale rispetto alla, pur intempestiva, contestazione stragiudiziale - non risulta, infatti, in discussione tra le parti del giudizio principale, né potrebbe essere rilevata d'ufficio dal giudice (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 settembre 2011, n. 19405).
2.1.2.- Per le medesime ragioni deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dall'interveniente in via subordinata.
La difesa statale deduce che la ricorrente nel giudizio principale, avendo recuperato la piena capacità di intendere e di volere almeno a far data dal 19 maggio 2016, avrebbe dovuto manifestare la volontà di impugnare l'atto espulsivo entro il 18 luglio 2016, mentre ha notificato il ricorso soltanto il 9 dicembre 2016: donde il difetto di rilevanza della questione.
Anche questa eccezione, vertendo su un segmento della impugnazione del licenziamento diverso da quello che, alla stregua dell'ordinanza di rimessione, risulta controverso nel giudizio a quo, è destituita di fondamento.
2.2.- Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono, pertanto, rilevanti.
La Corte rimettente è chiamata a fare applicazione della disposizione censurata e tanto è sufficiente per ritenere sussistente la rilevanza, la quale deve essere valutata «in ingresso del giudizio incidentale a prescindere dalla maggiore o minore ricaduta che l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale, in ipotesi anche solo parziale rispetto al petitum del giudice rimettente, possa avere nel giudizio principale (sentenza n. 41 del 2021)» (sentenza n. 167 del 2022).
3.- All'esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale è opportuno premettere la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disposizione censurata.
3.1.- L'art. 6 della legge n. 604 del 1966, disponendo, al primo comma, che «[i]l licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso», onera il lavoratore che intenda contestare l'atto datoriale di una previa impugnativa da esperirsi, anche in via stragiudiziale, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto espulsivo.
La stessa disposizione, al secondo comma, introduce un ulteriore onere di avvio del procedimento giurisdizionale entro un termine, anch'esso di decadenza, la cui inosservanza è sanzionata con l'inefficacia sopravvenuta della precedente impugnativa.
In particolare, è previsto che «[l]'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
3.2.- La disposizione censurata, nella formulazione originaria, contemplava il solo onere di impugnazione del licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla ricezione della sua comunicazione ovvero da quella dei relativi motivi, ove non contestuale a quella dell'atto di recesso.
I lavori parlamentari confermano che l'introduzione di un termine breve di decadenza per l'impugnazione dell'atto datoriale mirava a evitare l'insorgere di controversie a distanza di tempo, ciò che avrebbe reso certamente meno agevole l'accertamento dei fatti che ad esse avevano dato luogo.
Alla stregua di tale disciplina, il lavoratore, una volta che avesse scongiurato il maturare della decadenza attraverso l'impugnazione stragiudiziale, avrebbe potuto esperire l'azione di annullamento del licenziamento nel termine quinquennale di cui all'art. 1442 cod. civ., decorrente dal giorno di ricezione dell'atto di intimazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1° dicembre 2010, n. 24366) ovvero agire per la dichiarazione di nullità senza alcun limite temporale.
3.3.- L'art. 6 della legge n. 604 del 1966 è stato significativamente riformato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010, il quale - per ciò che rileva ai fini dell'esame delle odierne questioni di legittimità costituzionale -, al comma 1, ha introdotto, accanto all'onere di previa impugnazione stragiudiziale, l'ulteriore onere di tempestivo avvio del giudizio, da assolvere entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, termine poi ridotto a centottanta dall'art. 1, comma 38 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).
Il citato art. 32 della legge n. 183 del 2010 ha poi esteso tale disciplina della decadenza anche ad altre ipotesi.
3.4.- Infine, questa Corte, con la sentenza n. 212 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 «nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile».
3.5.- Il superamento del termine di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale, ovvero dei termini ulteriori per il deposito del ricorso, anche cautelare se anteriore alla causa, o per attivare le procedure di conciliazione o di arbitrato, rispettivamente indicati nel primo e nel secondo comma della disposizione in scrutinio, dà luogo a decadenza (ex aliis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 4 novembre 2024, n. 28266 e 17 luglio 2024, n. 19740), per effetto della quale al lavoratore è precluso anche l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 aprile 2021, n. 9827).
3.6.- Questa Corte ha individuato il fondamento della imposizione del doppio termine decadenziale nell'esigenza di deflazionare il contenzioso e di garantire, nell'interesse della parte datoriale, la certezza dei costi delle vertenze quiescenti.
Si è, in particolare, osservato che la finalità della riforma del 2010 è «quella di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo» (sentenza n. 155 del 2014) e che il legislatore ha perseguito «l'intento di evitare che un possibile contenzioso, attivabile dal lavoratore, possa rimanere latente per tutto il tempo di prescrizione dell'azione di annullamento ovvero per un tempo lungo e indefinito in caso di azione di nullità» (sentenza n. 212 del 2020).
3.7.- Il primo dei termini contemplati dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 decorre dalla comunicazione al prestatore di lavoro del licenziamento in forma scritta e, precisamente, dal momento in cui, in base a quanto disposto dall'art. 1334 cod. civ., l'atto datoriale produce effetto.
Dal carattere recettizio del licenziamento (ex multis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 marzo 2017, n. 8136) deriva, infatti, che, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ. - a mente del quale «[l]a proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia» - esso si presume conoscibile nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del lavoratore e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza (Cass., n. 5545 del 2007).
3.7.1.- La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che la validità e l'efficacia degli atti che, come il licenziamento, hanno natura recettizia prescinde dall'eventuale stato di incapacità naturale del soggetto cui sono diretti. Il legislatore ha, infatti, predisposto regole, come l'art. 1335 cod. civ., che consentono di stabilire la certezza giuridica della loro conoscibilità da parte dei destinatari, indipendentemente dalla capacità degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 giugno 1985 n. 3612 e Cass., n. 5563 del 1982).
Si è, ancora, precisato che il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, deve essere proposta l'impugnazione, anche in via stragiudiziale, del licenziamento, avendo natura decadenziale, è insuscettibile, a norma dell'art. 2964 cod. civ., sia di interruzione sia, in mancanza di disposizione contraria, di sospensione. Esso «produce il suo effetto preclusivo in conseguenza della inerzia del titolare del diritto, senza che le condizioni soggettive del titolare e, in particolare, la sua capacità di intendere e di volere, rilevino in alcun modo e possano costituire cause di interruzione o di sospensione» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 marzo 1987, n. 2197).
3.8.- Le pronunce appena ricordate concordano con gli esiti interpretativi cui la stessa giurisprudenza di legittimità è giunta in relazione alla disciplina generale delle dichiarazioni recettizie.
Secondo un consolidato indirizzo, infatti, la regola dettata dall'art. 1335 cod. civ., alla stregua della quale ogni dichiarazione diretta a una persona determinata si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, opera per tale solo fatto oggettivo. Grava, pertanto, sul destinatario l'onere di superare tale presunzione provando di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di acquisire la conoscenza della dichiarazione, a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 19 agosto 2016, n. 17204; sezione terza civile, sentenze 22 ottobre 2013, n. 23920, 8 agosto 2007, n. 17417 e 4 giugno 2002, n. 8073; sezione lavoro, sentenza 11 aprile 1990, n. 3061).
3.9.- La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, escluso che, nel caso in cui il destinatario dell'atto recettizio versi in condizioni di incapacità naturale, trovi applicazione l'art. 428, primo comma, cod. civ., a mente del quale «[g]li atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore».
Si è, infatti, argomentato che tale previsione riferisce l'annullabilità agli atti «compiuti» dalla persona incapace e per questa pregiudizievoli, così che deve escludersi che il rimedio in questione sia esperibile nel caso in cui il pregiudizio derivi dal mancato compimento di un atto, pur dipendente dall'incapacità (Cass., n. 3612 del 1985).
3.10.- Nella cornice giurisprudenziale sin qui ricomposta si colloca l'ordinanza di rimessione all'odierno esame.
4.- Prima di esaminare il merito delle questioni sollevate occorre delimitare esattamente il thema decidendum.
4.1.- La questione di massima di particolare importanza della quale sono state investite le Sezioni unite rimettenti concerne la rilevanza, ai fini del superamento della presunzione di conoscibilità stabilita dall'art. 1335 cod. civ., dello stato di incapacità naturale, processualmente accertato e non contestato, in cui versi il destinatario della dichiarazione recettizia nel momento in cui l'atto giunge al suo indirizzo.
La Corte rimettente esclude, tuttavia, che la tutela del lavoratore colpito da incapacità naturale possa essere assicurata attraverso una rimeditazione dell'interpretazione nomofilattica degli artt. 1335, 2964 e 428 cod. civ., in quanto tali disposizioni oppongono una assoluta resistenza a una revisione ermeneutica che scongiuri i vulnera costituzionali prospettati dall'ordinanza interlocutoria.
In aggiunta, osserva che la disciplina generale degli atti recettizi è posta a presidio della certezza dei rapporti giuridici ed esprime un preciso bilanciamento di interessi operato dal legislatore in relazione «all'intero complesso delle relazioni obbligatorie e contrattuali», mentre l'azione di annullamento ex art. 428 cod. civ. non si presta a essere estesa ai comportamenti omissivi.
Assume, quindi, che al segnalato vuoto di tutela debba porsi rimedio intervenendo sulla sola disciplina dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento e, segnatamente, sull'esordio del termine di decadenza al quale è sottoposta.
La Corte rimettente, in particolare, circoscrive il petitum alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui àncora il dies a quo del termine per l'impugnazione del licenziamento al fatto obiettivo della ricezione della relativa comunicazione, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore non sia in grado di comprenderne la portata e di autodeterminarsi consapevolmente in merito all'utilizzo degli strumenti predisposti dall'ordinamento per farne valere l'illegittimità.
4.1.1.- Va anche evidenziato che, nonostante il giudice a quo censuri l'art. 6 della legge n. 604 del 1966 senza ulteriori precisazioni, il contenuto precettivo effettivamente investito dai dubbi di illegittimità costituzionale è solo quello del primo comma, come è reso evidente dalla riproduzione del suo contenuto nel petitum dell'ordinanza di rimessione e, comunque, dal tenore complessivo delle argomentazioni svolte.
È, quindi, soltanto in relazione a tale comma che va condotto lo scrutinio di costituzionalità.
4.1.2.- Deve, infine, rilevarsi che la mancata indicazione nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione dell'art. 24, primo comma, Cost. - la cui violazione risulta, invece, dedotta e argomentata nella parte motiva - non pregiudica la corretta individuazione della censura fondata su tale parametro (ex aliis, sentenza n. 164 del 2023).
5.- Tutto ciò premesso, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost. sono fondate.
5.1.- La disciplina relativa alla impugnazione del licenziamento sopra richiamata, sottoponendo l'azione volta a far valere l'illegittimità di tale provvedimento a un duplice termine decadenziale, da un lato, deroga al precetto sancito dall'art. 2967 cod. civ., secondo cui, una volta che la decadenza sia stata impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione, e, dall'altro, costituisce lex specialis rispetto al regime generale delle impugnative negoziali e delle correlate azioni risarcitorie.
5.2.- D'altronde, il legislatore gode di ampia discrezionalità non solo nel qualificare l'inerzia estintiva delle situazioni giuridiche soggettive in termini di decadenza o di prescrizione e nel determinare il tempo necessario alla rispettiva maturazione, ma anche nel combinare termini di prescrizione e di decadenza.
5.2.1.- Per quanto concerne, in particolare, il diritto di azione, la scelta della natura, decadenziale o prescrizionale, e della stessa durata del termine cui condizionare l'esercizio di un diritto in giudizio è riconducibile alla discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali ed è calibrata secondo le speciali caratteristiche di ogni singolo procedimento (sentenza n. 94 del 2017).
Per costante giurisprudenza di questa Corte, tale discrezionalità incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (tra le più recenti, sentenze n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023), il quale è da intendersi valicato «ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire» (sentenza n. 76 del 2025; in senso conforme, ex aliis, sentenze n. 271 del 2019, n. 121 e n. 44 del 2016), in quanto vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (ex aliis, sentenze n. 13 del 2022, n. 230 e n. 148 del 2021, n. 271 del 2019).
5.3.- La non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di sottoporre a decadenza l'esercizio del diritto di azione dipende anzitutto dalla congruità del termine, la quale va apprezzata non solo rispetto all'interesse di chi è onerato della sua osservanza, ma anche in rapporto alla funzione a esso assegnata nell'ordinamento giuridico (sentenze n. 161 del 2000, n. 234 del 1974, n. 114 del 1972).
In ogni caso, l'introduzione di un termine di decadenza non deve mai tradursi nella esclusione della effettiva possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, rendendola meramente apparente o, comunque, estremamente difficile (ancora, sentenze n. 94 del 2017, n. 161 del 2000, n. 234 del 1974; per l'affermazione del principio in materia di prescrizione, sentenza n. 32 del 2024).
5.4.- Tanto precisato, il termine per la impugnazione, anche in via stragiudiziale, del licenziamento previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 - sul quale si appuntano le censure del giudice a quo -, è parte di uno speciale regime decadenziale che, come già evidenziato, trova in via generale giustificazione nelle esigenze, ritenute dal legislatore meritevoli di tutela, di fare emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale (sentenza n. 212 del 2020), di tutelare l'affidamento che il datore di lavoro ripone sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento e di garantire la speditezza del giudizio promosso per accertarne la legittimità (sentenza n. 155 del 2014).
In definitiva, esso è volto a «contemperare il diritto del prestatore all'eliminazione delle conseguenze dell'illegittimo recesso datoriale con l'interesse del datore di lavoro alla continuità e stabilità della gestione dell'impresa [...] subordinando la tutela del lavoratore alla circostanza che questi tempestivamente si attivi, sì che in mancanza di pronta iniziativa del prestatore il diritto di questo alla legittimità degli atti datoriali di gestione recede a fronte della stabilizzazione delle conseguenze del licenziamento» (Cass., sez. un. civ., n. 8830 del 2010).
Lo stesso termine ex art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 può ritenersi normalmente adeguato al tipo di atto il cui compimento è richiesto a pena di decadenza, potendo il lavoratore validamente provvedervi mediante invio al datore di lavoro, anche per mezzo di un'associazione sindacale, di una comunicazione scritta - per la quale non è richiesta una formulazione specifica (ex aliis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 aprile 2021, n. 10883) - in cui si limiti a manifestare la sua volontà di impugnare il licenziamento.
5.5.- Tale onere procedurale può, tuttavia, tradursi in un vero e proprio ostacolo all'accesso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione del recesso, o comunque in pendenza del termine di decadenza in esame, l'interessato, in ragione di una patologia o di altra causa perturbatrice a lui non imputabile, si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Nelle situazioni indicate il lavoratore, specie se versi in condizione di marginalizzazione sociale e non possa contare sull'aiuto di familiari, non essendo in grado di comprendere la portata dell'atto datoriale e di determinarsi in merito alle iniziative da assumere, viene a trovarsi nella impossibilità - se lo stato di perturbazione psichica perdura per l'intero termine - o comunque nella oggettiva difficoltà - se l'alterazione si verifica in pendenza di esso, così incidendo sulla possibilità di fruirne per intero -, di scongiurare, attraverso una valida e tempestiva impugnazione stragiudiziale, la consumazione del diritto alla tutela giurisdizionale.
In definitiva, per il lavoratore colpito da incapacità naturale, l'onere di impugnazione in esame può comportare la perdita definitiva della possibilità di contrastare l'iniziativa datoriale e, dunque, di «"[...] non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente" (sentenza n. 60 del 1991, punto 9 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 194 del 2018): ciò in aperto contrasto con il diritto al lavoro garantito dall'art. 4, primo comma, Cost. - diritto fondamentale (ancora, sentenza n. 194 del 2018) e fondamento dell'ordinamento repubblicano (sentenze n. 183 e n. 125 del 2022) - e con la «tutela» del lavoro «in tutte le sue forme e applicazioni» riconosciuta dall'art. 35, primo comma, Cost.
Nella fattispecie in scrutinio, la garanzia di tali diritti, che rinviene nella tutela giurisdizionale sancita dall'art. 24 Cost. un indispensabile strumento di realizzazione, risulta, infatti, irreparabilmente compromessa, non sussistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l'interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l'illegittimità dell'atto espulsivo.
5.5.1.- Il vulnus ai suddetti precetti costituzionali emerge con particolare evidenza nell'ipotesi, oggetto del giudizio a quo, in cui l'interessata assume che la propria incapacità naturale sia stata all'origine della stessa condotta sanzionata con il licenziamento non tempestivamente impugnato e abbia, al contempo, impedito al lavoratore di esercitare il diritto di difesa in sede disciplinare, fornendo le sue giustificazioni nel termine di cui all'art. 7, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). È, infatti, significativo che la stessa Corte di cassazione abbia affermato che il lavoratore che intenda contestare la legittimità della sanzione datoriale per essersi trovato nell'impossibilità di esercitare il diritto di difesa in sede disciplinare a causa di una minorata capacità di intendere e di volere, può far valere tale impedimento attraverso l'impugnazione giudiziale, dimostrando, appunto, di essersi trovato, nella pendenza del suddetto termine, in stato di incapacità naturale (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 maggio 2001, n. 7374).
5.6.- L'esigenza di effettività delle evocate garanzie costituzionali è resa, nella specie, ancora più pressante dalla condizione di particolare vulnerabilità in cui versa il titolare degli interessi incisi dalla scelta legislativa censurata.
5.6.1.- L'ordinamento interviene con varie misure a tutelare la persona che, a causa di una perturbazione, anche temporanea, della propria sfera intellettiva e volitiva, non sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti, né di autodeterminarsi liberamente e coscientemente per tutelare i propri interessi.
L'incapacità di intendere e di volere costituisce, anzitutto, causa di annullamento degli atti negoziali posti in essere dal soggetto incapace (art. 428, commi primo e secondo, cod. civ., per i negozi unilaterali e i contratti; art. 120 cod. civ., per il matrimonio; art. 591, secondo comma, numero 3, cod. civ., per il testamento; art. 775 cod. civ., per la donazione).
Questa Corte ha, in proposito, osservato come la nozione di incapacità naturale sia «estremamente lata», in quanto «potrebbe riguardare non solo una condizione transitoria del soggetto, presente al momento dell'atto, ma potrebbe essere anche indice di uno stato di infermità (artt. 404, 414 e 415 cod. civ.) o di una "menomazione fisica o psichica" (art. 404 cod. civ.), che necessitano di tutele preventive», così potendo essere oggetto di valutazione nei procedimenti di interdizione o di inabilitazione ovvero di amministrazione di sostegno (sentenza n. 168 del 2023).
5.6.2.- Sul versante processuale, diversi sono gli istituti diretti a evitare che l'incapacità naturale, sia essa momentanea o persistente, possa di per sé sola riverberarsi sulla capacità processuale dell'interessato. Si tratta di disposizioni, come gli artt. 70, terzo comma, 71 e 473-bis.14 cod. proc. civ. e l'art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), essenzialmente intese alla protezione processuale dell'incapace e a garantire allo stesso un giusto processo (ancora, sentenza n. 168 del 2023).
5.7.- Nell'ordinamento non è, tuttavia, rinvenibile una specifica misura a presidio del lavoratore che, a causa di una pur temporanea alterazione psichica, non assolva tempestivamente l'onere della previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento intimatogli, così perdendo la possibilità di contestarlo in sede giurisdizionale.
Poiché la persona in condizione di incapacità naturale non può contare sulle misure di protezione accordate dall'ordinamento all'incapace legale - e, in particolare, sulla rappresentanza o sull'assistenza previste per l'interdetto, l'inabilitato e il beneficiario dell'amministrazione di sostegno -, nella situazione in esame, l'effettività della difesa del lavoratore licenziato potrebbe essere vanificata dalla intempestiva attivazione dei soggetti - come gli assistenti sociali e gli operatori del Servizio sanitario nazionale - ai quali la legge affida la tutela delle persone incapaci anche attraverso la sollecitazione o il diretto promovimento dei procedimenti di protezione (come l'amministrazione di sostegno) e della correlata nomina, anche in via d'urgenza, di un rappresentante provvisorio dell'incapace.
Il termine di sessanta giorni imposto dalla previsione in scrutinio può rivelarsi troppo breve affinché la condizione di minorata capacità del lavoratore giunga a conoscenza delle istituzioni preposte alla protezione delle persone in condizione di fragilità in tempo utile perché possano essere attivate misure idonee a scongiurare la consumazione del diritto di impugnazione.
In tale ipotesi, la persona colpita da incapacità di intendere e di volere non può essere privata, a causa della sua condizione, del diritto di agire e di difendersi in giudizio.
Va, infine, ribadito che è compito della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, Cost., rimuovere gli ostacoli materiali che, per le persone affette da fragilità, si frappongono al godimento effettivo dei diritti costituzionali (ex aliis, sentenze n. 25, n. 3 e n. 1 del 2025, n. 258 del 2017 e n. 163 del 1993).
5.8.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non considera l'incompatibilità del rigido meccanismo decadenziale prescritto con una condizione soggettiva, come l'incapacità di intendere e di volere, che impedisce all'interessato di scongiurare le gravi conseguenze derivanti dal maturare della causa estintiva, si palesa manifestamente irragionevole, ponendosi in contrasto con l'art. 3 Cost. e ledendo, al contempo, il diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e alla sua tutela (art. 35, primo comma, Cost.) anche giurisdizionale (art. 24, prima comma, Cost.).
5.9.- L'accertato vulnus costituzionale non può, tuttavia, essere sanato nei termini indicati dalla Corte rimettente e, cioè, attraverso una pronuncia additiva che inserisca nella disposizione censurata una causa di differimento della decorrenza del termine per l'impugnazione stragiudiziale dalla data della ricezione del licenziamento a quella del riacquisto, da parte dell'interessato, della piena capacità di intendere e di volere.
5.9.1.- È pur vero che questa Corte ha già sperimentato una simile tecnica decisoria (sentenze n. 133 del 2021, n. 322 del 2011, n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985), anche con specifico riferimento all'incapacità naturale (in particolare, sentenza n. 322 del 2011); ma essa se ne è avvalsa in relazione a diritti, come quello di azione di disconoscimento della paternità e di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, la cui natura personalissima ha consentito eccezionalmente di differire sine die la decorrenza del termine di decadenza.
5.10.- Di regola, però, una indefettibile esigenza di tutela della certezza dei rapporti giuridici impone che i termini decadenziali decorrano per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive e oggettive dalle quali sia dipeso l'inutile maturare della causa estintiva, e salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, dal momento che il fondamento della decadenza coincide con l'esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 11 febbraio 2010, n. 3078).
5.10.1.- Anche questa Corte ha sottolineato che l'istituto della decadenza risponde alla «necessità obiettiva che particolari atti siano compiuti in un ristretto tempo, specie nell'interesse di altri soggetti, e quindi a prescindere dalle circostanze soggettive di chi deve compiere quegli atti» (sentenza n. 14 del 1994), mentre, per la prescrizione, gli artt. 2941 e seguenti cod. civ. ammettono - sia pure mediante previsioni connotate da eccezionalità (sentenza n. 86 del 2025) - la sospensione del decorso del termine in ragione di diverse circostanze che rendono difficile l'esercizio del diritto.
5.11.- La individuazione delle ipotesi, eccezionali e tassative, in cui è possibile tenere conto di circostanze che rendono eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto sottoposto a decadenza postula il contemperamento tra i diversi interessi, individuali e superindividuali, cui l'ordinamento, nel prevedere le singole ipotesi decadenziali, accorda protezione e l'esigenza del soggetto gravato dell'onere di sollecito compimento dell'atto richiesto dalla legge di conservare il suo diritto.
La pronuncia auspicata dal giudice a quo finirebbe per introdurre un elemento di aleatorietà in un regime decadenziale orientato da specifiche esigenze di celerità e di sicurezza dei rapporti giuridici. Dal differimento potrebbe, infatti, derivare una dilatazione indefinita del termine per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento - e, di riflesso, di quella giudiziale -, in contrasto con la eminente finalità di tutela dell'affidamento sulla definitiva stabilizzazione del recesso datoriale che informa la previsione censurata.
5.12.- Spetta, pertanto, a questa Corte individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, non essendo vincolata dalla formulazione del petitum nell'ordinanza di rimessione, che ha solo la funzione di indicare il contenuto e il verso delle censure (sentenze n. 83 e n. 53 del 2025, n. 128, n. 90, n. 46 e n. 12 del 2024, n. 221 del 2023).
5.12.1.- Alle riscontrate violazioni costituzionali deve porsi rimedio, senza stravolgere la funzione della norma censurata con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese, sollevando dall'onere della previa impugnazione stragiudiziale il lavoratore che, a causa di un perturbamento, anche di tipo transitorio, delle proprie facoltà cognitive o volitive, non sia in grado di comprendere l'effettiva portata dell'atto espulsivo e, quindi, di attivarsi tempestivamente, così incorrendo nella perdita irrimediabile della possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale.
La riconduzione a legittimità della disposizione censurata deve, pertanto, essere assicurata escludendo, nella situazione suddetta, l'operatività dell'onere della previa impugnazione stragiudiziale, pur mantenendo fermo lo sbarramento finale costituito dal complessivo termine massimo per l'impugnazione giudiziale in misura di duecentoquaranta giorni, dato dalla somma del termine per la impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma dell'art. 6, pari a sessanta giorni, e del successivo termine per il deposito del ricorso, anche cautelare (sentenza n. 212 del 2020), o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, stabilito dal secondo comma in centottanta giorni.
In questo modo, da un lato, si evita di pretendere dal lavoratore colpito da incapacità naturale di manifestare la volontà di reagire all'atto espulsivo entro un termine - quello di cui al primo comma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - che, per la sua ridotta estensione, potrebbe risultare insufficiente a consentire sia che la condizione patologica all'origine dell'incapacità regredisca e l'interessato recuperi le proprie facoltà intellettive e volitive, sia che le istituzioni deputate alla cura e alla protezione, anche giuridica, delle persone incapaci possano intervenire. Dall'altro lato, resta, comunque, garantita l'esigenza di certezza e di celerità che informa la disciplina in scrutinio, dal momento che la stabilizzazione degli effetti dell'atto datoriale interviene entro lo stesso termine - fisso e predeterminato - di cui, in caso di impugnazione extragiudiziale tempestiva, deve comunque essere atteso il decorso per poter ritenere il licenziamento non più contestabile.
6.- L'art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.
6.1.- Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.