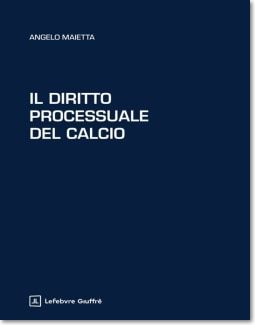Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 21 novembre 2017, n. 27623
Presidente: Mazzacane - Estensore: Lombardo
FATTI DI CAUSA
1. S.T., giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige/Suedtirol, fu tratto in arresto a Praga il 31 gennaio 2001, con l'accusa di abusi sessuali su minori.
La notizia apparve sugli organi di stampa trentini e il locale Ordine dei Giornalisti provvide a sospenderlo dal relativo Albo professionale.
Il processo penale fu definito con sentenza del Tribunale di Praga del 29 giugno 2001, che assolvette il S. dai più gravi reati di violenza sessuale su minore e prostituzione minorile, ma lo condannò al pagamento di una pena pecuniaria per il reato (previsto dall'ordinamento penale ceco) di "messa in pericolo dell'educazione dei minorenni".
Rientrato in Italia, il predetto diramò un comunicato col quale ebbe a dichiarare che il Tribunale di Praga lo aveva assolto dai reati ascrittigli; e l'Ordine territoriale provvide a revocare il provvedimento cautelare di sospensione dall'Albo.
A seguito della acquisizione di copia della sentenza del Tribunale ceco, il S. fu sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige/Suedtirol, che gli irrogò la sanzione della radiazione dall'Albo per due distinti illeciti disciplinari: 1) la violazione del decoro e della dignità professionale, a seguito delle condotte accertate dal Tribunale di Praga; 2) l'aver tenuto una condotta non conforme ai principi deontologici per avere, nella veste di giornalista pubblicista, riferito in un comunicato stampa - contrariamente al vero - di essere stato assolto dall'autorità giudiziaria ceca.
Impugnata la delibera dell'Ordine professionale locale dinanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, la sanzione disciplinare fu confermata.
2. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 18 marzo 2014, il S. chiese al Tribunale di Trento l'annullamento delle delibere emesse dagli organi disciplinari locale e nazionale; ma il Tribunale adito respinse la domanda.
Proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Trento, ai sensi degli artt. 38 della l. n. 69 del 1963 e succ. modif. e 27 del d.lgs. n. 150/2011, la Corte territoriale adita sostituì la sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo dei Giornalisti con quella della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un anno e compensò per un terzo le spese dei due gradi del giudizio.
3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre S.T. sulla base di sei motivi.
Resiste con controricorso l'Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige/Suedtirol.
Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi di ricorso, che - stante la loro stretta connessione - vanno trattati unitariamente, si deduce:
1) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360, n. 5, c.p.c.) in ordine alla effettiva corrispondenza del testo della sentenza penale di condanna acquisito alla sentenza resa dal Tribunale di Praga;
2) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360, n. 5, c.p.c.) circa la legittimità delle modalità di acquisizione della sentenza del Tribunale di Praga;
3) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360, n. 5, c.p.c.) in relazione alla traduzione della sentenza straniera utilizzata ai fini della decisione.
I motivi sono inammissibili.
Invero, in forza del nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. n. 83/2012 (convertito nella l. n. 134/2012) e applicabile ratione temporis (l'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83/2012 prevede, infatti, l'applicazione del nuovo testo relativamente alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012; e la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17 settembre 2012), il vizio di motivazione della sentenza non costituisce più un motivo per cui è ammesso il ricorso per cassazione.
Come hanno statuito le Sezioni unite di questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. un., n. 8053 del 7 aprile 2014).
Nella specie, non sussiste né la mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, né l'apparenza o la manifesta illogicità della motivazione, cosicché i dedotti vizi motivazionali risultano inammissibili.
A tale rilievo di carattere generale, vanno aggiunte le seguenti osservazioni.
Il primo motivo risulta inammissibile anche per genericità e difetto di autosufficienza. Invero, la Corte di Appello ha spiegato che la contestazione della corrispondenza tra il testo della sentenza penale acquisto dagli organi disciplinari e quello della sentenza resa dal Tribunale di Praga costituisce una censura nuova, proposta per la prima volta in grado di appello. A fronte di tale motivazione, era onere del ricorrente quello di indicare e trascrivere il punto in cui la censura sarebbe stata invece dedotta in primo grado. Non avendo il ricorrente assolto tale onere, il motivo è inammissibile.
Inammissibile per genericità è anche la doglianza relativa alla omessa integrazione istruttoria, non avendo il ricorrente precisato quale specifica attività istruttoria aveva chiesto ai giudici di merito.
Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, poi, anche perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte di Appello ha spiegato che, in sede di procedimento disciplinare, l'incolpato non contestò mai che il testo della sentenza penale acquisito in lingua originale corrispondesse a quello della sentenza del Tribunale di Praga e che - anzi - fu lo stesso incolpato a produrre la traduzione in lingua italiana della sentenza straniera poi utilizzata dagli organi disciplinari ai fini della decisione (p. 22 della sentenza impugnata).
Il ricorrente non ha sottoposto a critica tali argomenti, costituenti la ratio decidendi della sentenza impugnata, cosicché le censure sul punto risultano inammissibili.
2. Anche il quarto motivo, col quale si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360, n. 5, c.p.c.) per avere la Corte territoriale irrogato sanzioni disciplinari (in relazione alle vicende oggetto di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria ceca) pur in assenza di prove, è inammissibile.
Invero, a parte l'inammissibilità del motivo - per quanto dianzi detto - in relazione al dedotto vizio di motivazione, il motivo risulta inammissibile perché si risolve in una critica di merito circa la valutazione dei fatti e degli elementi di prova risultanti dalla acquisita sentenza del Tribunale ceco.
Né occorre che i fatti contestati quali illeciti disciplinari costituiscano reato secondo la legge italiana. L'irrogazione di sanzioni disciplinari, infatti, prescinde dalla commissione di reati, in quanto, ai sensi dell'art. 48 della l. n. 69/1963, costituiscono illeciti disciplinari le condotte dell'iscritto che risultano «non conformi al decoro e alla dignità professionali».
3. Col quinto motivo, si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360, n. 5, c.p.c.) circa la sussistenza della prova del secondo illecito contestato, relativo al comunicato stampa.
Anche questo motivo è inammissibile per il fatto di dedurre un vizio - quello di motivazione - non più previsto dalla legge.
Il motivo, in ogni caso, è inammissibile, anche perché si risolve in una censura di merito relativa all'accertamento dei fatti (i giudici di merito hanno accertato che il ricorrente, nel comunicato-stampa, spendendo la qualità di giornalista pubblicista, riferì fatti non veri, facendo credere che il Tribunale di Praga lo aveva assolto e che la multa gli era stata irrogata per coprire i costi del procedimento), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, laddove - come nella specie - la motivazione della sentenza impugnata risulta non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. un., n. 8053 del 7 aprile 2014).
4. Col sesto motivo, si deduce, infine, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360, n. 5, c.p.c.) circa la tipologia e la durata della sanzione.
Anche questo motivo è inammissibile, sia perché si deduce un vizio della sentenza impugnata non più consentito dall'art. 360 c.p.c., sia - in ogni caso - perché la doglianza si riduce ad una censura di merito relativa alla scelta e alla quantificazione della sanzione, profili del giudizio che sono insindacabili in sede di legittimità, in presenza - come nella specie - di una motivazione della sentenza impugnata (p. 31) non apparente né manifestamente illogica, ma anzi ampia e logicamente argomentata, in forza della quale peraltro l'incolpato ha ottenuto la sostituzione della sanzione precedentemente irrogata (la radiazione dall'albo) con la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un anno.
5. In definitiva, risultando inammissibili tutti i motivi di ricorso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
6. Ritiene la Corte che sussistano le condizioni di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., per condannare la parte soccombente al pagamento di un'ulteriore somma in favore del controricorrente.
Il Collegio ritiene di doversi soffermare sull'istituto previsto dal terzo comma all'art. 96 c.p.c., onde coglierne la esatta portata giuridica.
6.1. Com'è noto, con l'art. 96 c.p.c. (intitolato "Responsabilità aggravata") il codificatore ha previsto - nei primi due commi che originariamente componevano la disposizione - due fattispecie di responsabilità processuale della parte soccombente; a tali tradizionali figure, il legislatore del 2009 ha aggiunto un'ulteriore fattispecie, prevista dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dall'art. 45, comma 12, della l. n. 69 del 2009.
Orbene, la fattispecie di cui al novello terzo comma dell'art. 96 c.p.c., sebbene segua nel testo della disposizione e sotto il medesimo titolo le due originarie forme di "responsabilità aggravata", in realtà differisce del tutto da queste ultime per presupposti e per funzione.
I primi due commi, infatti, configurano due fattispecie di responsabilità di natura risarcitoria, che si inquadrano concettualmente nel genus della responsabilità aquiliana o per fatti illeciti.
In particolare, il primo comma dell'art. 96 c.p.c. detta la "regola generale" secondo cui «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza»; il secondo comma prevede poi alcune "ipotesi speciali" di responsabilità processuale, che il codificatore ha ritenuto opportuno disciplinare separatamente per il fatto di riguardare talune condotte processuali (ma non solo) che, per la loro particolare "aggressività", sono potenzialmente in grado di cagionare più grave danno a chi li subisce, sanzionandole più severamente col richiedere, ai fini del risarcimento del danno, non più che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave, ma solo che abbia agito «senza la comune prudenza» («Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza»).
Si tratta di due figurae iuris che assolvono indubbiamente funzione risarcitoria e che si inquadrano nella responsabilità extracontrattuale per violazione del precetto generale del neminem laedere; esse, attenendo alla condotta processuale della parte (soccombente), costituiscono "figure speciali" della più generale fattispecie della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c.c.
Coerentemente con la loro natura risarcitoria, le figure di responsabilità aggravata previste nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. sono ancorate alla domanda della parte interessata, essendo esclusa la pronuncia d'ufficio; inoltre, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo" della fattispecie.
Invero, per poter ottenere il risarcimento del danno, la parte vittoriosa deve, da un lato, allegare e provare l'esistenza e l'entità di un danno concreto ed effettivo patito nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso; dall'altro, allegare e provare la sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, costituito, per la figura di cui al primo comma, dalla "mala fede" o dalla "colpa grave" e, per la fattispecie di cui al secondo comma, dalla mancanza di "normale prudenza".
Si comprende bene come, in presenza di fattispecie di responsabilità aggravata così costruite, che impongono alla parte vittoriosa oneri probatori così gravosi, le figure di responsabilità aggravata previste nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. abbiano avuto e abbiano - nella pratica - un'applicazione molto limitata.
6.2. È avvenuto così che il legislatore del 2006, nel quadro del potenziamento della funzione nomofilattica della Corte di cassazione e nel tentativo di contenere il numero dei ricorsi, è intervenuto col d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, aggiungendo all'art. 385 c.p.c. un quarto comma, che è venuto a configurare una nuova forma di responsabilità aggravata della parte soccombente, sia pure limitata al giudizio di cassazione.
Stabilisce l'art. 385, quarto comma, c.p.c., che «Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave».
La ratio della norma è quella di agire sulla leva economica per scoraggiare i litiganti ad accedere alla Corte suprema con ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. La norma, però, configura una fattispecie di responsabilità processuale che nulla ha a che fare con le fattispecie previste dall'art. 96, primo e secondo comma, c.p.c.
Decisivo, in tal senso, è il rilievo che la condanna ai sensi dell'art. 385, quarto comma, c.p.c. non richiede la sussistenza di un danno patito dalla parte vittoriosa e dipendente dalla illecita condotta processuale della parte soccombente; coerentemente, la pronunzia di condanna non è subordinata alla domanda della parte, ma può essere pronunciata d'ufficio dal giudice.
Tali elementi caratterizzanti la fattispecie giuridica di cui all'art. 385, quarto comma, c.p.c. valgono ad escludere che essa possa avere "funzione risarcitoria" del danno patito dalla parte vittoriosa e che possa essere inquadrata - quale species ad genus - nella più generale figura della responsabilità aquiliana.
In realtà, la nuova figura di responsabilità processuale, prevista dall'art. 385, quarto comma, c.p.c., ha "funzione sanzionatoria" dell'abuso del processo perpetrato dalla parte soccombente nel giudizio di legittimità. La condanna irrogata dal giudice, ex art. 385, quarto comma, c.p.c., ha natura di "sanzione di ordine pubblico", da irrogare nell'interesse generale, allo scopo di reprimere l'abuso del ricorso per cassazione. Si tratta di una "sanzione processuale" per l'abuso del giudizio di legittimità.
Inequivoca conferma di ciò si ricava dal fatto che l'entità della sanzione da irrogare non va rapportata, come è previsto nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c., all'entità del danno da risarcire (che può essere del tutto insussistente), ma è indipendente da esso; la legge non parla più di liquidazione del danno (come nell'art. 96, primo e secondo comma), ma di pagamento di una «somma equitativamente determinata» (purché «non superiore al doppio dei massimi tariffari»), indipendente dalla sussistenza e dall'entità di un danno patito dalla parte vittoriosa.
L'unico elemento in comune, tra la fattispecie di cui all'art. 385, quarto comma, c.p.c. e quelle di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., è costituito dall'elemento "soggettivo" richiesto dalla legge per integrare la fattispecie: l'art. 385, ultimo comma, c.p.c., continua a pretendere - come il primo comma dell'art. 96 c.p.c. - che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio («ha proposto il ricorso o vi ha resistito») almeno «con colpa grave» (letteralmente «anche solo con colpa grave»), è necessaria, cioè, la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con "colpa grave", intendendosi con tale formula - come ha precisato la giurisprudenza di questa Corte - la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione (Cass., Sez. un., n. 25831 dell'11 dicembre 2007; Sez. 3, n. 22812 del 7 ottobre 2013).
La funzione di sanzione di ordine pubblico della figura di cui al quarto comma dell'art. 385 c.p.c. non è, d'altra parte, contraddetta dal fatto che "la somma equitativamente determinata" deve essere corrisposta, non allo Stato (come potrebbe apparire - in astratto - più coerente), ma alla controparte, essendo questa una scelta del legislatore adottata per sollevare gli uffici pubblici dagli oneri di complesse esazioni e per assicurare una più sicura e tempestiva riscossione della sanzione sulla spinta dell'interesse della parte vittoriosa.
Nonostante la semplificazione della fattispecie (rispetto a quanto previsto nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c.), la disposizione dell'art. 385 quarto comma c.p.c. è rimasta praticamente inapplicata, se non in casi del tutto marginali: non solo perché è stata accompagnata da un diritto transitorio che - senza tener conto del fatto che la disposizione era dettata specificamente per il giudizio di cassazione - ne ha retrodatato l'applicabilità alle sole cause iniziate in primo grado dopo la data dell'entrata in vigore della l. n. 40 del 2006; non solo perché ha avuto vita assai breve, essendo stata abrogata dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009 (ma sulla efficacia intertemporale della norma, v. Cass., Sez. 2, n. 21550 del 2016, non massimata); ma anche perché la fattispecie configurata dall'art. 385, quarto comma, c.p.c. ha continuato a richiedere l'accertamento della "colpa grave" della parte soccombente, ha preteso cioè dal giudice un giudizio in termini di negligenza e di colposità della condotta della parte e - per essa - del suo difensore, non sempre agevole da formulare.
6.3. A fronte delle difficoltà applicative riscontratesi, il legislatore è intervenuto ancora una volta, configurando, col novello terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45, comma 12), una nuova figura di responsabilità aggravata.
Con la nuova disposizione, il legislatore del 2009 ha inteso generalizzare ed estendere ad ogni grado di giudizio la possibilità per il giudice di reprimere l'abuso del processo con una condanna di tipo sanzionatorio in favore della parte vittoriosa; coerentemente, ha abrogato il quarto comma dell'art. 385 c.p.c., previsto per il solo giudizio di cassazione. Tuttavia, come si vedrà, la nuova norma, semplifica ulteriormente la fattispecie, rispetto a quanto previsto dall'art. 385, quarto comma, c.p.c., rendendone più agevole l'applicazione.
Certamente, la figura di responsabilità processuale configurata dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. si muove nel solco della figura - che ne è stata progenitrice - prevista dall'art. 385, quarto comma, c.p.c.
La disposizione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. prevede, infatti, che «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».
Come la fattispecie di cui all'art. 385, ultimo comma, c.p.c., anche la fattispecie di cui all'art. 96, terzo comma, è una figura iuris evidentemente estranea alla responsabilità aquiliana.
La norma - come ha rilevato la dottrina più avvertita - configura una "sanzione di ordine pubblico", dettata, con finalità di deflazione del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata.
Con l'istituto previsto nell'art. 96, terzo comma, c.p.c., il legislatore ha inteso affidare al giudice uno strumento per reprimere, nell'interesse generale della collettività, il c.d. "abuso del processo"; abuso che ricorre quando lo strumento processuale viene piegato a finalità devianti rispetto alla "tutela dei diritti e degli interessi legittimi" per il quale l'art. 24, primo comma, Cost. garantisce il ricorso al giudice.
Questa visione dell'istituto, d'altra parte, è stata fatta propria dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 152 del 2016 - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - ha rilevato che la previsione di tale disposizione ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso; ciò - secondo il giudice delle leggi - è confermato, sul piano testuale, dal riferimento al "pagamento di una somma", che segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni" di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, e dall'adottabilità della condanna "anche d'ufficio", che la sottrae all'impulso di parte e ne attesta la finalizzazione alla tutela di un interesse trascendente quello della parte stessa e colorato di connotati pubblicistici.
La stessa Corte costituzionale non ha mancato di osservare che la motivazione che ha indotto il legislatore a porre a favore della controparte la condanna del soccombente è plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività ed una più incisiva efficacia deterrente allo strumento deflattivo, sul verosimile presupposto che la parte vittoriosa possa provvedere alla riscossione in tempi e con oneri inferiori a quelli gravanti su un soggetto pubblico; osservando poi che l'istituto così modulato è suscettibile di rispondere anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata da un'ingiustificata chiamata in giudizio) nelle non infrequenti ipotesi in cui sia per essa difficile provare, ai fini del risarcimento per lite temeraria, l'an o il quantum del danno subito.
Va tuttavia osservato come l'art. 96, terzo comma, c.p.c. non abbia recepito del tutto il testo del precedente art. 385, quarto comma, c.p.c.
Vi è, infatti, un forte ed evidente "elemento di discontinuità" tra il testo dell'art. 96, terzo comma, e quello dell'art. 385, quarto comma, c.p.c.
Tale elemento di discontinuità consiste nel fatto che la fattispecie di cui all'art. 96, terzo comma, non prevede più alcun elemento soggettivo, quale suo elemento costitutivo; non è più richiesto cioè, ai fini della condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio "con colpa grave".
Certo, non è mancato in dottrina chi ha sostenuto che presupposti per l'applicazione del nuovo istituto sarebbero sempre la "mala fede" o la "colpa grave" previsti dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. (in questo senso, in giurisprudenza, Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del 22 febbraio 2016); ma si tratta di una interpretazione manipolativa della norma, contrastante con i dati testuali.
Innanzitutto, l'idea della sopravvivenza, nella nuova fattispecie, dell'elemento soggettivo previsto dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., appare smentita dalla inequivoca volontà del legislatore di sopprimere qualsiasi riferimento ai profili soggettivi di responsabilità. Sul punto, va rilevato che l'elemento soggettivo della "colpa grave" era transitato - col d.lgs. n. 40 del 2006 - dall'art. 96, primo comma, all'art. 385, quarto comma, c.p.c. Il fatto che il legislatore del 2009, nel ricollocare il testo dell'art. 385, quarto comma, nell'ambito dell'art. 96 c.p.c., non abbia replicato l'elemento della "colpa grave" ivi previsto, non può essere ascritto ad una dimenticanza; costituisce, invece, una scelta legislativa adottata sulla via della semplificazione della fattispecie, allo scopo di favorirne una più agevole applicazione.
L'opinione richiamata, d'altra parte, è smentita dall'inciso «In ogni caso», che apre il testo della disposizione e che, secondo corretti canoni interpretativi, non può che significare "al di fuori di quanto previsto dai commi che precedono", ossia a prescindere dai presupposti richiesti dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.
La stessa previsione, contenuta nell'art. 96, terzo comma, c.p.c., che vuole che il giudice pronunci condanna «quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91», se da un lato implica che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese processuali e che non vi siano state ragioni per compensarle (neanche in parte), lascia intendere, dall'altro, l'applicabilità della disposizione a tutte le ipotesi di soccombenza, a prescindere da ogni valutazione circa la mala fede o la colpa grave della parte.
Infine, conferma della volontà del legislatore di non esigere più che il giudice accerti la "mala fede" o la "colpa grave" della parte soccombente si ricava dai lavori parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della legge; in particolare, dalla circostanza che, nel corso dei lavori parlamentari, l'incipit del nuovo terzo comma dell'art. 96 c.p.c. è stato modificato, laddove la precedente formulazione «Nei casi previsti dai commi precedenti, il giudice condanna altresì...» è stata sostituita dall'attuale «In ogni caso».
L'adozione di tale diverso testo attesta inequivocabilmente il mutamento della volontà del legislatore, che ha determinato, di fatto, un altrettanto evidente mutamento della struttura della fattispecie.
In definitiva, deve ritenersi che, col terzo comma dell'art. 96 c.p.c., il legislatore ha voluto configurare non già una fattispecie ancillare rispetto alle figure risarcitorie previste nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c., ma una figura di responsabilità indipendente e autonoma, che prevede una "sanzione di carattere pubblicistico", priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto "abuso" dello strumento processuale.
Il rafforzamento della repressione dell'abuso del processo si è manifestato nella scelta legislativa di sopprimere l'elemento soggettivo della fattispecie.
Il giudice, nell'applicare l'art. 96, terzo comma, c.p.c., non è più tenuto a svolgere complessi - quanto delicati - apprezzamenti sulla colposità e negligenza della condotta della parte e del suo difensore. Egli - invece - deve limitarsi a valutare "oggettivamente" la sussistenza di un "abuso del processo", quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto.
Naturalmente, dalla diversa natura delle fattispecie previste dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. rispetto alla fattispecie prevista dal terzo comma, discende - come ha ritenuto la dottrina - la cumulabilità delle condanne (quella al risarcimento del danno ex art. 96, primo o secondo comma; e quella al pagamento di "una somma equitativamente determinata" ex art. 96, terzo comma).
6.4. Il nuovo istituto affida al giudice il più ampio potere discrezionale, che - tuttavia - deve essere esercitato con la dovuta ragionevolezza.
Se non occorre che il giudice accerti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con "mala fede" o con "colpa grave" (art. 96, primo comma) o "senza la normale prudenza" (art. 92, secondo comma), ciò non significa - naturalmente - che la mera infondatezza della domanda o della difesa possa comportare responsabilità ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il fatto che non sia più necessario l'accertamento di un profilo soggettivo di responsabilità significa semplicemente che il giudice, nel verificare la sussistenza delle condizioni per pronunciare condanna ex art. 96, terzo comma, deve prescindere dal compiere alcuna indagine sulla sussistenza dell'elemento psicologico colposo: la condanna può essere pronunciata ogni volta che "oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.
Incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità). Tra costoro vi saranno certamente parti che hanno agito o resistito in giudizio con "mala fede" o con "colpa grave" o "senza la normale prudenza"; ma il giudizio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua "oggettività", e non all'atteggiamento psicologico - di mala fede o di negligenza più o meno grave - della parte.
La norma affida al giudice un'ampia discrezionalità anche nella determinazione dell'importo della sanzione.
A differenza di quanto stabiliva l'art. 385, quarto comma, c.p.c., a tenore del quale la "somma equitativamente determinata" dal giudice doveva mantenersi entro il limite del «doppio dei massimi tariffari» previsti per i compensi dei difensori, nessun limite quantitativo - né massimo, né minimo - è previsto dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Il giudice, tuttavia, nella determinazione della sanzione deve osservare il "criterio equitativo", potendo la sanzione essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, e non può - in nessun caso - superare il limite della "ragionevolezza" (in questo senso, Cass., Sez. 6-2, n. 21570 del 30 novembre 2012, che, in applicazione di tale principio, ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
6.5. Alla stregua dei principi sopra esposti, deve ritenersi che il ricorrente abbia abusato dello strumento processuale. Egli, infatti, dopo ben quattro gradi di giudizio (due amministrativi e due giurisdizionali), ha proposto ricorso alla Suprema Corte, formulando motivi palesemente inammissibili, in quanto non consentiti dalla legge e tali da sottoporre questioni di fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, per di più trascurando di considerare le ragioni, ampiamente argomentate, che la Corte territoriale aveva posto a giustificazione della decisione impugnata.
Tenuto conto del valore della controversia e dell'importo delle spese processuali, il Collegio ritiene di determinare equitativamente in un ulteriore importo pari a quello liquidato per le spese processuali la somma che il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., deve corrispondere al controricorrente Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige/Suedtirol.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento) di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dell'ulteriore somma di euro 2.700,00, (duemilasettecento) ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.